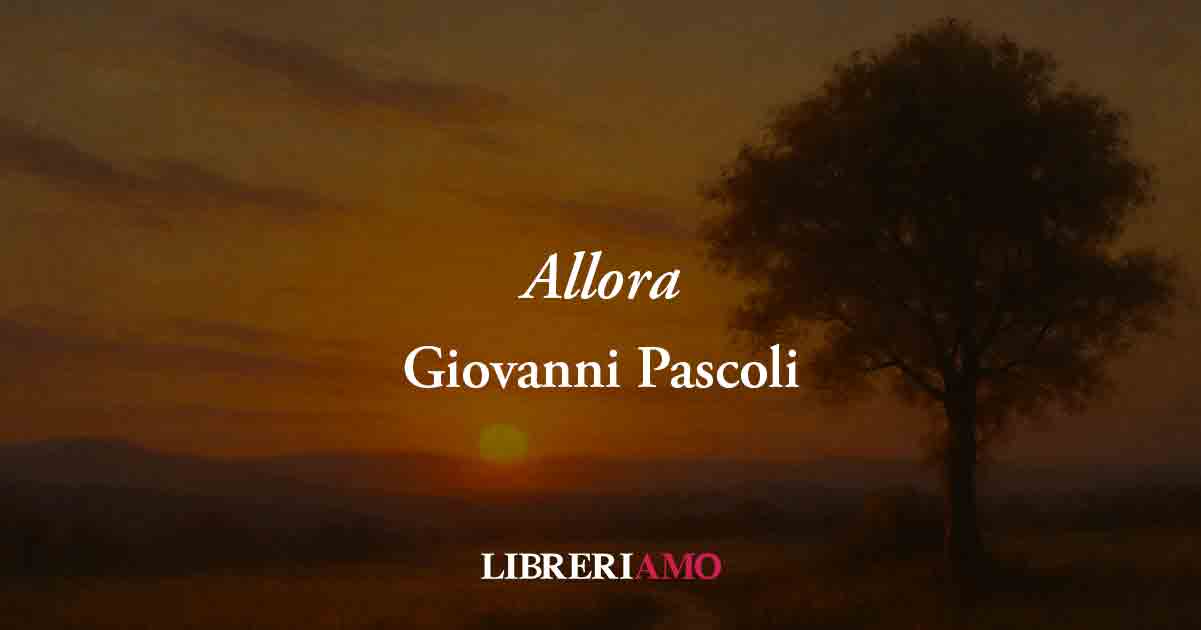Allora di Giovanni Pascoli non è solo il malinconico ricordo di un momento felice, ma una profonda riflessione sulla natura della memoria, sull’identità segnata dal trauma e sulla capacità della poesia di recuperare e dare un senso a ciò che è irrimediabilmente perduto.
Il poeta romagnolo si fa portavoce di tutti coloro che hanno vissuto un momento, un giorno della loro vita in cui tutto è cambiato in modo traumatico. Dopo quell’attimo non rimane che il ricordo dei giorni precedenti, in cui il tempo scorreva gioioso e l’esistenza era illuminata dalla felicità.
Allora fu pubblicata per la prima volta sulla rivista letteraria Il Marzocco del 23 febbraio 1896. Entrò successivamente nella sezione “Dall’alba al tramonto” della quarta edizione della raccolta di poesie Myricae di Giovanni Pascoli, pubblicata a Livorno da Raffaello Giusti Editore nel 1897.
Leggiamo questa stupenda poesia di Giovanni Pascoli per coglierne il profondo significato.
Allora di Giovanni Pascoli
Allora… in un tempo assai lunge
felice fui molto; non ora:
ma quanta dolcezza mi giunge
da tanta dolcezza d’allora!Quell’anno! per anni che poi
fuggirono, che fuggiranno,
non puoi, mio pensiero, non puoi,
portare con te, che quell’anno!Un giorno fu quello, ch’è senza
compagno, ch’è senza ritorno;
la vita fu vana parvenza
sì prima sì dopo quel giorno!Un punto!… così passeggero,
che in vero passò non raggiunto,
ma bello così, che molto ero
felice, felice, quel punto!
Il matrimonio di Ida e la fine del nido, l’altro trauma di Giovanni Pascoli
Dietro la dolce malinconia di Allora si nasconde una delle vicende più delicate e decisive della vita di Giovanni Pascoli, il matrimonio della sorella Ida celebrato il 30 settembre 1895, pochi mesi prima della pubblicazione della poesia avvenuta nel febbraio del 1896 e quindi scritta inevitabilmente ancora prima.
Per il poeta non fu un semplice distacco familiare ma la replica dolorosa di una perdita antica. Con la partenza di Ida il nido costruito con tanta fatica dopo la tragedia dell’infanzia crollò ancora una volta. La sorella che rappresentava affetto, stabilità e speranza lasciava la casa e con lei sembrava svanire ogni equilibrio possibile.
Già il fidanzamento di Ida iniziato nel 1894 con Salvatore Berti, divenne senza volerlo il segno di una nuova frattura. Giovanni viveva quei mesi in una tensione costante, diviso tra i successi letterari e un dolore profondo. Collaborava con De Bosis e D’Annunzio per Il Convito, ma dietro l’attività febbrile si nascondeva la paura di restare solo.
Nelle lettere alla sorella Maria si avverte una voce inquieta, piena di bisogno e di nostalgia. La chiama “sorellina adorata” e “compagnina”, le affida la promessa di una vita condivisa, di un legame che nulla potrà sciogliere. In queste parole si percepisce la nascita di un vincolo affettivo assoluto, insieme tenero e totalizzante.
Il giorno delle nozze Giovanni non si presenta né in chiesa né al ricevimento. Rimane chiuso nel suo studio, immerso nel silenzio, e affida il suo dolore alla scrittura del prosimetro Nelle nozze di Ida. Pochi giorni dopo lascia Bologna e si trasferisce con Maria e il cane Gulì a Castelvecchio di Barga. Quel luogo diventa il nuovo nido, un rifugio dove cercare pace e protezione dopo la perdita. Ma anche una casa chiusa, lontana dal mondo, in cui la vita si restringe all’interno di un rapporto esclusivo.
Nel 1896 Giovanni Pascoli tenta di rifarsi una vita e si fidanza con la cugina Imelde Morri. Questa volta è la reazione di Maria a diventare problematica. Per la prima volta teme di perdere il fratello, l’unico legame rimasto dopo la partenza di Ida. Maria prova una gelosia profonda e assoluta, che nasce dal timore di restare sola. Il 15 maggio alla stazione di Savignano lo convince a rompere il fidanzamento. Quell’incontro segna una svolta definitiva. Da quel giorno Pascoli rinuncia all’idea del matrimonio e accetta la vita chiusa del nido condiviso con Mariù.
Allora, pubblicata nel 1896, è il riflesso poetico di questo intreccio di perdite e dipendenze affettive. Il dolore per Ida, la paura dell’abbandono, la gelosia di Maria, tutto si fonde nei versi in cui il poeta contrappone il “tempo assai lunge” della memoria all’aridità del presente. La felicità si riduce a un istante lontano e luminoso, “quel punto” che la vita non potrà più restituire.
Con la partenza di Ida e la gelosia di Maria Pascoli comprende che ogni amore può trasformarsi in ferita. Allora diventa la sua risposta alla perdita, la confessione di un’anima che trova nella poesia l’unica forma di salvezza. In essa il dolore si trasfigura, la memoria diventa casa, e la parola poetica il solo nido che non può più crollare.
Una poesia che dà voce al trauma della perdita
Allora è una delle poesie più intime e dolorose di Giovanni Pascoli. Non racconta solo un ricordo felice, ma la lotta di un’anima contro il tempo e la perdita. Ogni verso nasce dal bisogno di trattenere ciò che il dolore ha portato via, di salvare almeno la memoria della felicità quando la vita non ne offre più traccia.
In questa poesia Pascoli non cerca conforto, ma continuità. Il passato diventa rifugio, la memoria si fa riflesso della vita che non può più vivere, e che sembra essere segnata per sempre.
Rievocare significa resistere. Nel mondo fragile e ferito del poeta, ricordare non è rimpiangere, è un atto di sopravvivenza esistenziale.
Allora evidenzia che la felicità si trasforma, sopravvivendo nel ricordo come luce custodita dentro la parola poetica. Da questa consapevolezza nasce la potenza dei suoi versi, che non piangono ciò che è perduto, ma lo trasfigurano in eternità.
Una poesia che riaccende la felicità vissuta prima del trauma
Giovanni Pascoli non celebra la memoria come scudo contro il dolore. Celebra il ricordo come possibilità di rivivere un lampo di felicità che non è durata ma che non muore. Quel punto rimane e nel pensarlo il poeta sente ancora il suo battito
Allora è una poesia che nasce da un ricordo e si chiude in un punto.
Non racconta un tempo felice durato ma un attimo sospeso, un frammento di vita che brilla e si spegne nel momento stesso in cui il poeta lo ritrova nella mente. La felicità di cui Pascoli parla non è una stagione, è un lampo che torna a illuminare per un istante la coscienza prima di svanire
In quell’attimo il dolore si ferma, la vita si ricompone, il mondo ritrova per un respiro la sua interezza di un tempo, poi tutto tace di nuovo
Il poeta non cerca di resistere alla perdita né di curarla. Si limita a riconoscere la forza del ricordo che per un momento gli fa rivivere la dolcezza di un passato remoto, quello prima della morte del padre
Quel ricordo è un soffio che non salva ma consola. È la prova tangibile che la felicità è esistita anche se solo per un punto, un istante infinitesimale in cui tutto era pieno, vivo, vero
Il significato dei versi di Giovanni Pascoli
L’”Allora” iniziale sospeso con cui la poesia si apre è un invito a tornare con la mente a un tempo che non è scomparso né consumato del tutto.
Quando scrive “felice fui molto, non ora”, Pascoli dichiara che la felicità non appartiene più al presente ma continua a esistere nel ricordo. Non è un lamento ma una constatazione serena.
Il passato non si può rivivere ma può ancora parlare
“Quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d’allora” è la frase chiave. La felicità non torna ma la memoria ne trasmette ancora il profumo e la luce
Nella seconda strofa il ricordo si restringe.
Non più un tempo indefinito ma “quell’anno”, l’anno che racchiude tutta la luce prima del dolore. Gli anni successivi “fuggirono” e quelli a venire “fuggiranno”, un tempo che scorre senza lasciare traccia.
Il poeta parla al suo pensiero come a un custode e gli chiede fedeltà
“Non puoi, mio pensiero, non puoi” è la preghiera che rivolge a se stesso. Il pensiero deve restare fermo su quell’anno soltanto, su quel ricordo che diventa l’unico luogo abitabile
Nella terza strofa il tempo si concentra ancora di più e l’anno diventa un giorno
Quel giorno “è senza compagno, è senza ritorno”. È il momento perfetto e irripetibile, la soglia che divide la vita felice da quella segnata dal trauma.
“La vita fu vana parvenza sì prima sì dopo quel giorno” rivela che tutto ciò che non appartiene a quell’attimo perde significato. Quel giorno contiene la pienezza del vivere e la sua fine
Nell’ultima strofa la memoria si riduce a un punto.
“Un punto così passeggero che in vero passò non raggiunto”. La felicità è un attimo che non si può afferrare ma proprio per questo resta pura
“Ma bello così che molto ero felice, felice, quel punto”. La ripetizione di felice è la voce di chi sente ancora la presenza di quell’attimo nel cuore. Il punto non ritorna ma continua a esistere come luce invisibile, come certezza che la vita ha avuto un momento di verità.
Allora non è la poesia del rimpianto ma della memoria viva. Giovanni Pascoli non chiede al tempo di restituire ciò che ha tolto. Gli basta sapere che quell’attimo di felicità è esistito davvero. Nel pensarlo il poeta ritrova un respiro di vita, un lampo di grazia che illumina per un istante il buio del presente.