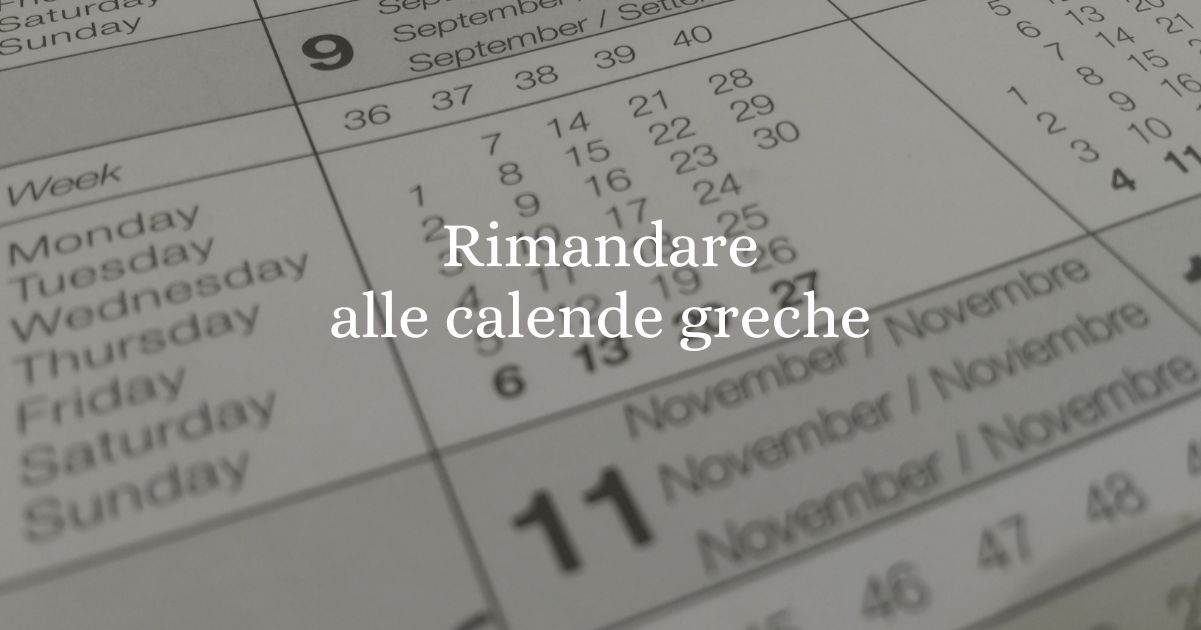Vi è mai capitato di “rimandare alle calende greche” qualcosa? Probabilmente si, ma non conoscevate il significato di questo modo di di dire. Per loro, e per quelli che sanno il significato ma ne ignorano l’origine e il riferimento storico, proponiamo la spiegazione di questa espressione di provenienza classica.
Cosa significa “Rimandare alle calende greche”
Il modo di dire “rimandare alle calende greche” è una traduzione letterale del motto latino ad kalendas graecas (cioè intenzionati a pagare alle calende greche) e fa riferimento a un tempo molto lontano, un futuro indeterminato, un giorno che non esiste, dunque, mai. Nel linguaggio comune, questa espressione si utilizza per riferirsi a un fatto molto improbabile o a un fatto rimandato a un futuro remoto: si usa soprattutto quando si vuole rimandare un’azione che non si è propensi a compiere volentieri a una data che non arriverà mai.
L’origine del modo di dire
Lo storico Gaio Svetonio attribuisce la frase ad kalendas graecas soluturos all’imperatore Augusto, generalmente riconosciuto come il fondatore dell’Impero romano e primo imperatore di esso, per 40 anni, dal 27 a.C. L’imperatore avrebbe usato questa espressione per riferirsi ai debitori insolventi e quindi a un pagamento che non sarebbe mai stato fatto.
Per chiarezza le kalendae, il primo giorno del mese, dedicato di norma al pagamento dei debiti e dei prestiti, erano presenti solo nel calendario romano (la parola “calendario” viene appunto da kalendae) e non esistevano invece in quello greco. In questo modo, quindi, l’imperatore Augusto voleva riferirsi a un momento che non sarebbe mai arrivato: quello in cui i debitori avrebbero saldato i debiti maturati nei suoi confronti.
Da qui l’espressione usata ironicamente nell’antica Roma per indicare il rinvio di un’attività, un’impresa o un pagamento a una data inesistente.
Le calende
La parola calende (kalendae) trae origine dal verbo calo (gr. καλέω “chiamo a raccolta, convoco”); nei primi tempi di Roma, quando ancora vigeva il calendario di Numa, al primo apparire della luna nuova uno dei pontefici convocava il popolo nella curia calabra, sul colle capitolino, presso il sacello di Giunone Moneta, e annunziava il principio del mese. Fissava inoltre i giorni delle ulteriori fasi lunari del mese.
Il dì delle calende era in modo particolare dedicato a Giunone, come le idi erano sacre a Giove. Così alle calende di febbraio si celebrava la feria di Giunone Sospita, il cui culto era originario da Lanuvio; quelle di marzo erano consacrate a Giunone Lucina, il cui tempio si ergeva sull’Esquilino. Nello stesso giorno cadevano le feste dette Matronalia, in onore di Bruto, uccisore e vendicatore di Lucrezia. Alle calende di giugno si solennizzava la dedicazione del tempio di Giunone Moneta, sull’arce capitolina, e in quelle di settembre si celebrava sull’Aventino la festa di Giunone Regina.
Il libro sulle espressioni idiomatiche
L’espressione “rimandare alle calende greche” e altri modi di dire diffusi nella nostra lingua sono protagonisti all’interno del libro del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), volume scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.
Un “libro di società” perché permette di essere condiviso e di “giocare” da soli o in compagnia alla scoperta dell’origine e dell’uso corretto dei modi di dire che tutti i giorni utilizziamo. Un volume leggero che vuole sottolineare l’importanza delle espressioni idiomatiche. Molte di esse sono cadute nel dimenticatoio a causa del sempre più frequente utilizzo di espressioni straniere e anglicismi.