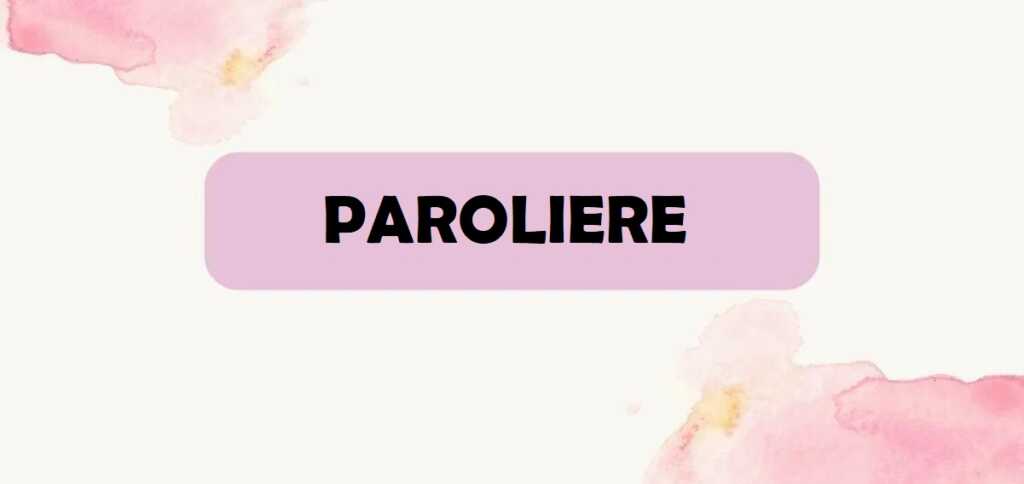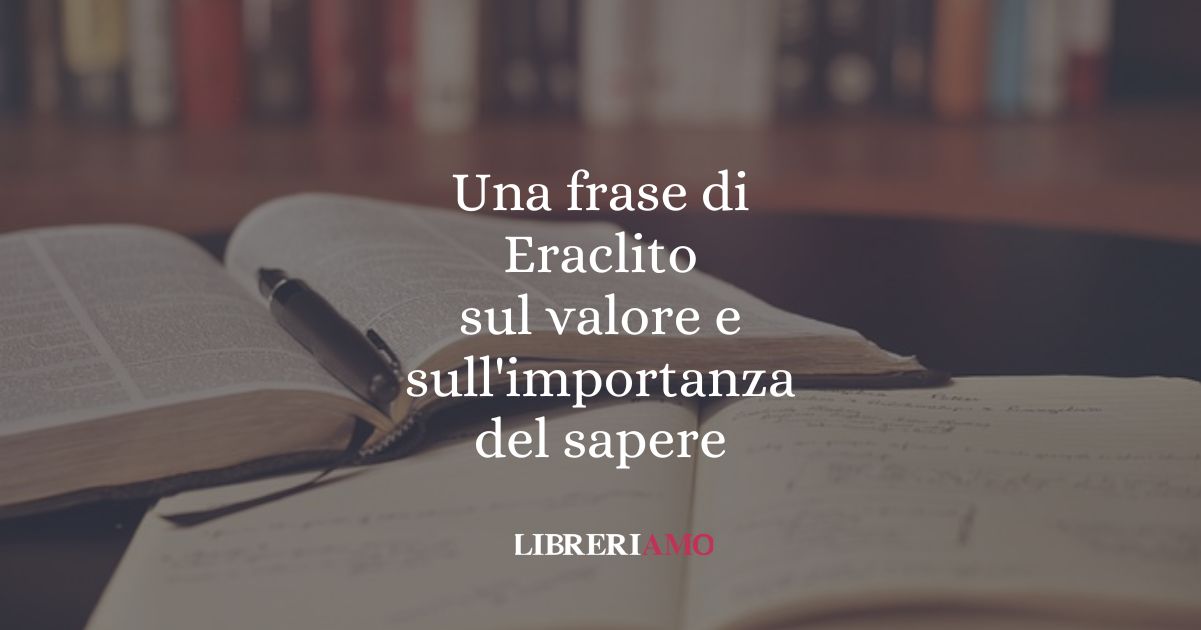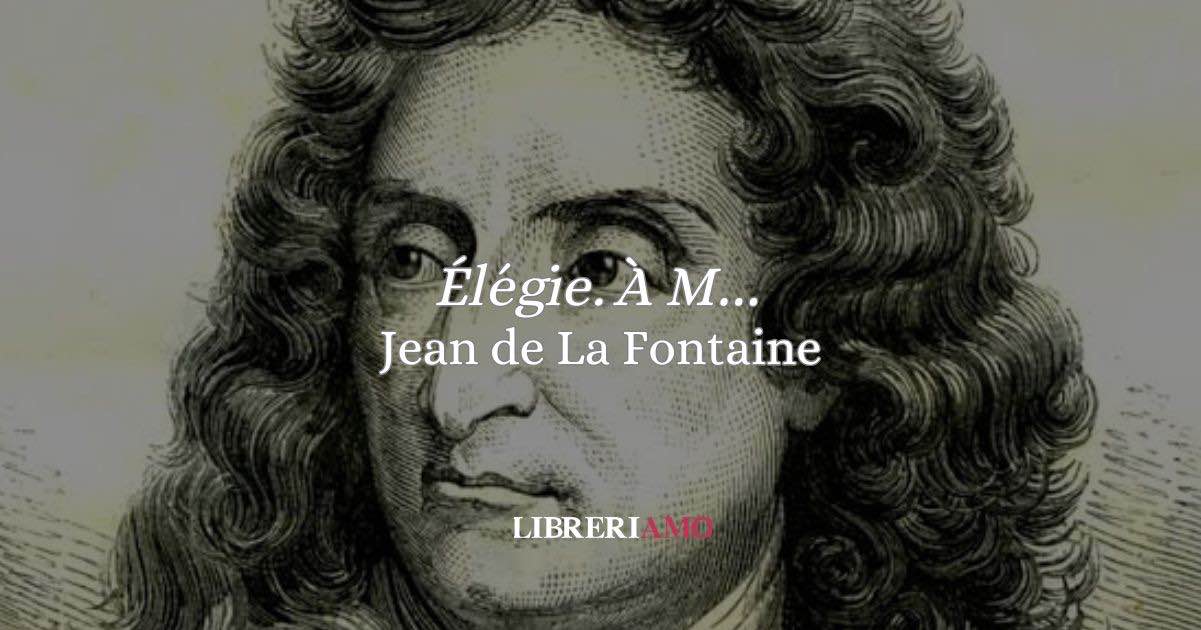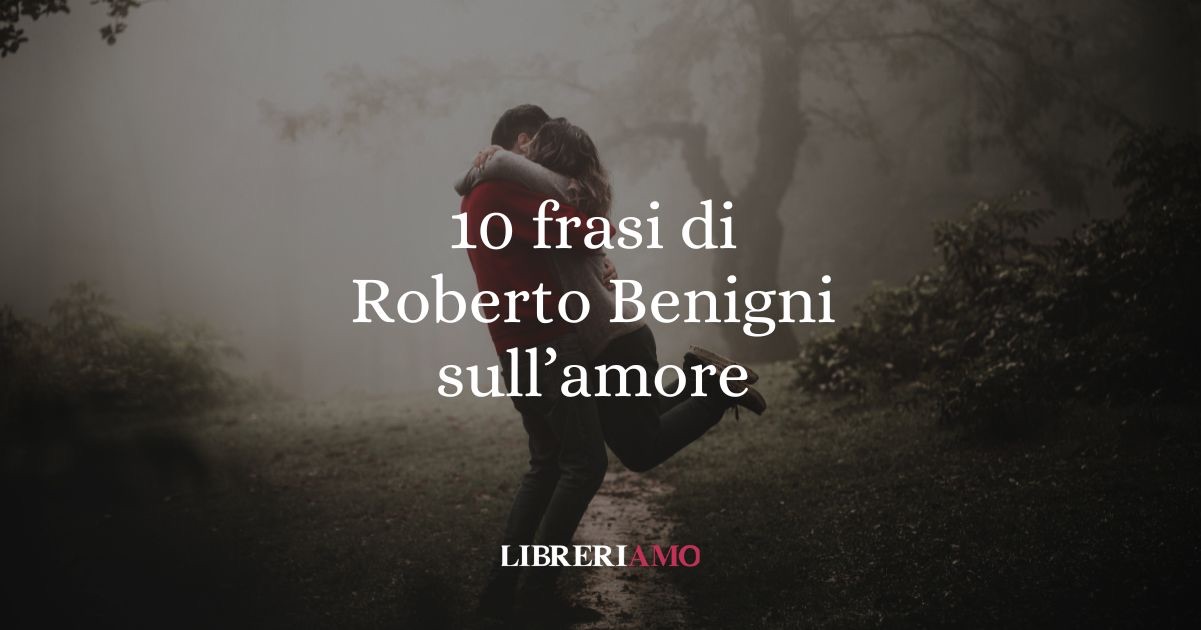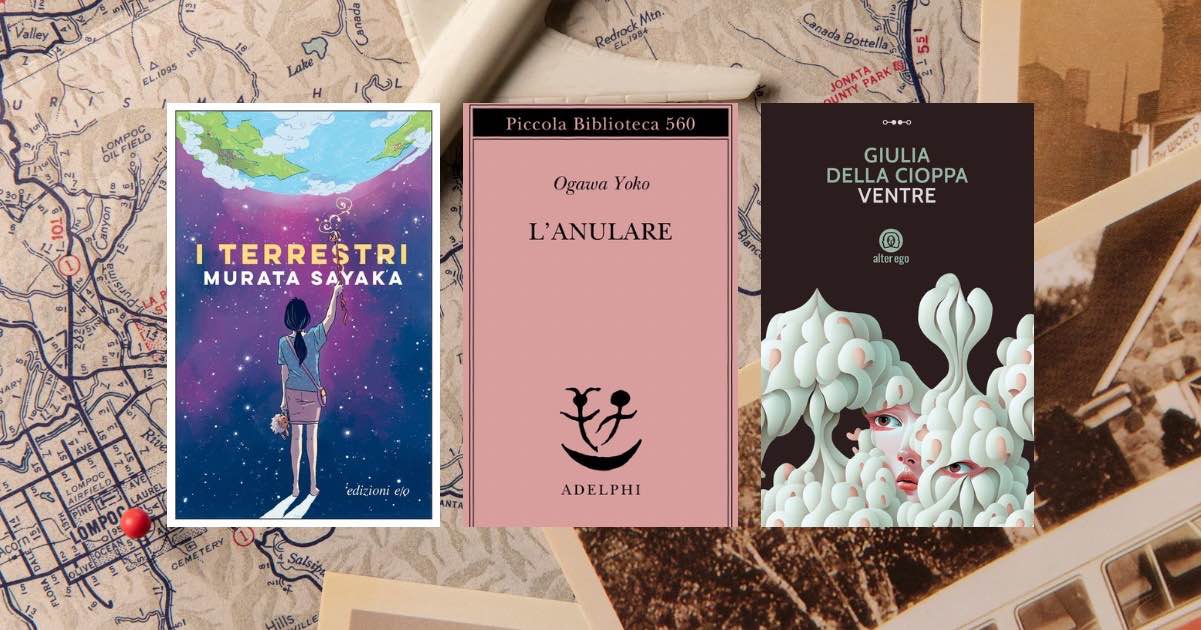Il paroliere indica solitamente chi scrive i versi o le parole per una canzone o per altra composizione di musica leggera, in particolare chi adatta le parole a musica già composta. Recentemente, agli accademici della Crusca è arrivata la richiesta, da parte della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), di consulenza sul termine paroliere, usato spesso in maniera colloquiale come sinonimo della parola autore, il cui utilizzo “equivale a sminuire la portata di un’attività creativa e artistica tra le più nobili”.
Il “paroliere” Mogol
L’analisi di Paolo D’Achille parte proprio dalla richiesta del più famoso paroliere italiano, il celebre Mogol, nonché Presidente onorario della SIAE, il quale sulla questione si era già sbilanciato in recenti interviste, inorridendo quando viene chiamato “paroliere” e ribadendo di voler essere definito “autore” (“io vi chiamo giornalisti, mica giornalai”).
Per cogliere la percezione negativa del termine da parte di Mogol, è opportuno ricostruire la storia della parola, che i principali dizionari italiani datano al 1928, sulla base di un esempio riportato dal GDLI nel Supplemento 2009, che anticipa il passo di Moravia (del 1970) citato nel vol. XII, s.v. paroliere (identica, nelle due voci, è la definizione: “Autore del testo di una canzone di musica leggera; chi svolge professionalmente tale attività”).
L’analisi della parola
Sul piano dell’etimologia sincronica, paroliere può essere facilmente interpretato come suffissato, da parola + -iere, suffisso tuttora produttivo per indicare i nomi di mestiere, e non sempre con connotazione negativa: se verduriere e verduraio sono (geo)sinonimi, il gelatiere è professionalmente più quotato del gelataio. Storicamente, però, si tratta di un francesismo. Lo documenta il fatto che il termine francese parolier è attestato anteriormente: il TLFi lo data al 1855, riportando anche esempi del 1863 e del 1935, ma la prima registrazione lessicografica è in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, vol. III, Paris, Hachette, 1873, dove si precisa che si tratta di una “parola d’autore”, inventata dal critico e musicologo Castil-Blaze (citato del resto anche nel TLFi) con un valore spregiativo, per indicare l’autore di testi di opere e operette, quello che in Italia si chiama – a partire dai primi dell’Ottocento, e inizialmente anch’esso con valore spregiativo – librettista (vocabolo formato con l’aggiunta di -ista a libretto, nel significato specifico, documentato già dal Settecento, di ‘testo in versi di un melodramma o di un’opera lirica’).
Si può aggiungere che in italiano, per indicare, ironicamente, il librettista è documentato – prima ancora che nascesse questa parola, la cui prima attestazione risale al 1836 – anche un derivato da parola, usato più spesso nel senso di ‘chi parla molto e in modo poco concludente’, e cioè parolaio (1817). Sempre a scopo ironico, invece di paroliere, troviamo un esempio di parolante (1965), non a caso contrapposto a musichiere ‘autore della musica di una canzone’. Ecco al riguardo i due esempi riportati nel GDLI:
Altre accezioni
Nella sua analisi, il linguista della Crusca analizza le occasioni in cui “paroliere” indica qualche altra cosa, e cioè:
1) la trasmissione RAI di Lelio Luttazzi del 1962-63 intitolata “Il paroliere questo sconosciuto”, dedicata, peraltro, proprio agli autori di testi di canzoni (cfr. V.B., TV: un servizio speciale e il ritorno del «Paroliere», “Il Corriere della Sera”, 3/7/1963);
2) la rubrica tenuta sull’“Espresso” da Tullio De Mauro, a cui si riferisce questo esempio:
Il mio vecchio amico Tullio De Mauro mi ha fatto l’onore di chiamarmi in causa, nella prestigiosa rubrica Il Paroliere che tiene sull’Espresso (di questa settimana). (Beniamino Placido, Rimini Rimini e la curva sud, “la Repubblica”, 24/5/1989, p. 29);
3) il nome commerciale di un “gioco consistente nel formare parole a partire da lettere dell’alfabeto scritte sulle facce dei dadi” (GRADIT; significato registrato con la data 1986); si tratta della versione italiana del gioco da tavolo inventato dallo statunitense Alan Turoff nel 1970, denominato in inglese Boggle, introdotto in Italia dalla Casa Editrice Giochi qualche anno dopo;
4) alcune rare occorrenze della parola come aggettivo (anche al femminile e al plurale) nel senso di ‘che usa molte parole, che ha un ricco vocabolario’ (ne do un esempio: “la sua superlativa capacità paroliera”, in Ettore Paratore, Il Satyricon di Petronio. Commento, Firenze, Le Monnier, 1933, p. 185).
Perché si utlizza “paroliere”
Secondo l’analisi della Crusca, il successo di paroliere nella musica leggera si spiega col fatto che, diversamente dalla prassi propria del melodramma e dell’opera lirica (almeno fino a Puccini), il musicista metteva in musica (“intonava”, per usare il termine tecnico) un preesistente testo drammatico in versi (sia pure non rispettandone sempre la metrica e cambiando, omettendo o ripetendo varie parole). Invece, nella canzone, il procedimento è di solito inverso. È la melodia a essere composta per prima e a offrire l’attenzione del poeta o paroliere una serie di ritmi e accenti che precostituiscono il suo schema prosodico. Il metro, quindi, precede nel lavoro del paroliere ogni altro elemento di lingua poetica, costituisce anzi il modello obbligato, astratto e concreto nello stesso tempo, che sta alla base della composizione.
Insomma, al paroliere si richiedono competenze particolari e non c’è dubbio che, data la crescita del peso della musica leggera e della cosiddetta “canzone popolare” nella cultura contemporanea, il termine – così come quello di cantautore (“cantante che interpreta brani da lui stesso composti”; GRADIT, con datazione al 1960) – si è progressivamente diffuso.
Preferire – nell’uso individuale – una designazione alternativa è del tutto lecito, ed è anche lecito rivendicare per il paroliere il rango di “autore” a tutti gli effetti, e in certi casi di vero “poeta”, se le parole di una canzone sono davvero belle e ben riuscite. Questo serve anche a ribadire il ruolo non sempre gregario rispetto al compositore della musica. Non sembra tuttavia possibile, allo stato attuale, sostituire la parola in tutte le occasioni, perché ormai il radicamento è molto forte, e vasta la sua diffusione, anche in contesto tecnico. Va comunque tenuto presente che la larga diffusione di paroliere ha finito per attenuare e anzi annullare il significato spregiativo che il termine aveva all’inizio, quando è arrivato dal francese.