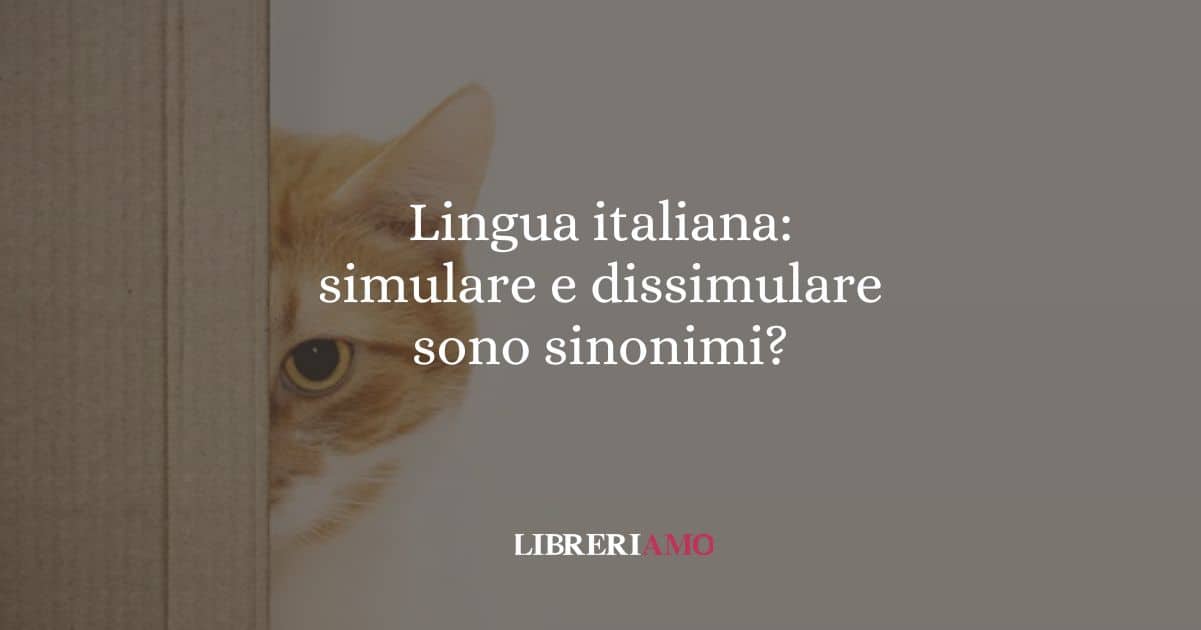La lingua italiana, ricca di sfumature e di precisioni semantiche, custodisce nel proprio lessico coppie di termini che a prima vista appaiono simili, ma che, a un’analisi più attenta, rivelano significati profondamente diversi. È il caso dei verbi “simulare” e “dissimulare”, spesso confusi, talvolta usati impropriamente come sinonimi, eppure distinti da una tradizione d’uso secolare che ne evidenzia le differenze.
Simulare: fingere come artificio
Il verbo simulare deriva dal latino simulare, “rappresentare, imitare, fingere”. La radice richiama l’idea di rendere simile ciò che non lo è, creando un’illusione di realtà. Nella lingua italiana simulare ha mantenuto questa impronta originaria: chi simula attribuisce a sé un comportamento, un pensiero o un’emozione che in realtà non prova.
La simulazione, dunque, è il regno della finzione attiva. Un calciatore che cade in area senza essere stato toccato simula un fallo; un attore che interpreta un personaggio simula emozioni che non gli appartengono; un imputato che vuole evitare un processo può simulare malattia.
Accanto a questo valore morale – quasi sempre negativo, perché legato all’inganno – si è sviluppato, soprattutto in epoca moderna, un uso tecnico e neutro del verbo. In ambito scientifico e tecnologico, “simulare” significa riprodurre artificialmente un fenomeno al fine di studiarlo o addestrarsi: i simulatori di volo per i piloti, le simulazioni matematiche per prevedere il comportamento di un sistema complesso, le simulazioni al computer di processi economici o biologici. Qui la parola perde il suo legame con la menzogna e diventa uno strumento di conoscenza.
Dissimulare: l’arte di nascondere
Molto diversa è la storia del verbo dissimulare, anch’esso di origine latina (dissimulare = “nascondere, celare”). Dissimulare non significa fingere ciò che non è, ma occultare ciò che è. È un gesto di sottrazione, non di invenzione. Chi dissimula non attribuisce a sé una qualità inesistente, ma tace o maschera una realtà autentica.
Un uomo che non vuole mostrare il proprio disappunto di fronte a un superiore lo dissimula; un diplomatico che mantiene un volto sorridente pur essendo in disaccordo dissimula le proprie emozioni; un adolescente che tace la propria delusione davanti agli amici dissimula.
Se simulare è “aggiungere” qualcosa che non c’è, dissimulare è “togliere” o nascondere ciò che c’è.
Differenza morale: il giudizio degli antichi
La differenza non è soltanto semantica, ma anche etica. Già il trecentesco Buti, commentatore della Divina Commedia, distingueva con chiarezza:
“Simulazione è fingere vero quello che non è vero, e dissimulazione è negar quello ch’è vero.”
Questa linea è stata ripresa dai lessicografi successivi e trova conferma in autori come Dante e Torquato Accetto. Dante, nel Convivio (III, 10), parlava della dissimulazione onesta come di una virtù, utile e necessaria in determinati contesti, ad esempio quando un figlio non può correggere apertamente il padre o un suddito il proprio signore senza rischiare conseguenze peggiori. Dissimulare, in questo senso, significava proteggere l’altro o preservare sé stessi con prudenza e discrezione.
Torquato Accetto, nel suo celebre trattato seicentesco Della dissimulazione onesta, ne fece addirittura un’arte della vita civile. Dissimulare significava difendersi in una società complessa, celando intenzioni e pensieri quando manifestarli sarebbe stato dannoso.
Simulare, invece, è sempre stato associato a una certa riprovazione morale. Guicciardini notava come i principi fossero costretti talvolta a simulare, ossia a fingere per ragioni di potere, ma la parola rimaneva gravata da un’aura di sospetto e ipocrisia. Ancora oggi parliamo di “fallo di simulazione” nel calcio o di “simulazione di reato” nel linguaggio giuridico: due espressioni che sottolineano la natura ingannevole del termine.
Usi assoluti e sfumature semantiche nella lingua italiana
Interessante è anche l’evoluzione sintattica dei due verbi. Entrambi hanno costruzione transitiva, ma possono essere usati anche in forma assoluta. Dire “Tizio simula” equivale a dire che ha l’abitudine di fingere, senza specificare che cosa. In questo caso il verbo non cambia di significato, ma acquista il valore di una caratteristica abituale.
Diverso è il caso di “dissimulare” intransitivo. Se dico “Tizio dissimula astutamente”, il verbo non significa più soltanto “nascondere”, ma anche “fingere altro”, avvicinandosi semanticamente a simulare. In questo senso, dissimulare si colora di un’ambiguità che lo rende più flessibile, capace di indicare atteggiamenti sottili, tra il celare e il fingere.
Simulare e dissimulare nella forma riflessiva
Anche nella costruzione pronominale emergono differenze. Simularsi significa fingersi, attribuirsi qualità non possedute, come notava Gadda nei suoi scritti. Dissimulare, invece, in forma pronominale vale “confondersi”, “non farsi notare”: un oggetto che si dissimula nell’ambiente, una persona che si dissimula nella folla. Ancora una volta, il primo verbo rimanda a una costruzione artificiale, il secondo a un nascondimento.
La distinzione tra simulare e dissimulare non è un mero esercizio di filologia: riflette due atteggiamenti umani opposti. Simulare è creare un’apparenza ingannevole, attribuirsi ciò che non si è. Dissimulare è celare un tratto autentico, un pensiero, un sentimento, una verità.
Entrambi appartengono alla sfera dell’astuzia e della strategia comunicativa, ma mentre la simulazione porta con sé un’aura di falsità e di inganno, la dissimulazione, almeno nella tradizione etica e letteraria, può assumere il valore della prudenza, della discrezione, perfino della virtù.
In un mondo in cui l’apparenza domina, riconoscere la differenza tra simulare e dissimulare non è solo questione di precisione linguistica: è anche un invito a distinguere tra il fingere ciò che non si è e il custodire ciò che si è, tra l’inganno e la riservatezza, tra la menzogna e la prudenza. Per saperne di più rimandiamo a questo bell’articolo redatto dall’Accademia della Crusca: Simulare e dissimulare.