Lingua italiana: significato della curiosa parola “pomigero”
Scopriamo assieme il significato di una curiosissima e ormai desueta parola della lingua italiana: l’aggettivo “pomigero”.
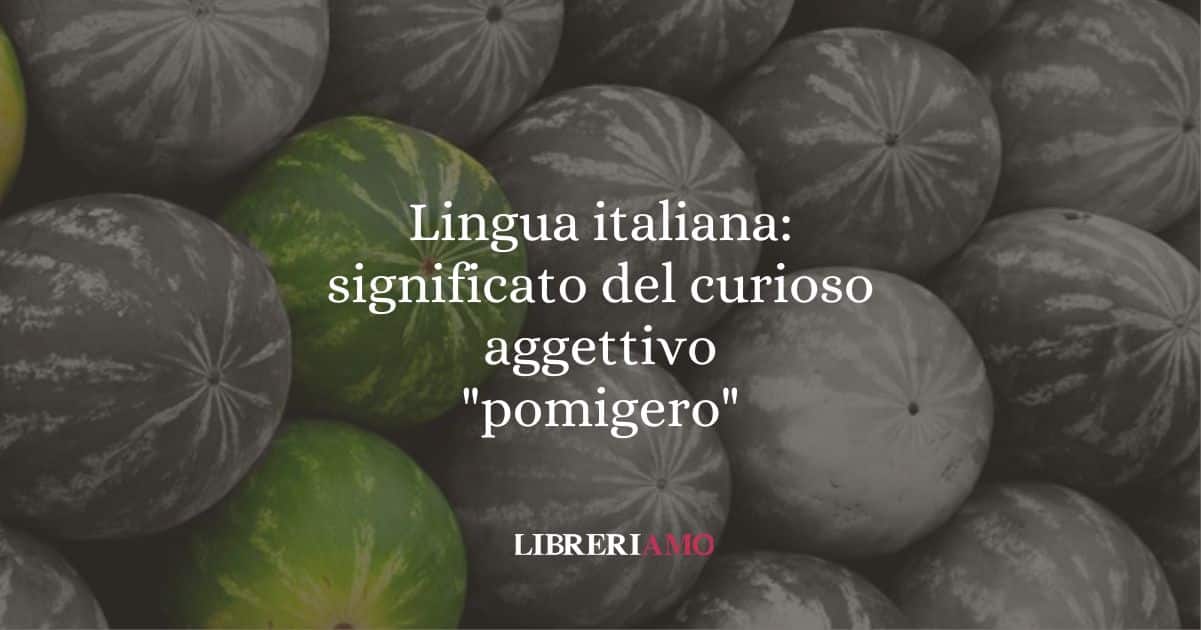
La parola “pomìgero”, oggi quasi scomparsa dall’uso comune, è un piccolo gioiello della lingua italiana letteraria e antica, un termine che unisce la musicalità del suono alla ricchezza delle immagini. In essa convivono due elementi di grande potenza evocativa: la dolcezza del “pomo”, simbolo di rotondità e fecondità, e l’idea del “portare”, ereditata dal latino gerĕre, che conferisce al termine un valore dinamico, vitale. Nella forma “pomìgero”, con l’accento sulla seconda sillaba, il vocabolo appartiene al linguaggio colto e amoroso del Rinascimento, in particolare alla prosa raffinata e barocca di Francesco Colonna, autore del celebre Hypnerotomachia Poliphili (1499), da cui proviene una delle testimonianze più note dell’uso di questo aggettivo.
L’etimologia: tra latino e lingua italiana
L’origine della parola pomigero è dotta e compositiva, ossia costruita a tavolino secondo i modelli del latino umanistico. È formata dall’unione di “pomo” (dal latino pomum, “frutto rotondo”, ma anche, in senso figurato, “seno”, “guancia”, “parte tondeggiante del corpo”) e dal tema del verbo latino “gerĕre”, che significa “portare”, “recare”, “sostenere”.Il significato letterale, dunque, è “che porta frutti” o “che reca pomi”. Tuttavia, nell’uso figurato e poetico che se ne fece nel Quattrocento e Cinquecento, il termine assunse un senso più specifico: “che ha mammelle tondeggianti e floride”, quindi un aggettivo riferito al corpo femminile, connotato da dolcezza, sensualità e grazia.
Non si tratta, dunque, di un termine botanico (come potrebbe far pensare la forma), bensì di un epiteto amoroso e visivo, usato per descrivere la bellezza del petto femminile, paragonandolo ai pomi per la rotondità e la morbidezza. L’immagine del seno come “frutto” era comune nella poesia rinascimentale, dove il corpo della donna veniva spesso celebrato attraverso metafore naturali: i pomi, le rose, i gigli, il latte, la neve.
L’uso letterario e il contesto rinascimentale
L’esempio più celebre dell’uso di pomigero si trova, come ricorda il Vocabolario degli Accademici della Crusca, in un passo di Francesco Colonna, tratto dalla Hypnerotomachia Poliphili (1499), opera monumentale in lingua italiana rinascimentale, considerata un capolavoro di prosa allegorica e simbolica.
Nel brano citato, Colonna descrive un momento di intensa sensualità e di tenerezza:
“Io repente avidissima anellando alla sua insperata reiterazione ricevute le debilitate et abandonate bracce, piamente e cum dulcissime et amorose lachiymule cum singulato pertractantilo e manuagendulo e sovente basiantilo, presentandogli, gli monstrava il mio, immo suo, albente e pomigero pecto palesemente, cum umanissimo aspecto e cum illici ochi…”
Qui pomigero si riferisce al petto (“pecto”), descritto come “albente” (cioè “bianco”) e “pomigero” (cioè “tondo e florido come i pomi”). L’immagine è carica di sensualità ma anche di dolcezza: il corpo femminile viene presentato come un paesaggio naturale, luminoso, pieno di grazia e vitalità.
Nel linguaggio di Colonna, caratterizzato da un lessico artificioso e da un continuo gioco tra latino, volgare e invenzione linguistica, pomigero si inserisce perfettamente come esempio di quella ricerca di musicalità e di ricchezza semantica tipica della prosa umanistica.
Per comprendere appieno il valore di pomigero, occorre soffermarsi anche sul significato simbolico del “pomo”, da cui deriva la prima parte del termine. Il pomo, nella tradizione letteraria e iconografica, è un simbolo di bellezza, desiderio e conoscenza.
Dal pomo d’oro di Paride al frutto dell’albero del bene e del male nella Genesi, il pomo rappresenta da sempre l’oggetto del desiderio e della tentazione. Nella poesia amorosa, esso diventa metafora del corpo femminile e, più specificamente, del seno, della guancia o del ventre, cioè delle parti che incarnano la fertilità e la dolcezza della vita.
Così, definire un petto “pomigero” non significa soltanto descriverne la forma, ma attribuirgli una qualità mitica e sensuale, quella stessa che rende il frutto un segno di abbondanza, di maturità e di armonia naturale.
La sensualità di una parola perduta
Oggi la parola pomigero è del tutto caduta in disuso e sopravvive solo nei dizionari storici o nelle opere letterarie antiche. È un termine che appartiene al linguaggio umanistico e rinascimentale, un lessico ricco di invenzioni, dove la lingua era vista come un terreno di sperimentazione estetica.
La sua scomparsa si deve probabilmente alla specializzazione semantica troppo ristretta (descrivere il petto femminile in modo figurato) e alla complessità del suo suono, più vicino al latino che all’italiano moderno. Tuttavia, il fascino di pomigero rimane intatto: in una sola parola riesce a racchiudere un mondo di immagini, unendo il corpo alla natura, la carne al frutto, la sensualità alla purezza della forma.