Lingua italiana: il significato del curioso verbo “glosare”
Scopriamo assieme qual è il significato dell’ormai desueto verbo della lingua italiana “glosare” e quale la sua origine e il suo uso.
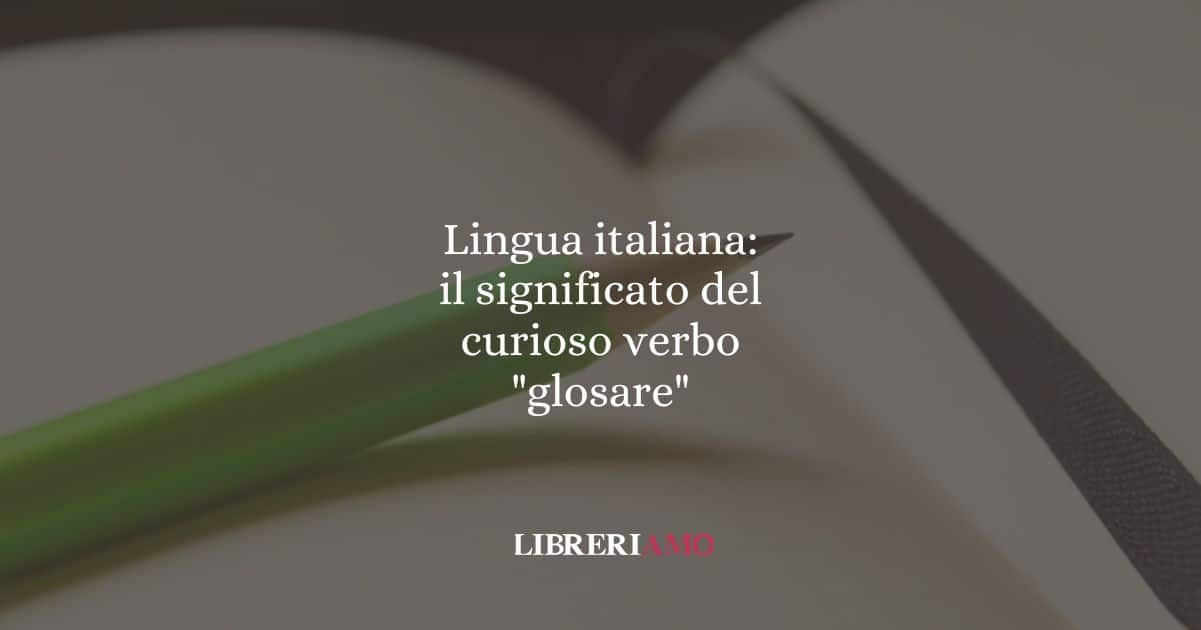
La parola della lingua italiana “glosare”, nella sua forma oggi prevalente “glossare”, appartiene a quel gruppo di termini che portano con sé una lunga storia di studi, interpretazioni e trasmissioni del sapere. Già dal suono, dalla breve e incisiva struttura fonetica, si percepisce una radice antica, che rimanda al mondo dei testi manoscritti, dei margini annotati, dei commentatori che cercavano di rendere comprensibile ciò che, per lingua, contesto o distanza storica, rischiava di diventare oscuro.
La sua origine è infatti legata direttamente alla parola “glossa”, proveniente dal greco glôssa, che significa “lingua” ma anche, per estensione, “parola difficile, termine raro, vocabolo che necessita di spiegazione”. Questo duplice nucleo semantico — la lingua come organo e la lingua come sistema espressivo — ha segnato la fortuna della parola nel passaggio dal greco al latino e poi alle lingue romanze.
Dal latino alla lingua italiana
Il verbo latino glossare nasce per indicare l’atto di spiegare una glossa, ossia chiarire un termine poco noto, arcaico o straniero presente in un testo. Nell’antichità classica, quando grandi opere poetiche o filosofiche venivano trasmesse ai lettori più giovani o a comunità linguisticamente diverse, si rendeva necessaria la creazione di raccolte di glosse: elenchi di vocaboli difficili accompagnati da sinonimi, parafrasi o brevi spiegazioni. Da qui nacque la pratica del glossare, cioè apporre note a margine — le celebri marginalia — o redigere veri e propri glossari.
Nel Medioevo, epoca in cui la trasmissione dei testi era affidata alle scuole monastiche e poi alle università, glossare divenne un’arte, oltre che una necessità. Gli amanuensi e i maestri delle scholae non si limitavano a copiare fedelmente i testi, ma li circondavano di chiose e interpretazioni: spiegavano termini tecnici, contestualizzavano riferimenti culturali, discutevano questioni teologiche o giuridiche.
La pagina medievale è spesso uno spazio stratificato, dove a un testo principale si affiancano diverse mani che glossano e contro-glossano. Nacque così una tradizione esegetica profondissima, soprattutto legata alla lettura delle Scritture, ma anche dei classici latini. Glossare significava dunque partecipare attivamente alla vita del testo, ampliarne il significato, renderlo vivo per nuove generazioni.
Da un punto di vista linguistico, il verbo “glosare/glossare” in italiano entra attraverso il latino medievale, conservando praticamente intatto il suo valore tecnico. Le prime attestazioni si trovano in ambienti accademici e religiosi, perché è lì che si praticava quotidianamente il lavoro di spiegazione dei testi. Nel tempo, però, il significato si è esteso: se inizialmente glossare indicava solo l’atto di chiarire vocaboli difficili, oggi significa commentare in generale, offrire spiegazioni più o meno approfondite su un testo, un discorso, un passaggio complesso.
È interessante osservare come la parola abbia mantenuto un’aura specialistica, senza tuttavia perdere accessibilità. Nel linguaggio comune “glossare” non è un verbo di uso frequente, ma compare nel contesto scolastico, letterario o filologico, proprio perché richiama una pratica antica, metodica e minuziosa. È un termine che evoca rigore intellettuale, capacità di lettura attenta e voglia di comprendere in profondità ciò che si legge.
Il significato più originario del verbo, quello di chiarire un vocabolo mediante un sinonimo, ci ricorda qualcosa di importante: le glosse nascevano per colmare un divario linguistico. Il lettore dell’antichità o del Medioevo non aveva a disposizione dizionari immediati, e spesso si trovava davanti a parole appartenenti a dialetti, lingue più arcaiche, registri colti. Il glossatore diventava quindi un ponte tra il passato e il presente. In questo senso, glossare non era un semplice esercizio di erudizione, ma un atto di mediazione culturale.
Glosare/glossare, oggi
Nel linguaggio contemporaneo, la semantica di glossare si è ampliata fino a includere ogni forma di commento esplicativo. Un critico letterario glossarebbe un romanzo, un docente glosserebbe un passo di Dante, un giurista glosserebbe un articolo di legge. Il gesto mentale è sempre lo stesso: prendere un testo e farlo parlare con maggiore chiarezza, mettendo in luce aspetti nascosti, ambiguità, rimandi impliciti.
Ciò che rende affascinante questa parola è la sua capacità di indicare sia un’attività tecnica sia un atteggiamento interpretativo. Glossare è un modo di leggere, un modo di entrare nel testo e di lasciarsi provocare da ciò che non è immediatamente comprensibile. In un’epoca in cui la lettura superficiale rischia di prevalere, glossare ricorda l’importanza della lentezza, dell’approfondimento, della cura per il dettaglio.
Inoltre, il concetto di glossare è oggi centrale anche nella comunicazione digitale. Le note a piè di pagina, i commenti esplicativi nei forum, le annotazioni sui documenti online, le precisazioni nei social network sono, in fondo, forme moderne di glosse. Senza contare che l’ipertesto stesso, con la sua struttura di rimandi e spiegazioni, può essere considerato una gigantesca glossa collettiva.
In conclusione, la parola “glosare” è un esempio perfetto di come un termine antico possa continuare a parlare al presente. Significa spiegare, chiarire, interpretare, accompagnare il lettore nella comprensione di un testo. Significa anche, in senso più ampio, avvicinare ciò che è lontano, rendere familiare ciò che è difficile, costruire ponti linguistici e culturali. Ed è forse questo il valore più prezioso del glossare: ricordarci che la conoscenza non si riceve mai passivamente, ma si costruisce attraverso il dialogo tra le parole e chi le legge.