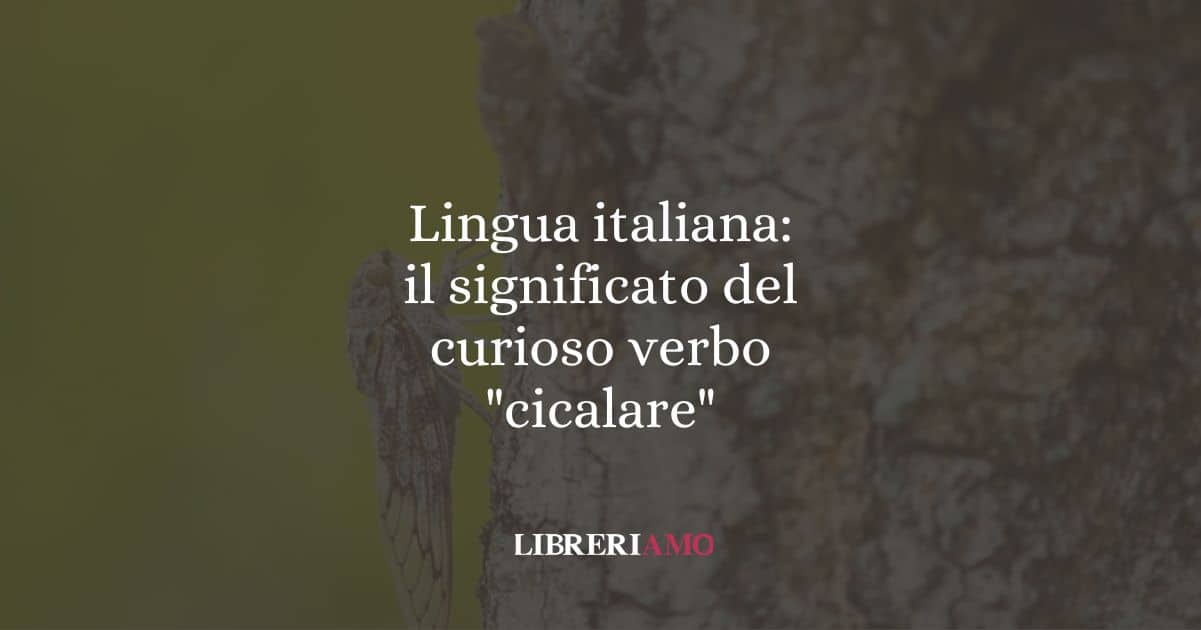Il verbo cicalare appartiene a quella categoria di parole della lingua italiana che, pur non essendo tra le più usate nel parlato quotidiano, conservano una straordinaria ricchezza espressiva e culturale. Derivato dal sostantivo cicala, il verbo evoca immediatamente un’immagine sonora e visiva: quella del piccolo insetto che, nelle calde giornate estive, riempie l’aria con il suo canto monotono e insistente. Da questa suggestione naturale nasce una metafora linguistica potente, che ha attraversato secoli di letteratura, costume e linguaggio comune.
Origini e significato nella lingua italiana
Cicalare è un verbo intransitivo della prima coniugazione (ausiliare avere) che significa, in senso proprio, parlare a lungo e noiosamente di cose frivole. È il parlare continuo, leggero, spesso inconcludente, che si associa a chi chiacchiera per passare il tempo o per il semplice gusto di parlare, senza particolare profondità di contenuto. Ma non si tratta solo di innocua conversazione: cicalare può significare anche mormorare o sparlare, cioè parlare male di qualcuno, diffondere pettegolezzi, insinuare maldicenze.
L’etimologia è trasparente: la parola deriva da cicala, l’insetto simbolo della loquacità e dell’inutilità del parlare continuo. L’associazione tra l’insetto e il comportamento umano è antica e radicata nella cultura europea: basti pensare alla celebre favola di Esopo (e poi di La Fontaine) La cicala e la formica, in cui la cicala rappresenta l’ozio e la leggerezza contrapposti all’operosità della formica.
“Cicalare” nella letteratura
La lingua letteraria italiana ha fatto largo uso del verbo cicalare, sia in senso neutro che negativo. Celebre è l’uso che ne fa Massimo D’Azeglio, scrittore e patriota dell’Ottocento, quando scrive:
«Camminavano passo passo, fermandosi spesso e cicalando fra loro».
Qui il verbo ha un tono descrittivo, quasi affettuoso: indica una conversazione leggera tra amici o conoscenti, un chiacchiericcio senza malizia. L’immagine è quella di un momento di socialità semplice, forse un po’ inconcludente, ma umano e quotidiano.
Diverso è il tono con cui Alessandro Manzoni lo utilizza nei Promessi sposi:
«In vece di cicalar più a lungo intorno a quest’uomo, andiamo a vederlo in azione».
In questo caso, cicalare ha una sfumatura critica: parlare troppo senza agire diventa perdita di tempo, un chiacchiericcio sterile che non produce conoscenza né verità. Manzoni invita il lettore a superare le parole inutili per arrivare alla sostanza dei fatti.
Questi due esempi mostrano bene la duplice natura del verbo: da un lato può indicare un parlare leggero e innocuo, dall’altro un parlare eccessivo e fastidioso, quando non addirittura maligno.
Il valore sociale del “cicalare”
Dal punto di vista sociolinguistico, cicalare si colloca nell’area semantica della chiacchiera, del pettegolezzo, della conversazione informale. È un’attività prevalentemente orale, che si svolge in contesti di prossimità: tra amici, vicini di casa, colleghi, parenti. Il verbo conserva un’aura popolare, spesso associata a contesti femminili o domestici, anche se questa attribuzione è frutto di stereotipi culturali più che di realtà linguistiche oggettive.
Nelle società tradizionali, il cicalare aveva una funzione sociale ben precisa: permetteva lo scambio di informazioni, rafforzava i legami di comunità, creava complicità. Ma poteva anche essere strumento di controllo sociale, di esclusione, di condanna morale. Sparlare di qualcuno, insinuare dubbi sulla sua condotta, diffondere voci non verificate: tutto ciò rientra nel campo semantico di cicalare in senso negativo.
Oggi il verbo ha perso parte della sua diffusione, soppiantato da termini più comuni come chiacchierare, spettegolare, parlare male. Tuttavia conserva un sapore letterario e ironico che lo rende ancora efficace in contesti stilistici ricercati o quando si vuole dare un tocco di eleganza o di distacco ironico al discorso.
Cicalare e chiacchierare: una differenza sottile
È interessante confrontare cicalare con il più comune chiacchierare. Entrambi indicano un parlare leggero e informale, ma con sfumature diverse. Chiacchierare è più neutro, meno connotato negativamente: può essere un’attività piacevole, rilassante, amichevole. Cicalare, invece, porta con sé un giudizio implicito di fastidio o inutilità: si cicala quando si parla troppo, senza costrutto, ripetendo le stesse cose o affrontando temi frivoli.
Inoltre, cicalare suggerisce una certa continuità sonora, un parlare ininterrotto che ricorda appunto il frinire della cicala. È un verbo onomatopeico, in qualche modo, che trasmette la sensazione di un rumore di fondo persistente.
Cicalare nel linguaggio figurato e moderno
In senso figurato, cicalare può essere usato per criticare comportamenti prolissi, discorsi inutili, riunioni interminabili. Dire che qualcuno “cicala” troppo significa sottolineare che parla senza dire nulla di importante.
Nel linguaggio giornalistico o saggistico, può comparire in contesti ironici o polemici, per smascherare la retorica vuota o la comunicazione autoreferenziale. Ad esempio, si può dire che in politica si “cicala” molto e si conclude poco, oppure che nei talk show televisivi si cicala per ore senza arrivare a una verità condivisa.
Il verbo cicalare, con la sua origine naturalistica e la sua lunga storia letteraria, rappresenta un piccolo gioiello della lingua italiana. Racchiude in sé un giudizio sul parlare umano: quando la parola diventa rumore, quando la conversazione si trasforma in chiacchiericcio, quando il discorso perde di vista la verità per inseguire la frivolezza o la maldicenza, allora si cicala.
Eppure, dietro questo verbo si cela anche la dimensione più quotidiana e semplice della comunicazione umana: il bisogno di parlare, di condividere, di stare insieme. Come le cicale che cantano al sole, anche gli uomini hanno bisogno di parole leggere. L’importante è saper riconoscere quando il canto diventa rumore.