Lingua italiana: origine e significato di “ageismo”
Scopriamo il significato del neologismo della lingua italiana “ageismo”, come nasce, come si è diffuso e in quali contesti viene adoperato.
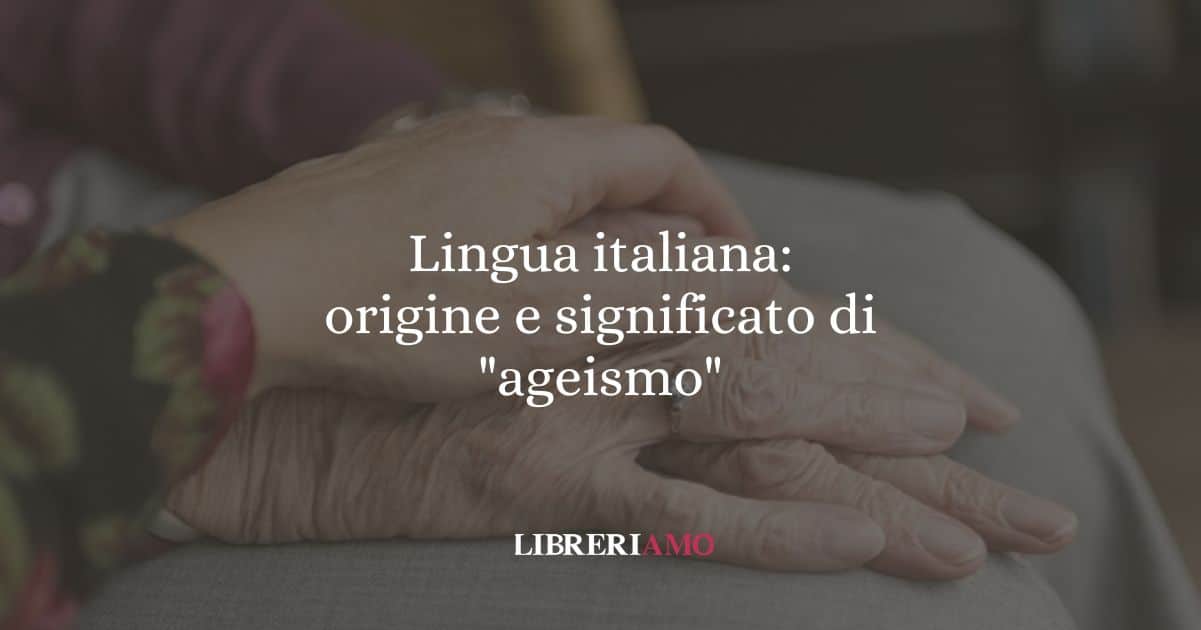
La lingua italiana, da sempre in dialogo con le trasformazioni sociali e culturali, accoglie nuovi termini per nominare fenomeni che, pur esistendo da tempo, acquistano visibilità solo in epoche particolari. Tra questi neologismi si colloca “ageismo”, parola poco diffusa ma sempre più necessaria per descrivere una forma di discriminazione spesso taciuta: quella basata sull’età.
Secondo la definizione lessicografica, l’ageismo è una forma di pregiudizio e svalorizzazione ai danni di un individuo in ragione della sua età, con particolare riferimento agli anziani. È un concetto che affonda le sue radici nella seconda metà del Novecento, quando il geriatra e psichiatra statunitense Robert Butler coniò il termine ageism (1969) sull’esempio di “racism” e “sexism”, cioè razzismo e sessismo. In francese sarebbe arrivato come âgisme, mentre in italiano è entrato con più lentezza, probabilmente a causa della minore consuetudine del nostro paese a discutere pubblicamente di discriminazioni legate all’età.
Lingua italiana e il neologismo “ageismo”
Se il termine è recente, la realtà che descrive è antica. L’ageismo si manifesta in tutte quelle situazioni in cui l’età diventa un criterio per giudicare, escludere o svalutare una persona. In passato, gli anziani erano spesso depositari di saggezza e memoria collettiva, ma con la modernità – soprattutto nella società industriale e post-industriale – l’età avanzata è stata progressivamente associata a perdita di produttività, rallentamento, obsolescenza.
Oggi l’ageismo si nota nel mondo del lavoro, dove i cinquantenni e sessantenni incontrano difficoltà a ricollocarsi, ma anche nella comunicazione mediatica, che celebra giovinezza, efficienza e bellezza, relegando la vecchiaia a una condizione da occultare. Allo stesso tempo, anche i giovani possono esserne vittime, quando vengono etichettati come inesperti o incapaci solo per la loro età.
Il linguaggio ha un ruolo cruciale nella diffusione e nella percezione dell’ageismo. Espressioni come vecchietto, matusalemme, bollito o, sul versante opposto, ragazzino, non sono semplici etichette: veicolano un giudizio, spesso sprezzante, che riduce la persona alla sua età anagrafica, ignorandone individualità e competenze.
La creazione del termine ageismo rappresenta dunque un passo avanti, perché dare un nome a un fenomeno significa renderlo visibile, riconoscibile, discutibile. Prima ancora di combattere un pregiudizio, è necessario chiamarlo per quello che è.
Ageismo e società contemporanea
Viviamo in società sempre più longeve. In Italia, uno dei paesi con la più alta aspettativa di vita al mondo, la percentuale di over 65 supera ormai il 23%. Questo dato demografico ha conseguenze profonde: il peso degli anziani nella vita sociale, politica ed economica cresce, ma al tempo stesso crescono le discriminazioni nei loro confronti.
Gli stereotipi legati alla vecchiaia – fragilità, malattia, lentezza – influenzano le politiche pubbliche, le dinamiche familiari e i rapporti interpersonali. Ma la realtà è molto più sfumata: la terza età è sempre più attiva, dinamica, capace di contribuire con competenze ed esperienze. L’ageismo, riducendo gli individui alla loro età, impedisce di valorizzare questa ricchezza.
Ageismo al contrario?
Va notato che l’ageismo non colpisce solo gli anziani. Anche i giovani possono subirlo quando vengono esclusi da decisioni importanti con il pretesto della scarsa età, o quando la loro voce viene sminuita come immatura. L’ageismo, dunque, non riguarda soltanto la vecchiaia: è un pregiudizio trasversale, che in generale svaluta chiunque sulla base dell’età, anziché delle reali capacità o dei meriti.
Non tutti hanno accolto con favore il neologismo. Alcuni commentatori, come Beppe Severgnini, hanno osservato che “ageismo” suona come un vocabolo brutto, artificiale, poco naturale per l’italiano. È vero che la parola appare meno immediata rispetto ad altre formazioni: richiama un’eco straniera, che può sembrare distante dalla sensibilità italiana. Tuttavia, la sua assonanza con razzismo e sessismo ne rafforza l’efficacia: colloca questa discriminazione sullo stesso piano delle altre, rendendola riconoscibile come problema sociale e non come fatto individuale.
Il contributo della parola al dibattito pubblico
L’introduzione di un termine come ageismo nella lingua italiana contribuisce a modificare la coscienza collettiva. Non basta denunciare singoli episodi: serve un concetto che li unisca, che mostri l’esistenza di un meccanismo sistemico.
Proprio per questo, anche se la parola può sembrare “dura” o “straniera”, la sua presenza è preziosa. Aiuta a smascherare pregiudizi radicati, spesso mascherati da ironia o da buon senso. Dire che qualcuno è “troppo vecchio per…” o “troppo giovane per…” diventa riconoscibile come espressione di ageismo, non come giudizio neutro.
Il neologismo ageismo segna un passo importante nell’evoluzione del lessico italiano. Non si tratta solo di arricchire la lingua con un termine in più, ma di portare alla luce un fenomeno sociale antico e pervasivo. Dare un nome al pregiudizio significa renderlo visibile, denunciarlo e, in prospettiva, combatterlo.
In una società che invecchia rapidamente, ma che allo stesso tempo valorizza ossessivamente la giovinezza, l’ageismo è un rischio concreto. Contrastarlo significa promuovere una cultura in cui l’età non sia etichetta, ma semplice dato anagrafico, irrilevante rispetto alla dignità, alle competenze e al valore di ogni persona.
Se la parola appare “brutta” a qualcuno, forse è proprio perché ci costringe a guardare una realtà scomoda. Ed è il compito di ogni buon neologismo: scuotere la coscienza collettiva e aprire spazi di riflessione che prima restavano muti.