Lingua italiana: si scrive e si dice “confort” o “comfort”?
Scopriamo assieme se secondo le regole della lingua italiana la parola inglese “comfort” va scritta con la lettera enne o con la lettera emme.
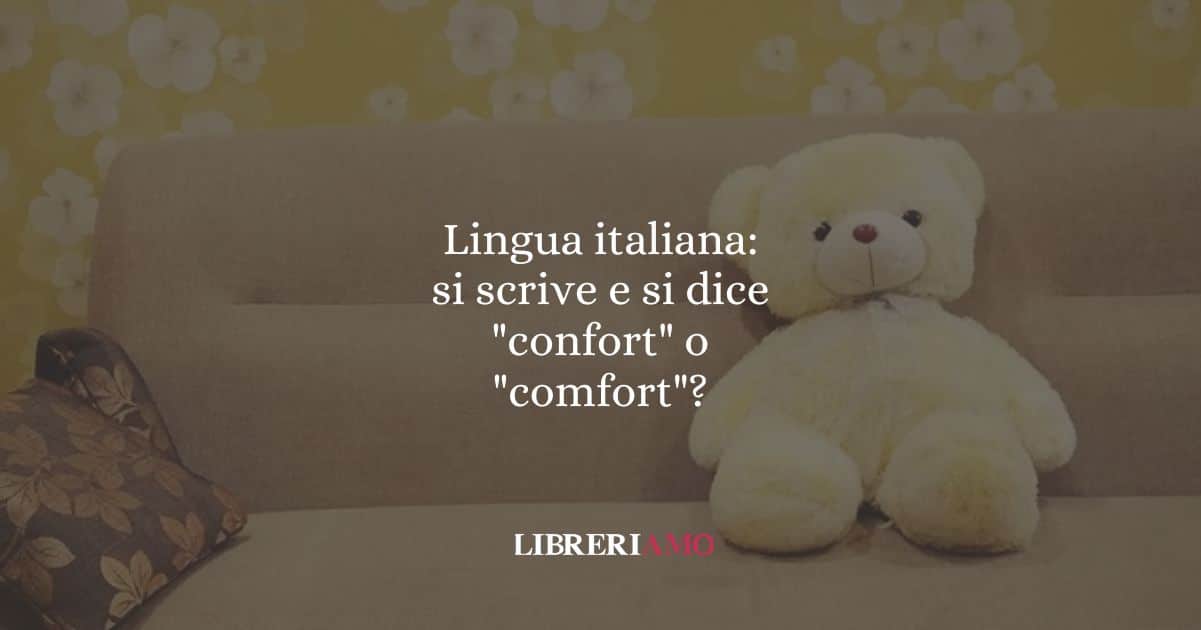
La lingua italiana è un organismo vivo, in continua trasformazione, capace di assorbire suggestioni esterne, adattarle, respingerle o talvolta custodirle in una sorta di limbo semantico. Il caso del dubbio tra confort e comfort è un esempio emblematico del modo in cui l’italiano vive il contatto con altre lingue—prima il francese, poi l’inglese—e del modo in cui gli usi sociali influenzano l’autorevolezza delle parole più di quanto non facciano le radici etimologiche. Si tratta dunque di un fenomeno linguistico che parla non soltanto di lessico, ma anche di storia culturale, di mutamenti nei gusti e nelle abitudini, e persino di prestigio delle lingue straniere nelle varie epoche.
Lingua italiana e anglicismi
In italiano, come accade per molti vocaboli d’importazione, confort e comfort non sono equivalenti soltanto sul piano grafico, ma racchiudono vicende storiche differenti. Oggi la forma più diffusa è nettamente comfort, prestito dall’inglese. La voce entra nell’italiano scritto verso la fine del XIX secolo con un significato inizialmente specifico: indicava l’insieme delle comodità offerte agli occupanti di una casa o di un mezzo di trasporto.
Era dunque una parola legata alla modernità industriale, ai nuovi stili di vita della borghesia, ai salotti, alle automobili e più in generale all’idea di un benessere materiale legato al progresso tecnico. Solo in seguito il termine assume il valore più generico di “comodità, agio”, pur mantenendo un senso concreto: non un benessere astratto, ma tutto ciò che rende confortevole la vita quotidiana in un determinato ambiente.
È significativo notare come l’introduzione di comfort abbia avuto un curioso effetto sul lessico italiano: ha operato un “prestito semantico” retroattivo. A partire dagli anni Venti dell’Ottocento, infatti, il nostro conforto, tradizionalmente legato all’idea di sostegno morale o spirituale, comincia ad allargare il proprio significato includendo quello di “agio, comodità”. Una trasformazione influenzata proprio dal mondo semantico del francese confort e dell’inglese comfort. Tuttavia, questa accezione di conforto è oggi considerata letteraria e antiquata, testimone di una fase linguistica passata più che di un uso vivo.
Eppure, se ci si sposta dal terreno dell’uso attuale a quello storico-etimologico, la voce confort non soltanto è legittima, ma in un certo senso è anche “più antica”. La parola comfort in inglese, infatti, non nasce autonomamente: è la traduzione, attestata fin dal XIII secolo, del francese confort nel significato di “conforto”. Dal francese medievale la parola giunge all’inglese nel XVII secolo, e solo molto più tardi dall’inglese rientra nell’italiano. Un curioso gioco di rimbalzi linguistici che mostra come una lingua possa riappropriarsi di un termine già esistente attraverso un’altra cultura.
Per questa ragione alcuni linguisti e puristi hanno nel tempo rivendicato la legittimità, perlomeno storica, della grafia confort. Tra questi compare Paolo Monelli, scrittore e giornalista molto attento ai fatti di lingua, autore del celebre Barbaro dominio, un dizionarietto critico delle voci straniere nell’italiano degli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Benché Monelli difenda la priorità delle parole autoctone—comodo, comodità, agio—non si mostra del tutto intransigente verso comfort. La considera sì un “errore”, ma un errore ormai radicato, e riserva le critiche più severe non tanto alla parola in sé quanto alla pronuncia alla francese, con l’accento sull’ultima sillaba, che giudica un arbitrio inutile e pedante.
Su questo punto, almeno, il giudizio di Monelli ha avuto fortuna: gli italiani hanno scelto spontaneamente una pronuncia più vicina all’inglese, con l’accento sulla prima sillaba. Un esempio di come l’uso sociale decida molto più delle prescrizioni normative.
Italiano e comfort zone
Oggi, dunque, entrambe le forme—confort e comfort—sono legittime. Ma è comfort a prevalere nettamente, per diffusione, riconoscibilità internazionale e perché ormai associato a una sfera semantica moderna e universale. Confort, pur corretto, sopravvive in nicchie colte, letterarie o filologiche, e appare spesso come un tratto d’epoca più che una scelta contemporanea.
Il caso dei due termini dimostra ancora una volta come la lingua non sia un museo di forme immutabili ma un paesaggio dinamico, dove ciò che sopravvive non è sempre la forma più antica, bensì quella che più si adatta ai bisogni comunicativi del presente. Così comfort, voce straniera adottata e italianizzata nell’uso quotidiano, racconta la storia di un’epoca, mentre confort ci ricorda le radici francesi di una parola che ha attraversato i secoli cambiando territorio, significati e pronunce. In questa tensione viva tra passato e presente si gioca, in fondo, la bellezza dell’evoluzione linguistica. Per saperne di più rimandiamo all’esaustivo articolo di Simonetta Tino: Confort o confort?