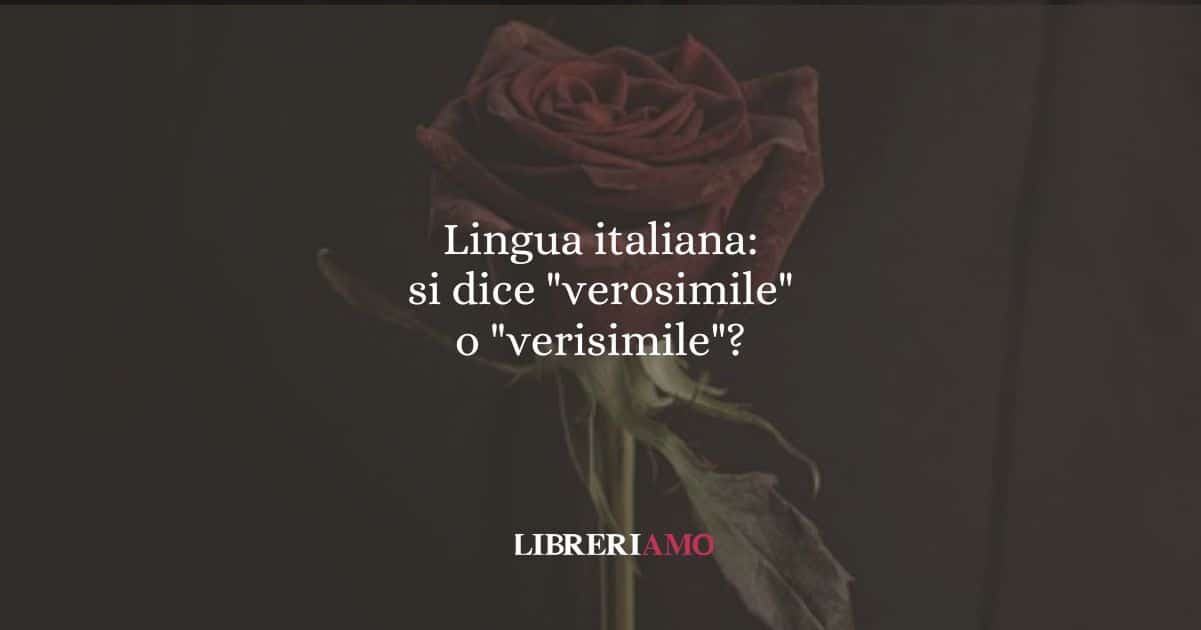La lingua italiana è ricca di doppioni, varianti e forme concorrenti che convivono per lunghi periodi prima che l’uso comune ne selezioni una come preferita. Tra questi casi rientrano «verosimile» e «verisimile», due aggettivi che derivano entrambi dal latino verisimĭlis, composto da verum («vero») e similis («simile»). La forma latina significava, appunto, “che somiglia al vero”, “che ha apparenza di verità”. Nel passaggio all’italiano, il termine ha assunto due fisionomie grafiche diverse, entrambe legittime, anche se non equivalenti per diffusione e percezione.
Se oggi «verosimile» è la forma largamente prevalente nell’uso contemporaneo, «verisimile» non è affatto errata: è una variante storicamente attestata, tuttora registrata nei dizionari e impiegata, seppur più raramente, in contesti letterari o in registri più sorvegliati. Esplorare queste due forme significa comprendere non solo la storia di una parola, ma anche i meccanismi di evoluzione della lingua italiana.
Origini e trasformazioni: dal latino alla lingua italiana
Come accade spesso nel passaggio dal latino ai volgari romanzi, si verificano fenomeni di semplificazione fonetica e di adattamento grafico. La forma latina verisimĭlis presentava una -i- nella seconda parte della parola (similis), che viene mantenuta in molte lingue romanze: si veda il francese vraisemblable, lo spagnolo verosímil (con caduta della seconda i), il portoghese verossímil.
In italiano, entrambe le vie erano possibili:
-
verisimile (più vicino al latino)
-
verosimile (con assimilazione vocalica e semplificazione)
La forma «verosimile» si impone progressivamente, probabilmente per un’analogia fonetica: la sequenza -ri-si- della forma latina appariva meno armoniosa rispetto alla più scorrevole -ro-si-. In altre parole, si è trattato di un normale processo di accomodamento fonetico volto a favorire la pronuncia e la fluidità del parlato.
I due usi nei secoli
Nei testi letterari antichi si trovano entrambe le forme. Ad esempio:
-
«verisimile» ricorre con maggiore frequenza nei testi medievali e rinascimentali, complice la vicinanza culturale e linguistica al latino.
-
«verosimile» si afferma soprattutto dal Seicento in poi, fino a diventare la forma dominante nell’italiano moderno.
Autori come Ariosto, Tasso e persino Leopardi oscillano tra le due forme, benché nel tempo la seconda prenda il sopravvento. Nell’Ottocento e ancor più nel Novecento, i dizionari normativi iniziano a indicare «verosimile» come forma preferibile, pur continuando a considerare «verisimile» come variante corretta.
Differenze di significato?
Da un punto di vista strettamente semantico, non esiste alcuna differenza di significato: entrambe le varianti indicano ciò che è “probabile”, “plausibile”, “credibile”, “conforme a ciò che si può ragionevolmente ritenere vero”.
E tuttavia, la lingua non si limita alla semantica: intervengono la percezione, la connotazione, la frequenza, il ritmo sonoro. Oggi:
-
verosimile è percepito come standard, comune, neutro.
-
verisimile appare più ricercato, più “latinizzante”, talvolta più letterario.
In certi testi filosofici, narrativi o saggistici, «verisimile» può assumere una sfumatura di maggiore astrattezza, quasi a sottolineare un legame più diretto con la tradizione classica o retorica.
Il ruolo della retorica e della narrazione
Il concetto di verosimiglianza è centrale nella poetica occidentale fin da Aristotele. Nella Poetica, l’autore afferma che l’arte deve rappresentare non necessariamente ciò che è accaduto, ma ciò che può verosimilmente accadere. Questo principio attraversa tutta la storia della letteratura: dal romanzo realistico alle narrazioni contemporanee, ciò che conta è la coerenza interna, la capacità di un racconto di risultare credibile nel mondo che costruisce.
In questo contesto, sia verosimile sia verisimile funzionano perfettamente: entrambe richiamano l’idea di un’apparenza di verità che sostiene la sospensione dell’incredulità del lettore.
Perché «verosimile» è più diffuso?
La prevalenza di una forma rispetto all’altra può dipendere da vari fattori:
-
Semplificazione fonetica
La sequenza -ri-si- è percepita come più complessa rispetto a -ro-si-. -
Influenza dell’uso comune
La forma più usata dai parlanti tende a consolidarsi. -
Codificazione normativa
I dizionari e la scuola, nel corso del Novecento, hanno promosso più spesso «verosimile» come forma principale. -
Analoghe semplificazioni in altre parole
L’italiano tende spesso a ridurre gruppi di vocali contigue o a modificare dittonghi e iati per agevolare la pronuncia. Verosimile si inserisce in questa tendenza.
La coesistenza pacifica delle due varianti
L’italiano contemporaneo ammette entrambe le forme, ma con una differenza importante:
-
verosimile → standard, comune, preferito, frequente nei testi di qualsiasi livello.
-
verisimile → raro, percepito come colto, talvolta considerato arcaizzante.
Scrivere «verisimile» non è un errore. È una scelta stilistica che può conferire un tono particolare al testo. Tuttavia, chi desidera adottare un registro neutro o quotidiano, sceglierà quasi sempre «verosimile».
Il caso di «verosimile» e «verisimile» mostra come la lingua italiana sia un sistema in continuo movimento, che permette spesso la convivenza di varianti nate dalla stessa radice ma sviluppatesi in modi differenti. La forma oggi standard è senza dubbio «verosimile», più scorrevole, più diffusa, più aderente alla pronuncia moderna. Ma «verisimile» continua a vivere come alternativa legittima, un’eco preziosa della tradizione latina e della storia linguistica italiana.
L’esistenza di queste due forme dimostra che la lingua non è solo comunicazione immediata, ma anche memoria, stratificazione, possibilità di scelta. In questo senso, la ricchezza di varianti come queste non è un ostacolo, ma una risorsa che permette all’italiano di essere più espressivo, più sfumato, più capace di raccontare il pensiero dei suoi parlanti attraverso il tempo.