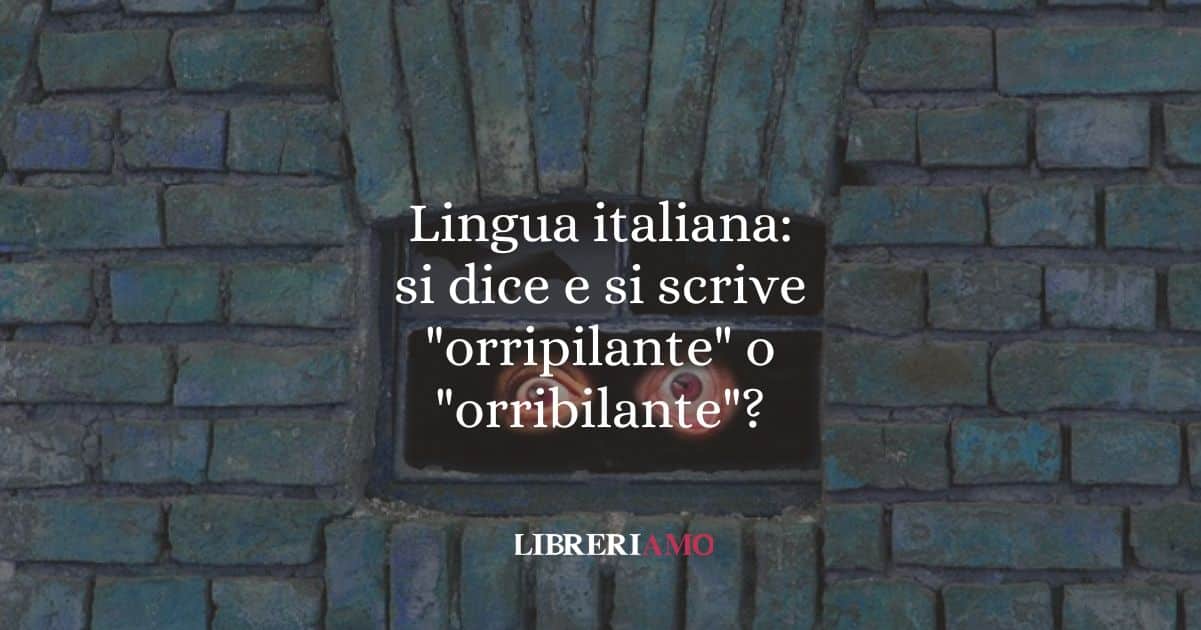La lingua italiana è attraversata da numerosi dubbi lessicali che riguardano soprattutto parole poco comuni, di uso meno frequente o caratterizzate da una struttura fonetica complessa. Uno di questi dubbi si concentra sull’aggettivo “orripilante”, che spesso viene confuso con una forma inesistente ma apparentemente plausibile: “orribilante”. La questione non è banale, perché rivela come la percezione dei parlanti sia fortemente influenzata dall’assonanza con termini più comuni, e come la tradizione etimologica della lingua abbia un ruolo determinante nel definire la forma corretta.
Etimologia e significato di “orripilante” nella lingua italiana
La forma corretta è, senza dubbio, orripilante. Essa deriva dal sostantivo orripilazione, che a sua volta risale al latino tardo horripilare, verbo composto da horrere (“rizzarsi”, “avere brividi”, “provare spavento”) e pilus (“pelo”). Letteralmente, dunque, “orripilare” significa “far rizzare i peli”.
Da questa base nasce il significato figurato e moderno di “orripilante”: qualcosa che provoca raccapriccio, che suscita un terrore tale da far “rizzare i capelli in testa”. L’aggettivo, quindi, mantiene un legame diretto con l’immagine fisica di un corpo che reagisce allo spavento con la pelle d’oca e i capelli eretti.
Perché nasce la confusione con “orribilante”?
La confusione deriva dal fatto che nella lingua italiana esiste l’aggettivo orribile, molto comune e di larghissimo uso. La vicinanza semantica tra “orribile” e “orripilante” (entrambi descrivono qualcosa di spaventoso, ripugnante, terrificante) induce molti parlanti a creare una forma intermedia o contaminata: orribilante.
Si tratta, quindi, di un classico caso di analogia linguistica. Poiché “orribile” è di gran lunga più frequente di “orripilazione” (parola ormai tecnica e rara), la mente dei parlanti tende a modellare l’aggettivo sul termine noto, dando vita a una variante che, pur sembrando plausibile, non ha alcun fondamento etimologico o storico.
Una questione di suono e frequenza
Un altro elemento che alimenta l’errore è il suono stesso delle due parole. Orripilante presenta la sequenza consonantica -pil-, che suona inconsueta e quindi percepita come meno “naturale”. Al contrario, orribilante appare più scorrevole e familiare, proprio perché richiama immediatamente orribile.
In realtà, la lingua non sempre privilegia la “facilità” fonetica. Talvolta conserva forme più dure e meno comuni proprio per rispettare la tradizione etimologica e il senso originario. Questo è il caso di orripilante, che mantiene vivo il legame con pilus (“pelo”), evitando di ridursi a un calco superficiale di orribile.
L’uso nella letteratura e nei testi
Se andiamo a cercare negli scrittori italiani, troviamo che “orripilante” è stato utilizzato in contesti letterari e giornalistici con la funzione di rafforzare il senso di raccapriccio. Ad esempio, nelle cronache di guerra o nei resoconti di eventi tragici, il termine è adoperato per descrivere scene particolarmente cruente.
Al contrario, “orribilante” non compare nei testi letterari né in dizionari seri della lingua italiana. È quindi un vero e proprio errore d’uso, probabilmente recente e figlio della diffusione colloquiale o di distrazioni grafiche. Non è raro, infatti, imbattersi in blog, social network o articoli non revisionati in cui “orribilante” appare come sinonimo di “orripilante”, ma si tratta sempre di usi non conformi alla norma.
La forza espressiva di “orripilante”
A differenza di orribile, che ha un uso ormai generalizzato e può riferirsi tanto a un vestito di cattivo gusto quanto a un delitto efferato, orripilante conserva una maggiore intensità semantica. Il termine non si applica a qualsiasi cosa spiacevole, ma piuttosto a ciò che provoca un brivido profondo, quasi fisico.
Dire che una scena è orripilante significa sottolineare l’effetto di sgomento e paura che essa suscita, molto più di quanto farebbe il semplice “orribile”. Non a caso, nel linguaggio giornalistico e mediatico, “orripilante” viene usato con valore enfatico per attirare l’attenzione del lettore, spesso associato a crimini efferati o immagini di grande impatto emotivo.
La prospettiva linguistica
Dal punto di vista linguistico, la vicenda di orripilante e della falsa variante orribilante è esemplare. Ci mostra come i parlanti tendano a semplificare o a ricondurre le parole meno comuni a strutture note, producendo così errori di analogia. Tuttavia, la norma linguistica, registrata nei dizionari e confermata dall’uso letterario, stabilisce chiaramente quale sia la forma corretta.
Inoltre, il mantenimento della sequenza -pil- permette alla parola di preservare il legame con la sua origine latina. In questo senso, l’italiano non è solo un mezzo di comunicazione immediata, ma anche un custode della memoria storica delle parole.