Lingua italiana: si dice “venirono” o “vennero”?
Molti verbi della lingua italiana hanno delle forme che si affiancano ad altre forme con lo stesso tempo e lo stesso modo, solo che sono errate.
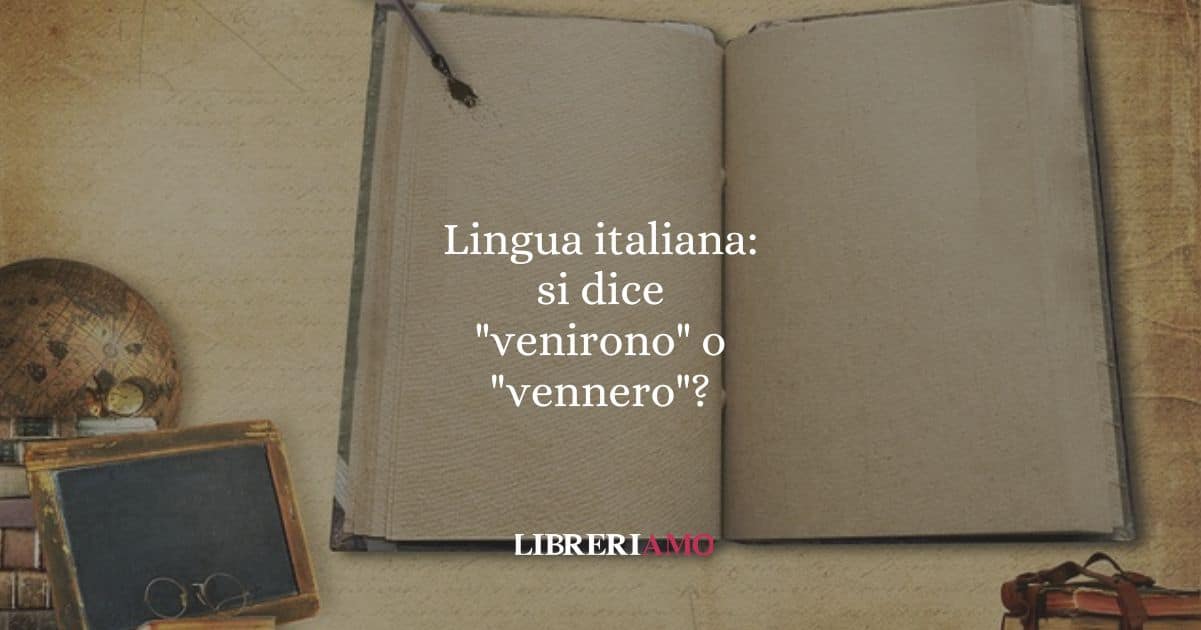
La lingua italiana conserva nel suo sistema verbale una serie di forme che, pur apparendo perfettamente intuitive in base ai modelli regolari, risultano invece scorrette, soprattutto quando ci troviamo di fronte ai verbi fortemente irregolari. Uno dei casi più ricorrenti riguarda il verbo “venire”, e in particolare la difficoltà, per alcune persone, di ricordare correttamente la forma del passato remoto. Così capita di chiedersi: si dice “vennero” o “venirono”? E quale delle due rispecchia realmente la tradizione grammaticale italiana?
Lingua italiana e tempi verbali
La risposta è chiara e non ammette eccezioni:
Le forme corrette sono “venni”, “venne”, “vennero”.
Sono scorrette “venii”, “venì”, “venirono”.
Nonostante ciò, l’errore è molto diffuso, tanto da meritare un’analisi più approfondita, che coinvolge la struttura del verbo, l’evoluzione linguistica e le interferenze analogiche con altri modelli verbali della nostra lingua.
Il passato remoto del verbo “venire”: un paradigma irregolare
Vediamo innanzitutto la coniugazione corretta al passato remoto:
-
io venni
-
tu venisti
-
egli venne
-
noi venimmo
-
voi veniste
-
essi vennero
Questa serie presenta una doppia particolarità:
-
rafforzamento consonantico (raddoppiamento) nella prima e terza persona singolare: venni, venne
-
forma tronca e rotonda nella terza persona plurale: vennero
È evidente quanto queste forme si distacchino dalla radice più riconoscibile del verbo, quella che incontriamo nell’infinito venire. Ed è proprio da questa distanza che nasce la tentazione di ricondurre il passato remoto a un modello più regolare, dando vita a forme scorrette ma “sentite” come plausibili.
Perché molti dicono (o scrivono) “venirono”?
L’errore “venirono” deriva da un processo molto comune nella lingua:
la spinta dell’analogia.
Chi apprende la lingua, o chi la usa spontaneamente senza ripensare alle regole, tende a ricondurre le forme irregolari verso schemi regolari. Così, avendo in mente verbi come:
-
sentire → sentirono
-
capire → capirono
-
finire → finirono
è facile immaginare che anche venire si comporti allo stesso modo:
→ venire → venirono
Ma il verbo “venire” appartiene al gruppo dei verbi fortemente irregolari, il cui passato remoto si è formato seguendo una logica storica distinta, ereditata dal latino tardo e da evoluzioni fonetiche peculiari. La forma “venirono”, dunque, non ha alcun fondamento nella tradizione letteraria né nell’uso contemporaneo corretto.
E le forme “venii” e “venì”? Da dove derivano?
Oltre a “venirono”, si incontrano talvolta anche due forme erronee:
-
io venii
-
egli venì
Anche in questo caso si tratta di iperregolarizzazioni: tentativi spontanei di riportare il verbo a un paradigma più semplice e prevedibile, come:
-
capire → capii
-
finire → finì
Ma il passato remoto dei verbi profondamente irregolari non procede per imitazione dei modelli regolari. La forma corretta resta quella che la storia della lingua ha consolidato: venni, venne.
La forza della tradizione letteraria
Una delle ragioni per cui non si può accettare l’uso di “venirono” è la solidità con cui la forma “vennero” ricorre nei testi della nostra letteratura, dai più antichi ai più moderni. Dante, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, Verga, Pirandello… tutti impiegano vennero, così come venni e venne. Questo fa del paradigma corretto non solo una norma grammaticale, ma un tratto profondamente radicato nella storia dell’italiano.
Il passato remoto, soprattutto nella tradizione letteraria, è una forma viva e importante: veicola narrazioni, dialoghi, cronache. L’irregolarità del verbo “venire” non è dunque un accidente o un capriccio linguistico, ma il frutto di un lungo processo di stabilizzazione.
Perché è importante mantenere le forme corrette?
Si potrebbe obiettare che la lingua è in continua evoluzione e che un giorno forme oggi considerate errate potrebbero diventare accettabili. È vero: la storia linguistica è fatta di trasformazioni, semplificazioni e spostamenti. Tuttavia, nel caso specifico di “venirono”:
-
l’uso è ancora percepito come un errore grave, anche da parte di parlanti non specialisti;
-
non esiste una tradizione scritta che lo avvalori;
-
non vi è necessità di introdurre una variante: vennero è chiaro, diffuso, stabile.
Inoltre, la capacità di riconoscere e impiegare correttamente le forme irregolari rappresenta un indice di padronanza della lingua, sia nello scritto sia nel parlato.
La scelta tra “vennero” e “venirono” non lascia spazio a dubbi: la sola forma corretta è “vennero”, così come “venni” e “venne” sono le uniche opzioni legittime per le corrispondenti persone del passato remoto. Le varianti “venirono”, “veniì” e “venì” non appartengono alla norma e nascono da un tentativo comprensibile, ma infondato, di rendere il verbo regolare.
Rispettare la forma corretta significa non solo evitare un errore, ma riconoscere l’eredità di un verbo che attraversa la storia dell’italiano nella sua peculiarità e nella sua ricchezza. In una lingua in cui il passato remoto ha ancora un peso culturale e narrativo, preservare l’irregolarità di “venire” significa custodire un frammento della nostra tradizione linguistica.