Lingua italiana: si dice “familiare” o “famigliare”?
Scopriamo assieme quale, secondo le norme della lingua italiana, è la forma corretta o se lo sono entrambe, tra “familiare” e “famigliare”.
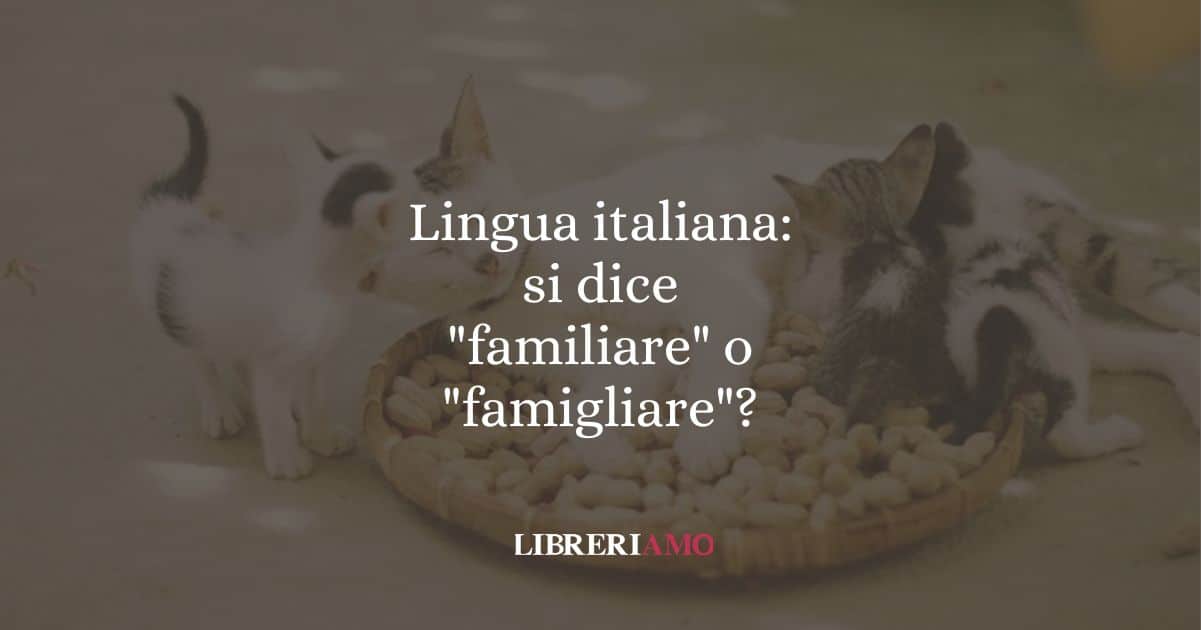
Nella lingua italiana poche coppie di parole generano tante esitazioni quanto “famigliare” e “familiare”. Due forme graficamente quasi identiche, due pronunce simili, due significati che nella maggior parte dei contesti coincidono perfettamente. Eppure, tra i due termini esiste una storia linguistica complessa, fatta di evoluzioni fonetiche, oscillazioni d’uso, preferenze regionali e interventi normativi. Oggi, entrambe le forme sono corrette, ma il loro uso rivela molto sul modo in cui la lingua italiana si è sviluppata nei secoli, tra tradizione scritta e parlata quotidiana.
Lingua italiana e forme colloquiali
Tutto parte dal latino familiaris, aggettivo derivato da familia, che indicava non solo il nucleo parentale, ma anche l’insieme dei servi e delle persone che vivevano sotto uno stesso tetto. In latino, familiaris significava “che appartiene alla casa, al focolare domestico”, e, in senso figurato, “intimo, confidenziale”. Da qui discendono entrambi i nostri aggettivi italiani: familiare e famigliare.
Nel passaggio dal latino all’italiano, la parola familia diede origine a famiglia, con l’aggiunta di una -g- e un cambiamento fonetico tipico della nostra lingua. Da familiaris, invece, derivò direttamente familiare, che mantenne la forma più vicina al latino. Quando, però, si diffuse la forma “famiglia” per il nome, era naturale che alcuni parlassero anche di “famigliare”, per analogia morfologica. In altre parole, famigliare nacque come una variante “popolare” o “analogia spontanea”, costruita sul sostantivo moderno famiglia.
Una doppia forma da secoli
Le due forme — “familiare” e “famigliare” — convivono da molti secoli. Nei testi antichi si trovano entrambe, spesso usate indifferentemente. Scrittori illustri come Boccaccio, Ariosto e Machiavelli utilizzavano “famigliare”, mentre altri, come Tasso o Manzoni, preferivano “familiare”. Questa oscillazione non fu mai veramente risolta, perché entrambe le forme risultavano legittime: una più colta e vicina al latino, l’altra più popolare e coerente con la forma del sostantivo “famiglia”.
Nel corso dell’Ottocento e del Novecento, la grammatica e la lessicografia cercarono di regolare questa doppia presenza. I vocabolari più normativi tendevano a preferire familiare, considerandolo più “puro”, mentre famigliare veniva segnalato come forma “popolare” o “meno corretta”. Tuttavia, nella lingua d’uso, “famigliare” non è mai scomparso, anzi — ha continuato a vivere nel parlato e in molti contesti regionali, specie nell’Italia centrale e meridionale.
Dal punto di vista del significato, non esiste una differenza semantica stabile tra familiare e famigliare. Entrambe le forme possono significare:
-
Che riguarda la famiglia (“problema familiare” o “problema famigliare”);
-
Intimo, conosciuto, abituale (“un volto familiare”);
-
Confidenziale, amichevole (“un tono familiare”);
-
Persona di casa, servitore, membro della corte (uso arcaico: “i famigliari del re”).
Nella lingua comune contemporanea, però, si è creata una sfumatura d’uso: “familiare” tende a essere la forma più neutra e formale, usata in contesti scritti, ufficiali o standard (“ambiente familiare”, “medico di base familiare”), mentre “famigliare” appare più colloquiale, legata al parlato o a testi letterari di tono affettivo. È una distinzione che ha più a che fare con la percezione linguistica che con una vera differenza di significato.
Gli esempi lo mostrano bene. In un testo scientifico o burocratico si leggerà più facilmente “legami familiari”, mentre in una lettera o in un racconto narrativo può suonare più naturale “legami famigliari”. Anche la scelta dipende dal registro: “familiare” è oggi considerato standard in tutta Italia, ma “famigliare” conserva una sfumatura più calda, più domestica, che la lingua letteraria a volte preferisce proprio per ragioni espressive.
I dizionari e la norma attuale
Le principali autorità linguistiche italiane riconoscono oggi entrambe le forme come corrette.
Il Vocabolario Treccani registra sia familiare che famigliare, specificando che la seconda è “variante legittima e antica della forma più comune”.
Anche la Crusca, in più occasioni, ha confermato che famigliare non è un errore, ma una variante etimologicamente giustificata, derivante dall’adattamento morfologico al sostantivo famiglia.
Lo stesso Devoto-Oli sottolinea che l’uso di famigliare non deve essere censurato, anche se familiare resta la forma preferita nello standard.
In ambito scolastico, però, per ragioni di uniformità e chiarezza, si consiglia generalmente l’uso di “familiare”, specie negli scritti formali. Ma questa preferenza non implica la scorrettezza dell’altra forma: semplicemente, familiare è oggi la variante di prestigio, quella che appare più neutra e meno marcata.
La convivenza di famigliare e familiare racconta qualcosa di profondo sulla lingua italiana: la sua naturale tendenza alla varietà e alla coesistenza di forme diverse. La lingua non è mai monolitica: accoglie al suo interno voci colte e voci popolari, oscillazioni che riflettono i diversi livelli sociali, regionali e stilistici dei parlanti.
Nel caso di “famigliare” e “familiare”, questa doppia forma diventa simbolo di un equilibrio tra etimologia e analogia, tra la fedeltà alla radice latina e la spontaneità dell’uso moderno. È un perfetto esempio di come la lingua viva nella tensione fra regola e realtà, fra la norma scritta e la parola quotidiana.