Lingua italiana: si dice “bassa durata” o “breve durata”?
Scopriamo assieme se secondo le norme della lingua italiana “bassa durata” e “breve durata” hanno la stessa valenza.
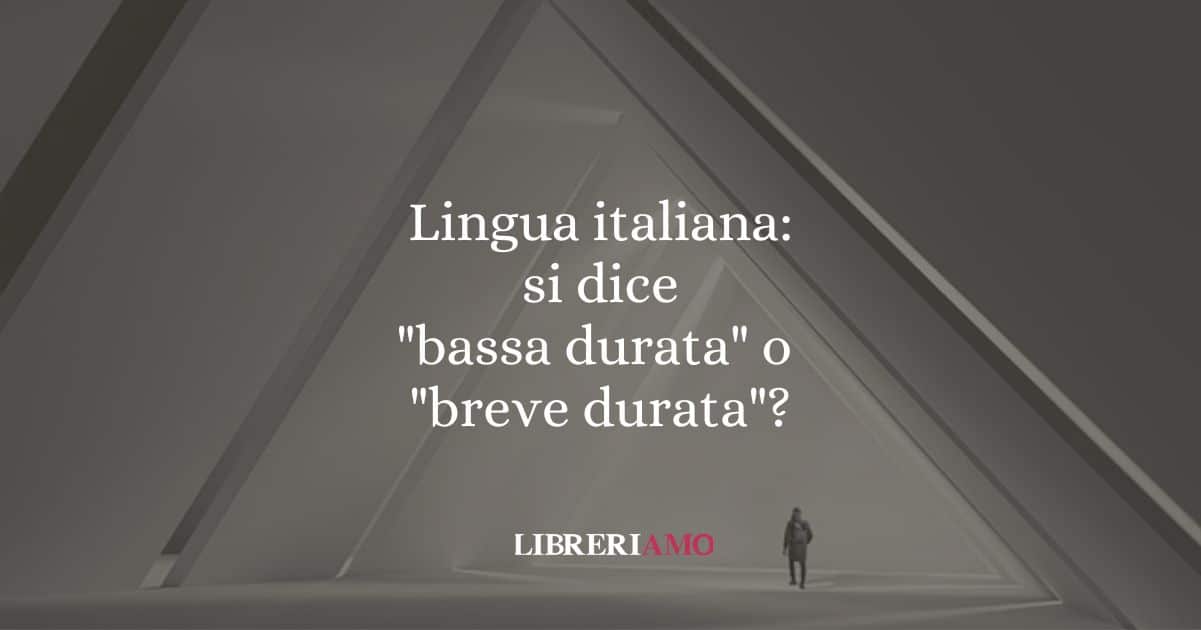
L’osservazione linguistica sull’uso di “breve durata” e “bassa durata” è un esempio illuminante di come la lingua italiana, nella sua naturale evoluzione, segua criteri di coerenza semantica e di uso reale, piuttosto che astratte regole di logica o di economia formale. La questione non è soltanto di preferenza stilistica: riguarda il modo in cui l’italiano — come ogni lingua viva — costruisce i propri significati attraverso convenzioni, metafore e associazioni storiche. E, come mostrano i dati empirici raccolti da diversi corpora linguistici, l’espressione corretta, naturale e comunemente usata è senza dubbio “breve durata”, mentre “bassa durata” risulta praticamente inesistente nell’uso reale.
L’evidenza dell’uso nella lingua italiana
Gli studi condotti su fonti giornalistiche e corpora digitali sono inequivocabili. In dieci anni di “La Stampa” (dal 1992 al 2001) si contano quasi 400 occorrenze di “breve durata” e nessuna di “bassa durata”. Nel corpus giornalistico La Repubblica SSLMIT, messo a disposizione dall’Università di Bologna, le proporzioni sono analoghe: 629 attestazioni per “breve durata” contro zero per “bassa durata”. E anche nel corpus RIDIRE dell’Università di Firenze, che raccoglie testi vari dal web, la sproporzione è schiacciante: 2.650 casi di “breve durata” contro appena 6 di “bassa durata**.
Questi dati confermano che non si tratta di una semplice preferenza stilistica, ma di una vera e propria norma d’uso consolidata: chi dice “breve durata” parla un italiano perfettamente corretto e naturale; chi usa “bassa durata”, invece, forza il lessico in un modo che non appartiene al sistema della lingua.
Perché “breve durata” funziona e “bassa durata” no
Per comprendere questa asimmetria, bisogna spostarsi dal livello dell’uso empirico a quello semantico. L’aggettivo “breve”, in italiano, deriva dal latino brevis, e significa originariamente “di poca estensione nello spazio”. Da questo significato primario — spaziale — si è sviluppato, per metafora, quello temporale: una “strada breve” è una strada corta, e dunque un “tempo breve” è un tempo che dura poco. La metafora spaziale-temporale è universale nelle lingue del mondo: come notavano Lakoff e Johnson (1980), il tempo viene quasi sempre concettualizzato in termini spaziali. Si dice, infatti, che un periodo è “lungo” o “breve”, una stagione è “vicina” o “lontana”, il passato è “dietro” e il futuro “davanti” — anche se, in alcune culture come quella Aymara, l’orientamento si inverte.
L’aggettivo “basso”, invece, deriva dal latino bassus e indica “di poca altezza”. La sua estensione metaforica ha seguito un percorso diverso: in italiano “basso” non è usato per misurare il tempo, ma piuttosto per indicare valore, intensità o livello. Si dice, per esempio, “bassa temperatura”, “basso prezzo”, “basso livello culturale”, “basso profilo”. L’uso metaforico di “basso” si è quindi specializzato in campi semantici legati alla quantità o alla qualità, non alla durata temporale.
Ne consegue che “bassa durata” risulta incongruente: applica un aggettivo legato alla dimensione verticale a un nome — durata — che appartiene alla dimensione temporale orizzontale. “Breve durata”, invece, rispetta la metafora convenzionale che collega tempo e spazio lineare.
Il mito della lingua “economica”
Chi critica l’espressione “breve durata” sostiene che l’aggettivo “breve” sia ridondante, poiché il concetto di “tempo” è già implicito nella parola “durata”. Questa obiezione, apparentemente logica, si fonda sull’idea ingenua che la lingua debba funzionare “all’osso”, senza ripetizioni né ridondanze. Ma la lingua naturale non è un sistema matematico: è un organismo complesso, pieno di sovrapposizioni, sfumature e ridondanze funzionali.
Già Ferdinand de Saussure e, successivamente, Louis Hjelmslev distinguevano tra piano paradigmatico (le scelte tra parole alternative) e piano sintagmatico (le combinazioni delle parole). L’idea di evitare ogni ripetizione — come dire che “breve durata” è superfluo — nasce da una concezione analogista della lingua, che pretende un rapporto biunivoco tra forma e significato (il cosiddetto principio del One Meaning – One Form). Ma le lingue reali non funzionano così.
Come osserva Maria Thornton (2012), la nostra tendenza a volere un solo modo “giusto” per dire qualcosa è erede di un atteggiamento “manzoniano”, volto a stabilire una forma unica e pura. Eppure la varietà, la ridondanza e la polisemia sono tratti fondamentali del linguaggio. Dire “breve durata” non è come dire “giovane ragazza” o “entrare dentro”: in questi ultimi casi la ripetizione è davvero tautologica, mentre in “breve durata” l’aggettivo aggiunge una specificazione qualitativa, un’intensità semantica.
Le “restrizioni di selezione” e la coerenza semantica
Dal punto di vista linguistico, “breve durata” rispetta perfettamente le cosiddette restrizioni di selezione: cioè l’accordo semantico tra aggettivo e nome. “Breve” si lega naturalmente a sostantivi che indicano tempo o lunghezza — come pausa, attesa, vita, giorno — mentre “basso” si lega a sostantivi che implicano un’idea di altezza, livello o misura verticale — come muro, tavolo, montagna, tono. La lingua, insomma, “sa” quali combinazioni sono appropriate.
Chi dice “breve durata” segue una norma linguistica invisibile ma solidissima: quella della compatibilità semantica. Dire “bassa durata”, invece, produce un effetto di dissonanza: come dire “corto prezzo” o “leggera altezza”. Non è un errore grammaticale, ma è una scelta estranea alla logica profonda dell’italiano.
La lingua come sistema metaforico
In definitiva, “breve durata” e “bassa durata” non sono due sinonimi da scegliere in base al gusto, ma due espressioni che si collocano su piani semantici diversi. Solo la prima appartiene alla rete metaforica su cui si costruisce il modo italiano di concepire il tempo.
Ogni lingua possiede la propria architettura metaforica, un sistema di corrispondenze inconsce che collegano lo spazio, il tempo, la quantità e il valore. “Breve durata” è un’espressione che nasce da questa architettura: deriva dalla percezione del tempo come linea, non come altezza. “Bassa durata”, invece, tenta di piegare la lingua a una logica estranea al suo funzionamento naturale.