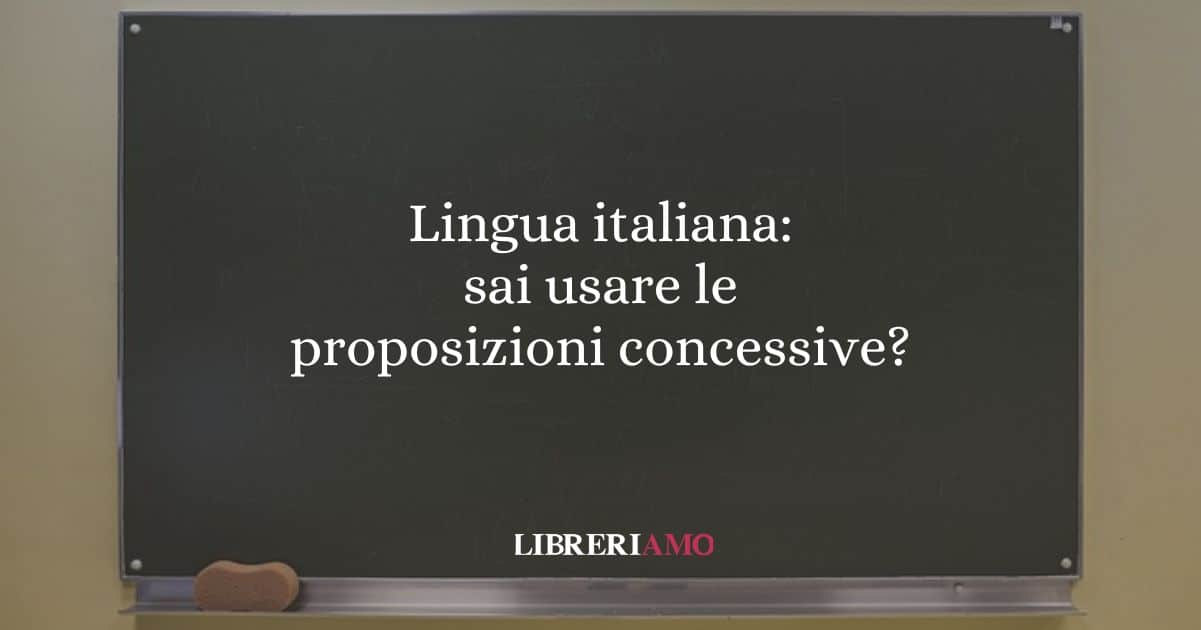Le proposizioni concessive rappresentano una tipologia particolare di subordinate della lingua italiana, che introducono nel discorso un elemento di contrasto, ponendo in evidenza il mancato verificarsi dell’effetto che ci si aspetterebbe in base a una determinata causa, reale o supposta. In altre parole, esse esprimono una frattura logica nel rapporto causa-effetto: alla premessa contenuta nella concessiva corrisponde un risultato inatteso nella proposizione principale. Un esempio tipico è: Benché sia ricco, vive poveramente. Qui, l’essere ricco costituirebbe di norma una condizione che porta a vivere agiatamente, ma la principale smentisce questa logica, generando un effetto di sorpresa o di opposizione semantica.
Questo tipo di legame sintattico è considerato più complesso e astratto rispetto ad altre forme di subordinazione. Dal punto di vista storico, le congiunzioni concessive si sono sviluppate tardi, passando dal latino alle lingue romanze, e sono risultate meno frequenti sia nel parlato informale sia nei testi scritti dei semicolti. Nella lingua popolare, infatti, il contrasto fra due fatti è spesso espresso tramite coordinazione avversativa: Vive poveramente, ma è ricco.
Lingua italiana: tipologie di proposizioni concessive
Le concessive possono essere esplicite o implicite:
-
Esplicite: contengono un verbo di modo finito (congiuntivo, indicativo o condizionale) e sono introdotte da congiunzioni (benché, sebbene, quantunque, anche se, per quanto, ecc.), locuzioni congiuntive o, in certi casi, da avverbi o pronomi indefiniti.
-
Implicite: presentano il verbo all’infinito, al participio o al gerundio, come in: Pur essendo stanco, continuò a lavorare.
L’uso dei modi verbali
Il congiuntivo è il modo tipico nelle concessive esplicite, in tutti i suoi tempi, soprattutto quando la subordinata precede la principale. L’indicativo, invece, è frequente dopo anche se e, meno spesso, dopo tutto che. Con benché e simili, l’indicativo può comparire quando la concessiva è posposta e ha un tono di aggiunta autonoma, con valore vicino a quello di una congiunzione avversativa (ma, tuttavia). Ad esempio, Manzoni nei Promessi Sposi scrive: … benché la poveretta se ne pentì poi, con l’indicativo pentì.
Nella lingua familiare e nell’italiano antico l’indicativo nelle concessive era più tollerato: Sciascia scrive benché evitava di dichiararlo; Alamanni usa quantunque molto gli dispiace. L’indicativo futuro è sempre possibile per indicare un’azione posteriore rispetto alla reggente: Benché forse per me ne dipenderà la perdita di una cara compagnia.
Il condizionale appare quando sarebbe previsto anche in una frase indipendente, ad esempio con valore eventuale: Farò un solo esempio, benché se ne potrebbero fare centomila. Qui la concessiva presuppone una protasi implicita (…se si volesse).
Le concessive indipendenti
Esiste anche una forma di concessiva priva di congiunzione introduttiva, detta indipendente. In questi casi il verbo è spesso rafforzato da anche o pure, ed è espresso al futuro semplice o anteriore, oppure al congiuntivo. La principale è solitamente introdotta da una congiunzione avversativa. Ad esempio: Venezia sarà bellissima, non discuto, però non mi ci trovo (= benché Venezia sia bellissima). Questa costruzione ha una forte componente emotiva, poiché il parlante ammette un fatto, ma lo considera irrilevante rispetto alla conclusione.
Concessive nominali
Accanto alle concessive verbali esistono le concessive nominali, in cui la congiunzione introduce un sintagma nominale o aggettivale. Due i casi principali:
-
Ellissi del verbo essere: Benché vecchio, è ancora in gamba (= benché sia vecchio).
-
Ellissi di un verbo presente nella reggente: … sebbene con minore evidenza, l’arte dello scrittore fiorentino (= sebbene la rivelino con minore evidenza).
Funzione comunicativa
L’uso delle concessive non è solo un fatto grammaticale, ma anche retorico. Servono a introdurre un elemento di incertezza, a mostrare complessità nel ragionamento e a sfumare l’argomentazione, evitando contrapposizioni nette. Hanno una funzione dialogica, perché ammettono un punto di vista per poi ribaltarlo.
Se le proposizioni causali spiegano perché un fatto accade, le concessive spiegano malgrado cosa un fatto accade. In questo senso, sono uno strumento raffinato della lingua, capace di creare contrasti sottili e di arricchire la struttura del discorso.
In sintesi, le concessive sono meno comuni rispetto ad altre subordinate, ma rivestono un ruolo importante nell’italiano scritto e parlato colto. Con la loro capacità di spezzare il legame lineare causa-effetto, conferiscono sfumature e profondità alla comunicazione, rivelando la complessità dei rapporti fra i fatti e la relatività delle interpretazioni possibili.