Lingua italiana: sai cosa significa l’arcaico “mover piato”?
Scopriamo assieme il significato di un’espressione della lingua italiana che ormai è diventata più che rara: mover piato.
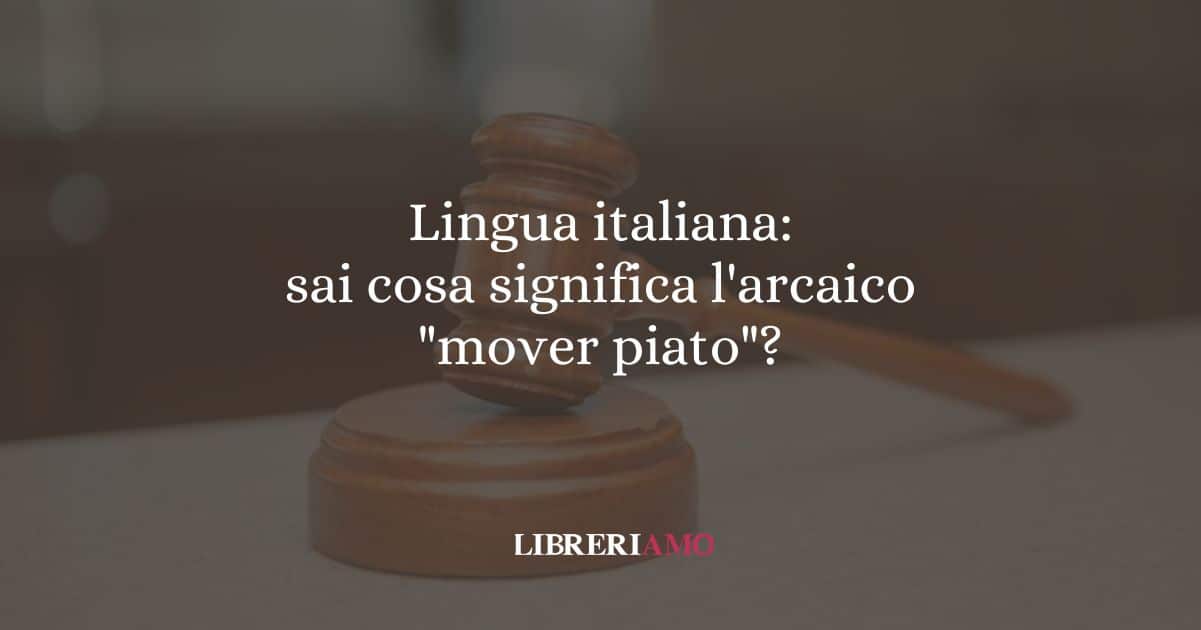
La lingua italiana, come tutte le lingue vive, conserva nei suoi archivi espressioni che nel tempo hanno perso l’uso quotidiano, rimanendo però a testimoniare non solo una fase storica della comunicazione, ma anche modi di pensare e di concepire la realtà diversi dai nostri. Una di queste espressioni è “mover piato”, che significa letteralmente “fare causa”, intraprendere un’azione legale contro qualcuno.
Il sintagma ricorre in autori medievali e rinascimentali, ma la sua eco giunge fino all’Ottocento, quando Alessandro Manzoni, nella poesia Sulla poesia, scrive: “Vo’ mover piato, e mio legal t’eleggo”. Con queste parole il poeta evoca, in forma scherzosa e ironica, la terminologia giuridica antica, attribuendo alla poesia stessa la dimensione di un contenzioso da difendere in tribunale.
Origini della parola “piato” e dell’espressione della lingua italiana “mover piato”
Per comprendere il significato di “mover piato” bisogna soffermarsi sul termine piato. Esso deriva dal latino placitum, participio passato di placere, “piacere, stabilire, decretare”. Con il tempo, nel latino medievale placitum assunse il senso di “decisione giuridica, giudizio, sentenza”, fino a indicare anche l’assemblea o il tribunale in cui si emetteva una sentenza.
In volgare italiano, piato venne a significare “causa, lite, contesa giudiziaria”. Non è un caso che nel diritto longobardo e poi nei testi comunali dell’Italia medievale, il termine sia largamente attestato: il piato era l’atto stesso del contendere in tribunale. Ancora Dante, nel Convivio e altrove, utilizza piato con questo valore. L’espressione “mover piato”, dunque, non è altro che “dare avvio a una lite”, promuovere un procedimento giudiziario.
Dall’aula del tribunale alla letteratura
La fortuna di piato nella letteratura italiana è significativa. Se oggi la parola è pressoché desueta, nei secoli passati costituiva un termine comune per indicare dispute non solo giuridiche, ma anche morali e intellettuali.
Ad esempio, nei testi poetici medievali e rinascimentali, “piato” può comparire in senso figurato per indicare una disputa ideale, una lotta tra valori o concetti astratti. Così, l’atto di “movere piato” non è soltanto l’avvio di un procedimento legale, ma anche l’apertura di un contenzioso culturale o poetico, una dichiarazione di battaglia intellettuale.
Il caso di Manzoni
Manzoni recupera questo arcaismo nella poesia Sulla poesia. Il verso “Vo’ mover piato, e mio legal t’eleggo” va letto come una provocazione scherzosa ma anche come dichiarazione programmatica: il poeta, rivolgendosi alla Musa o a un amico, elegge un difensore, quasi un avvocato, per sostenere le proprie ragioni in una “causa” che riguarda la poesia stessa.
L’uso di un’espressione antiquata e solenne, appartenente alla tradizione giuridica medievale, non è casuale. Manzoni, autore sempre attento al peso delle parole, intendeva probabilmente sottolineare con ironia quanto la poesia, nell’Ottocento, fosse oggetto di dibattiti e contrapposizioni quasi legali. “Mover piato” diventa così una metafora del discutere appassionato, dello scontro di idee e di poetiche, tipico di un’epoca in cui la letteratura non era solo estetica, ma anche questione di verità e di responsabilità.
Il valore arcaico e la perdita d’uso
Oggi la formula “mover piato” non è più usata e, se compare, lo fa in contesti colti o in citazioni letterarie. L’evoluzione della lingua ha sostituito piato con termini come “causa”, “processo”, “lite”. L’espressione, quindi, appare come un fossile linguistico: ci parla di un tempo in cui la lingua italiana, ancora fortemente radicata nei prestiti latini e nel linguaggio giuridico medievale, aveva un lessico diverso e più vicino alle pratiche concrete delle assemblee e dei tribunali.
La ragione di questo declino è chiara: con la modernizzazione della giustizia e del linguaggio burocratico, piato è stato sostituito da voci più tecniche, mentre nella lingua comune prevalevano parole di uso quotidiano. Tuttavia, proprio per il suo sapore arcaico, il termine è stato talvolta recuperato in letteratura per evocare un tono solenne o per giocare con l’allusione storica.
L’importanza dei fossili linguistici
Studiare espressioni come “mover piato” ci aiuta a comprendere come la lingua italiana sia frutto di stratificazioni, sovrapposizioni e continui cambiamenti. Ogni arcaismo conserva tracce di usi sociali, di istituzioni e di mentalità che altrimenti rischierebbero di cadere nell’oblio.
Nel caso specifico, l’espressione ci restituisce l’immagine di una società medievale e rinascimentale in cui la dimensione giuridica permeava fortemente la vita quotidiana, al punto che termini come piato erano familiari a tutti. E ci ricorda anche quanto la letteratura si nutra di tali lessici, riprendendoli, trasformandoli e infine consegnandoli alla memoria culturale, come fece Manzoni nell’Ottocento.
“Mover piato” è molto più che un semplice arcaismo: è un frammento di storia linguistica e culturale. Nato dal latino placitum e sviluppatosi nei tribunali medievali, ha avuto lunga vita nella lingua letteraria, fino a giungere a Manzoni, che lo recupera per dare forza e ironia a un discorso sulla poesia.
Oggi la formula è un’espressione inattuale, destinata a pochi cultori della lingua. Ma il suo valore simbolico rimane intatto: ricorda che la lingua non è mai statica, che ogni parola porta con sé una vicenda secolare, fatta di usi, trasformazioni e significati che mutano col tempo. E ci insegna che persino un’antica causa, un “piato” ormai dimenticato, può ancora raccontare qualcosa di noi e del nostro modo di intendere la parola, la letteratura e la giustizia.