Lingua italiana: quando utilizzare l’articolo “il” e quando “lo”
Scopriamo tramite questo articolo quando, seguendo le norme della grammatica e lingua italiana adoperare l’articolo “il” e quanto l’articolo “lo”.
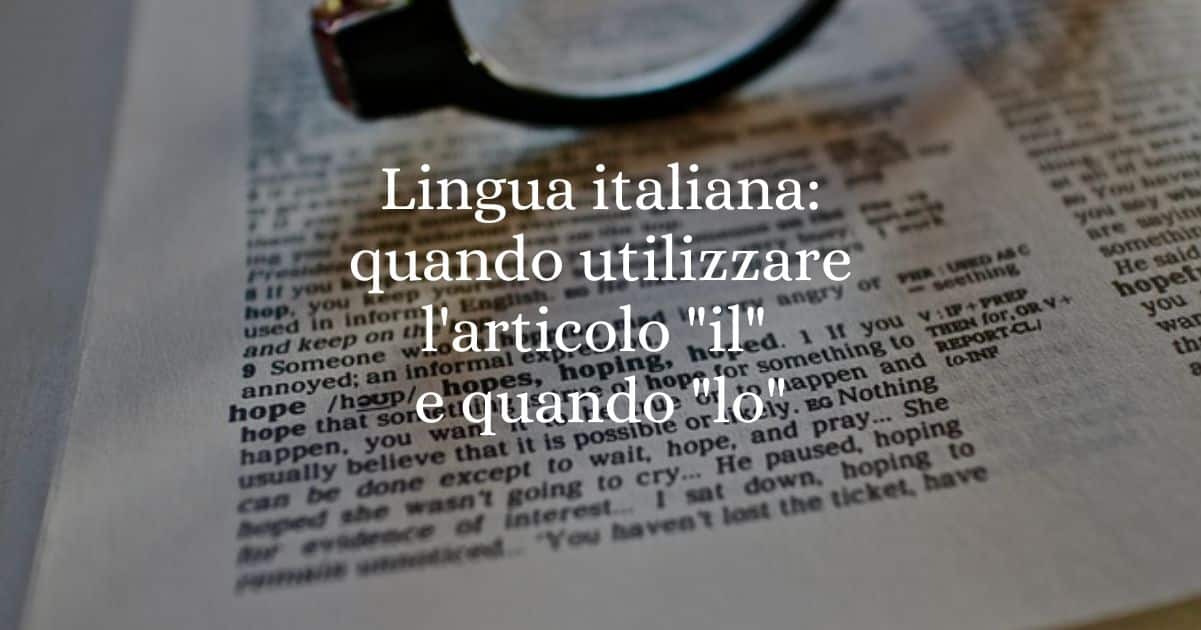
Nel panorama della grammatica e, in generale, lingua italiana, poche questioni sembrano così semplici e al tempo stesso così scivolose come la scelta tra gli articoli determinativi “il” e “lo”. Apparentemente scontata per chi parla fluentemente la lingua, questa scelta si rivela invece il risultato di un’evoluzione storica complessa, di criteri fonetici ben precisi e, non da ultimo, di usi variabili e in parte ancora instabili. Un viaggio nella loro storia e nella loro logica d’impiego ci permette non solo di comprendere meglio la norma attuale, ma anche di cogliere come la lingua italiana viva in un equilibrio continuo tra tradizione e innovazione. Analizziamo il tema con l’ausilio dell’illuminante saggio di Alfonso Leone Conversazioni sulla lingua italiana
Uso attuale nella lingua italiana: la regola fonetica
La distinzione tra “il” e “lo” si fonda oggi prevalentemente su criteri di eufonia: cioè, si cerca di evitare incontri consonantici duri, difficili da pronunciare. Per questo:
-
“Lo” si usa davanti a:
-
parole che iniziano con s + consonante (es. lo spirito, lo schema);
-
parole che iniziano con z (es. lo zio);
-
parole con gn (es. lo gnomo);
-
parole con ps e pn (es. lo pseudonimo, lo pneumatico);
-
parole che iniziano con x, letta come “cs” (es. lo xenofobo).
-
L’articolo indeterminativo “uno”, e l’aggettivo “bello” quando posto davanti al nome (e quindi soggetto alle stesse regole degli articoli), seguono la stessa logica (uno scemo, uno zaino, un bello spirito).
-
“Il” si usa in tutti gli altri casi davanti a consonante (es. il gatto, il treno, il libro), mentre “l’” si adopera davanti a vocale (l’amico, l’elefante), sia per il maschile che per il femminile.
La storia: “lo” in età antica e letteraria
Tuttavia, questo assetto moderno non è sempre stato tale. In italiano antico, l’uso di “lo” era più esteso. Grandi autori come Dante scrivevano “lo giorno”, “lo bello stile”, e la forma “lo” era comune anche prima di parole che oggi richiederebbero “il” secondo le regole attuali.
Questa estensione di “lo” è proseguita anche nell’Ottocento, come dimostrano esempi poetici in cui si legge “per lo libero ciel” (Leopardi). La scelta di “lo” non rispondeva solo a motivi fonetici, ma anche ritmici, metrici e stilistici. Alcune forme cristallizzate di quell’uso sopravvivono ancora oggi: per lo meno, per lo più, o locuzioni come gabbato lo santo.
Zone di confine e variazioni letterarie
La regola fonetica attuale, sebbene largamente rispettata, non è assoluta. Esistono zone di confine, sia linguistiche sia geografiche, dove si affacciano varianti legittime, o almeno attestate. Così, in Emilia Romagna, si dice ancora lo suocero, perché la “u” iniziale ha una pronuncia quasi consonantica che richiama la logica dell’“s impura”.
Nel corso del tempo, alcuni scrittori hanno “sfidato” la norma ufficiale per ragioni stilistiche, espressive o per riflettere tratti dialettali. Così troviamo:
-
i sguardi (Fornaciari),
-
i scivoloni (Pavese),
-
il gnomo (Pascoli),
-
coi zoccoli (Pea),
-
un bel zero spaccato (Martini).
Questi usi, sebbene non accettati dalla norma grammaticale, testimoniano la fluidità del parlato e la vivacità della lingua letteraria, che talvolta predilige l’aderenza alla realtà linguistica o alle esigenze ritmiche più che alla grammatica codificata.
L’influenza della frequenza d’uso
Anche la frequenza d’uso di certe parole può influenzare la percezione dell’eufonia e rendere accettabili delle forme che in teoria infrangono la regola. Così si sente ormai comunemente il pneumatico, il psicologo, un xilofono. La consuetudine smussa lo stridore iniziale, rendendo “accettabili” o perlomeno diffuse soluzioni un tempo giudicate scorrette o cacofoniche.
Curiosità linguistiche: da “gl’iddei” a “gli dei”
Il caso di “gli dei” merita una nota particolare. Questa forma nasce da una lunga trasformazione fonetica e morfologica: da gl’iddei, dove iddèi era il plurale di iddio, a sua volta nato dalla fusione dell’articolo con il sostantivo (il dio → iddio). Questo meccanismo, chiamato concrezione o agglutinazione, ha dato origine a molte parole italiane, come l’alloro (da “la lauro”), o la Puglia (da “l’Apulia”).
Al contrario, altri termini hanno subito una discrezione, cioè una separazione tra articolo e parola, come lusignolo (da “l’usignolo”).