Lingua italiana: “performante” riferito alle persone, perché?
Scopriamo il significato della parola della lingua italiana “performante” e perché, purtroppo, viene sempre più accostata alle nostre vite.
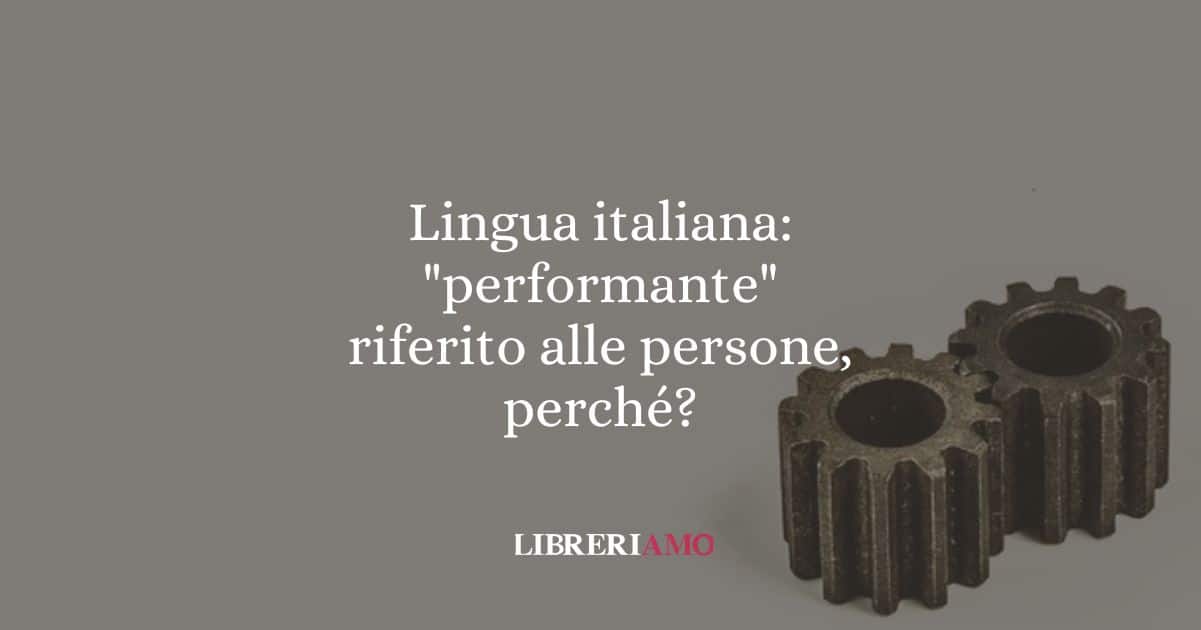
La parola “performante”, entrata nel lessico della lingua italiana a partire dall’ambito tecnico e sportivo, ha conosciuto negli ultimi decenni una trasformazione semantica profonda, tanto da essere oggi usata sempre più spesso per descrivere le persone e, più in generale, la loro vita. Originariamente, come registrano i dizionari, “performante” è un aggettivo che deriva dall’inglese to perform, ossia “compiere, eseguire”, e che in italiano ha assunto il significato di “che offre prestazioni di ottimo livello”. Si diceva dunque, e si dice ancora, di macchine, veicoli, strumenti tecnologici: “un motore altamente performante”, “un computer performante”, “un sistema performante”.
Tuttavia, a partire dagli anni Duemila, la parola ha iniziato a varcare i confini della meccanica e della tecnica per diventare un attributo dell’essere umano, e non più soltanto delle cose.
Oggi, dire che una persona è “performante” significa alludere a una condizione di efficienza, di rendimento, di produttività, ma anche, in senso più sottile, a un ideale di perfezione operativa che la società contemporanea tende a esigere da ciascun individuo. Il termine, nato per descrivere il motore di un’auto o l’efficacia di un software, è diventato così una misura dell’identità umana, un parametro del successo personale e professionale. Questa evoluzione linguistica è uno specchio fedele dei tempi: viviamo in un’epoca in cui le persone vengono valutate, spesso inconsciamente, con le stesse categorie usate per valutare le macchine.
Dalla macchina all’uomo: la metamorfosi dell’aggettivo della lingua italiana
L’aggettivo “performante” si è diffuso dapprima nel linguaggio aziendale e nel lessico del management, dove la metafora della “prestazione” si applicava facilmente anche ai lavoratori: si parlava di un “team performante”, di un “manager performante”, di una “strategia performante”. Da lì, il passo verso l’uso quotidiano è stato breve. Oggi si dice di una persona “molto performante” per intendere che è capace, energica, produttiva, efficiente, che sa ottenere risultati.
Ma l’uso umano del termine non è neutro. Mentre l’aggettivo “efficiente” rimandava a una qualità funzionale, “performante” introduce una dimensione di valutazione estetica e quasi competitiva. Non basta più essere bravi, bisogna essere performanti, cioè eccellere, distinguersi, apparire sempre al massimo delle proprie possibilità. La parola suggerisce dunque una tensione costante verso l’ottimizzazione di sé, una spinta a non fermarsi, a migliorare le proprie “prestazioni” non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata, nella cura del corpo, nei rapporti sociali.
La società della performance
L’estensione di “performante” al mondo umano non è casuale, ma riflette una trasformazione culturale profonda che molti studiosi hanno descritto come “società della performance”. In questo contesto, l’individuo è chiamato a mostrarsi sempre produttivo, brillante, in forma, proattivo. Il linguaggio assorbe e amplifica questa ideologia: dire di qualcuno che “è performante” diventa un complimento, ma anche un’etichetta che implica una certa pressione.
La parola porta con sé l’eco del verbo inglese to perform, che significa sì “eseguire”, ma anche “esibirsi”. E in effetti la vita contemporanea, filtrata dai social media e dai ritmi del lavoro globale, sembra diventare una performance continua. Si è performanti quando si lavora tanto, quando si mostra efficienza, quando si ottiene consenso. Il verbo “essere” si intreccia così con il verbo “rendere”: non basta più esistere, occorre performare.
Dietro questa trasformazione linguistica si cela un cambiamento antropologico. L’uomo “performante” è l’uomo che si misura costantemente con se stesso, che deve ottimizzare il proprio tempo, il proprio corpo, la propria emotività. È il soggetto che internalizza i criteri di efficienza della macchina e li applica alla propria esistenza.
L’ambiguità del termine
L’aggettivo “performante” vive dunque un’ambiguità di fondo. Da un lato, esprime un’aspirazione positiva: essere performanti significa dare il meglio di sé, mettere a frutto i propri talenti, perseguire l’eccellenza. È il linguaggio del merito, della crescita personale, della competenza. Dall’altro, però, nasconde una dimensione coercitiva, quasi disumanizzante: implica che il valore della persona dipenda dal rendimento, che l’errore o la lentezza equivalgano a un difetto meccanico.
La forza semantica della parola sta proprio in questa ambiguità: “performante” è un aggettivo che loda e, nello stesso tempo, giudica. È il segno di una società che ha fatto dell’efficacia il suo mito e che, pur di non smettere di funzionare, rischia di ridurre la vita a un algoritmo di risultati.
Dal motore al cuore
C’è un paradosso nel dire che un essere umano è “performante”: mentre un motore o un computer si valutano in base alla loro potenza o velocità, la vita umana si misura anche nella sua fragilità. Le pause, gli errori, le esitazioni fanno parte dell’esperienza e la rendono autentica. L’uso di “performante” per descrivere le persone tende invece a cancellare questa dimensione, come se la perfezione fosse una condizione naturale e permanente.
Ma l’essere umano, diversamente dalla macchina, non funziona sempre al massimo. Ha bisogno di fallire, di fermarsi, di ricominciare. Forse, allora, dovremmo riscoprire la distanza tra “performare” e “vivere”. Una vita “performante” non è necessariamente una vita felice, né una vita piena. Il linguaggio ci insegna molto su come guardiamo noi stessi: se cominciamo a descriverci come motori, rischiamo di dimenticare che siamo cuori, menti e relazioni, non solo meccanismi di produzione.
La parola “performante”, con la sua origine tecnica e il suo presente umano, rappresenta perfettamente la tensione del nostro tempo: il desiderio di superarsi e la paura di non essere all’altezza. È un aggettivo che illumina l’ossessione moderna per la prestazione, ma anche la sua fragilità nascosta.
Forse il compito del linguaggio, e della riflessione su di esso, è proprio questo: ricordarci che le parole non sono mai innocenti. Dire “performante” di una persona può essere un elogio, ma anche un monito. Significa riconoscere la forza di chi dà il meglio di sé, ma anche il rischio di ridurre la vita a una corsa senza tregua. In un mondo che misura tutto in termini di prestazione, l’unico vero atto di libertà è forse quello di rallentare, di restare umani — anche quando non siamo, e non vogliamo essere, performanti.