Lingua italiana: perché Gesù viene chiamato anche Rabbi?
Scopriamo assieme perché Gesù nel Nuovo Testamento viene appellato anche Rabbi e come questo termine sia entrato nella lingua italiana.
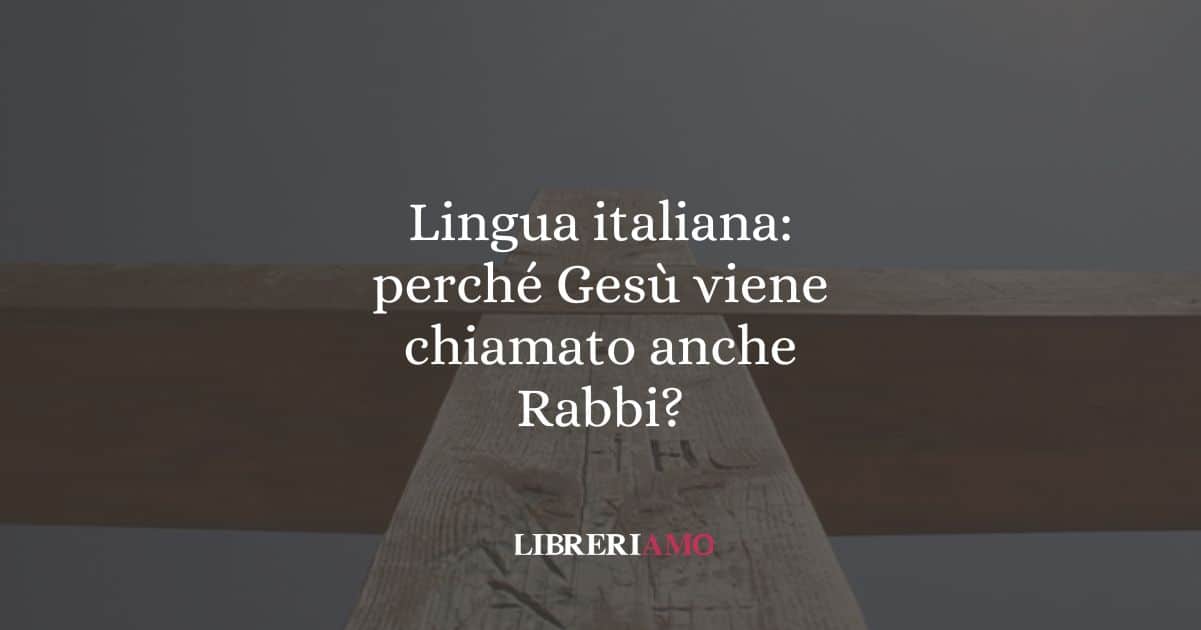
La parola “rabbi”, ormai presente anche nella lingua italiana, è una delle più dense di significato nella tradizione ebraica e, più in generale, nella storia delle lingue semitiche. Essa racchiude in sé un intero universo di valori, di rapporti sociali e di visioni del sapere. Deriva dalla radice trilittera r-b-b, che in molte lingue semitiche indica l’idea di grandezza, di autorità, di possesso. In arabo, il verbo rabba significa “essere il capo, governare, possedere”, ma è anche uno dei verbi più usati per parlare di Dio (ar-Rabb significa infatti “il Signore”).
In ebraico, la stessa radice dà origine a rabbī, termine che si può tradurre come “mio maestro” o “mio signore”, e che fin dai tempi antichi esprimeva rispetto, autorevolezza e sapienza.
Nel mondo ebraico antico, rabbī era il titolo riservato non solo ai maestri di religione, ma a qualunque persona dotata di un sapere riconosciuto o di una posizione di prestigio sociale. Si usava per rivolgersi a un anziano, a un giudice, a un capo di famiglia, ma anche a chiunque avesse insegnato qualcosa a qualcun altro. L’idea di fondo, dunque, non era semplicemente quella di un’autorità gerarchica, bensì quella di una figura che, attraverso l’insegnamento, trasmette una parte della propria esperienza e conoscenza agli altri.
Il rabbi era, in questo senso, il ponte tra la tradizione e il presente, tra la legge e la vita quotidiana, tra Dio e l’uomo.
Ebraico e lingua italiana
Il significato più profondo di rabbi si comprende davvero se lo si inserisce nel contesto storico e spirituale del popolo ebraico, in particolare dopo la diaspora. Con la perdita della terra promessa e la dispersione delle comunità ebraiche tra Oriente e Occidente, lo studio della Torah e della Halakhah (la legge ebraica) assunse un ruolo vitale. Senza una patria geografica, il popolo ebraico trovò nella conoscenza della legge e nella sua trasmissione un nuovo modo di esistere come collettività.
In questo senso, lo studio e l’insegnamento divennero molto più che attività intellettuali: divennero una forma di culto, un dovere spirituale e un gesto di resistenza culturale. Il maestro, il rabbi, non era solo colui che spiegava il significato dei testi, ma anche chi custodiva l’identità di un popolo in esilio. Lo studio divenne la nuova patria, il testo sacro il nuovo territorio da abitare. Come ha scritto Martin Buber, “l’ebraismo non vive in uno spazio, ma in un tempo e in una parola”.
Essere rabbi, allora, significava tenere accesa la fiamma della memoria. Insegnare era un atto politico e spirituale, un modo per rendere presente la promessa divina anche nell’assenza della terra. È in questa prospettiva che si comprende come la figura del rabbino sia diventata una delle più rispettate e carismatiche nella cultura ebraica.
Da Gesù ai maestri del Talmud
L’immagine del rabbi non appartiene soltanto alla tradizione ebraica in senso stretto: essa attraversa anche la storia del cristianesimo. Nei Vangeli, Gesù viene chiamato più volte rabbì dai suoi discepoli, nel significato di “maestro”. Questo appellativo non era un titolo sacerdotale, ma un segno di riconoscenza e di rispetto per colui che insegna, guida e illumina. Il fatto che Gesù fosse chiamato rabbi testimonia quanto fosse naturale, in quell’epoca, associare il sapere spirituale alla figura dell’insegnante.
Nel corso dei secoli, la tradizione rabbinica si è poi sviluppata in forme sempre più complesse. Dopo la distruzione del Secondo Tempio (70 d.C.), quando il culto sacerdotale divenne impossibile, furono proprio i rabbini a raccogliere l’eredità spirituale del popolo ebraico. Da loro nacquero le grandi scuole di pensiero che produssero il Talmud — letteralmente “studio” —, un’immensa opera di discussione, interpretazione e commento della legge.
In questo testo non c’è solo teologia, ma anche filosofia, diritto, medicina, poesia, aneddoti, e soprattutto un metodo: il dibattito. Il rabbi non è colui che impone, ma colui che interroga, che discute, che invita a pensare.
Il rabbino e il sacerdote: due figure diverse
È importante distinguere, tuttavia, la figura del rabbi da quella del kohen (sacerdote). Il kohen apparteneva a una specifica linea familiare, quella discendente da Aronne, e aveva funzioni cultuali: offriva sacrifici, officiava nel Tempio, presiedeva ai riti. Il rabbi, invece, non è un sacerdote, ma un maestro. Il suo ruolo non è rituale, ma educativo e spirituale. Egli interpreta la legge, la spiega, la rende viva nel quotidiano.
Questa distinzione spiega anche perché molti cognomi ebraici — come Cohen, Kagan, Katz — indichino l’origine sacerdotale di alcune famiglie, mentre il titolo di rabbi resta invece un riconoscimento di studio e di sapienza, non di nascita.
Il rabbino nella cultura moderna
Oggi la figura del rabbino mantiene una funzione di guida spirituale, ma anche di interprete del mondo contemporaneo. È un mediatore tra la tradizione e le domande del presente. Nella cultura popolare, il rabbi è spesso rappresentato con ironia e affetto: basti pensare all’umorismo ebraico dei film di Woody Allen, o alla figura enigmatica dei tre rabbini nel film dei fratelli Coen A Serious Man. Queste rappresentazioni, pur caricaturali, testimoniano come il rabbi sia diventato un simbolo riconoscibile di saggezza, di interrogazione incessante, di dialogo tra fede e ragione.