Lingua italiana: sai cosa sono le parole polirematiche?
Vediamo assieme cosa si intende quando si parla di polirematiche e che ruolo hanno nella lingua italiana.
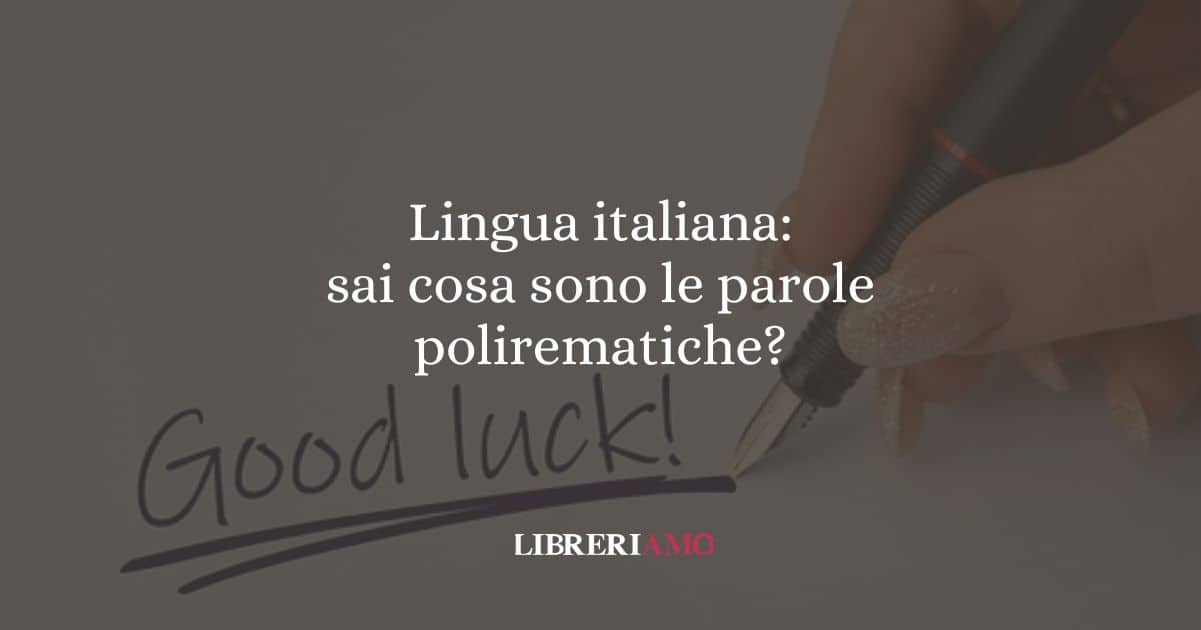
Le parole polirematiche rappresentano una delle componenti più affascinanti della lingua italiana. Con questo termine — introdotto e sistematizzato da Tullio De Mauro — si intendono quelle espressioni formate da più parole che, tuttavia, funzionano come un’unica unità di senso e di grammatica. Esempi di uso quotidiano ne sono anima gemella, carta di credito, giacca a vento, dare una mano, a fior di pelle: sequenze che, pur essendo composte da più elementi, non possono essere spezzate o modificate senza perdere il loro significato complessivo.
Lingua italiana: parole polirematiche
Le parole polirematiche, dette anche semplicemente polirematiche, occupano una posizione intermedia tra morfologia e sintassi. Non sono parole semplici, ma nemmeno sintagmi liberi: possiedono una coesione interna — sia strutturale sia semantica — che le rende paragonabili a veri e propri lessemi. In altre parole, il significato di una polirematica non si ottiene semplicemente sommando i significati delle singole parole che la compongono.
Prendiamo, ad esempio, l’espressione luna di miele: la sua interpretazione non deriva dalla combinazione letterale dei termini “luna” e “miele”, ma da un senso figurato, convenzionale, che la lingua ha fissato come unità. Lo stesso vale per colpo di fulmine, acqua e sapone, punto di vista: tutte espressioni che il parlante percepisce come un tutt’uno.
De Mauro, nel suo Grande Dizionario Italiano dell’Uso (GRADIT), stimava che oltre un terzo del lessico italiano contemporaneo sia costituito da polirematiche: su circa 360.000 lemmi, ben 130.000 sarebbero multi-parola. Ciò dimostra quanto la nostra lingua faccia ricorso a queste strutture per creare nuove espressioni, sostituendo in molti casi i meccanismi di composizione propri di altre lingue, come l’inglese o il tedesco.
Una frontiera tra parola e frase
Le polirematiche hanno una caratteristica peculiare: pur essendo costituite da più parole, non tollerano modifiche interne. Non si può dire, ad esempio, stanza a gas al posto di camera a gas, né casa spaziosa di cura invece di casa di cura. La loro rigidità è una delle principali differenze rispetto ai sintagmi liberi, dove invece è possibile inserire aggettivi, modificatori o cambiare l’ordine degli elementi.
Questo tipo di coesione, tuttavia, non è assoluto. Esistono polirematiche più “rigide” e altre più “flessibili”. Ad esempio, fare acqua (nel senso di “non funzionare”) è una costruzione poco modificabile, mentre prendere tempo consente una certa variabilità, come in prendere un po’ di tempo. Il grado di coesione dipende anche dalla categoria grammaticale: le preposizioni e le congiunzioni polirematiche (come per mezzo di o nella misura in cui) sono tra le più compatte, mentre i verbi polirematici mostrano una maggiore libertà sintattica.
Le diverse categorie di polirematiche
Le polirematiche possono appartenere a tutte le principali parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi, avverbi, ma anche preposizioni, congiunzioni e interiezioni.
1. Nomi polirematici
Sono forse la categoria più numerosa. Appartengono a questa classe espressioni come carta di credito, giacca a vento, borsa di studio, punto di vista, treno merci. Esse possono formarsi in diversi modi:
-
Nome + aggettivo: casa editrice, anno accademico;
-
Aggettivo + nome: terzo mondo, prima serata;
-
Nome + sintagma preposizionale: macchina da scrivere, tavolo da cucina, avvocato del diavolo.
Interessante è anche il caso dei binomi irreversibili, come botta e risposta, gratta e vinci, tira e molla, che si presentano come formule fisse e insostituibili. Alcune polirematiche, come cessate il fuoco o nontiscordardimé, derivano invece dalla nominalizzazione di frasi, un fenomeno più raro ma significativo nella formazione lessicale.
2. Verbi polirematici
I verbi polirematici includono sia espressioni idiomatiche (come tirare le cuoia, prendere piede, andare per la propria strada) sia verbi sintagmatici, cioè combinazioni di un verbo con una particella avverbiale o preposizionale (come mettere via, buttare giù, portare avanti).
Una sottocategoria importante è costituita dai verbi supporto, in cui il verbo svolge un ruolo puramente grammaticale, mentre il significato pieno è portato dal nome o dall’aggettivo: prendere coraggio, fare buio, dare fastidio.
3. Aggettivi e avverbi polirematici
Gli aggettivi polirematici sono spesso formati da sintagmi preposizionali, come alla mano, fuori stagione, in bianco. Possono coincidere con avverbi polirematici, che condividono la stessa struttura: a caldo, al verde, sulla carta.
Un’altra tipologia è quella dei binomi aggettivali, come acqua e sapone, usa e getta, vero e proprio, che hanno un alto grado di fissità e una forte connotazione idiomatica.
Gli avverbi polirematici comprendono invece espressioni come di male in peggio, giorno per giorno, per filo e per segno, notte e giorno, a rotta di collo. Queste locuzioni sono parte integrante del linguaggio quotidiano e letterario, e la loro forza espressiva deriva proprio dalla loro stabilità.
Polirematiche, collocazioni e modi di dire
È importante distinguere le polirematiche dalle collocazioni, cioè combinazioni di parole che tendono a comparire insieme ma che mantengono una certa libertà sintattica. Per esempio, bandire un concorso è una collocazione, non una polirematica, perché si può dire il concorso è stato bandito o hanno bandito molti concorsi. Una polirematica, invece, non ammette simili variazioni senza perdere coerenza semantica.
Le polirematiche si avvicinano, piuttosto, ai modi di dire, in quanto spesso hanno un significato non letterale o idiomatico (dare una mano, fare acqua, alzare il gomito). Tuttavia, a differenza dei modi di dire più figurati, le polirematiche possono essere anche neutre e trasparenti, come carta da lettera o campo da calcio.
Una ricchezza del lessico italiano
L’abbondanza di polirematiche in italiano rivela un tratto tipico della nostra lingua: la tendenza alla perifrasi, alla costruzione di significati complessi attraverso combinazioni di parole piuttosto che con la composizione morfologica (come avviene in tedesco o inglese). In altre lingue si direbbe credit card, football field, typewriter, con composti uniti o semi-uniti; in italiano preferiamo dire carta di credito, campo da calcio, macchina da scrivere.
Questa strategia lessicale conferisce all’italiano flessibilità e ricchezza semantica, ma anche un’incredibile varietà di sfumature. Ogni polirematica è una piccola invenzione collettiva, un’unità di senso cristallizzata nel tempo, che rivela il modo in cui una comunità linguistica vede il mondo, nomina le cose e ne costruisce il significato.
In definitiva, le parole polirematiche sono il luogo in cui la creatività linguistica e la memoria culturale si incontrano: forme fisse, eppure nate dal dinamismo del parlato, che rendono l’italiano una lingua viva, articolata e poetica anche nella sua quotidianità.