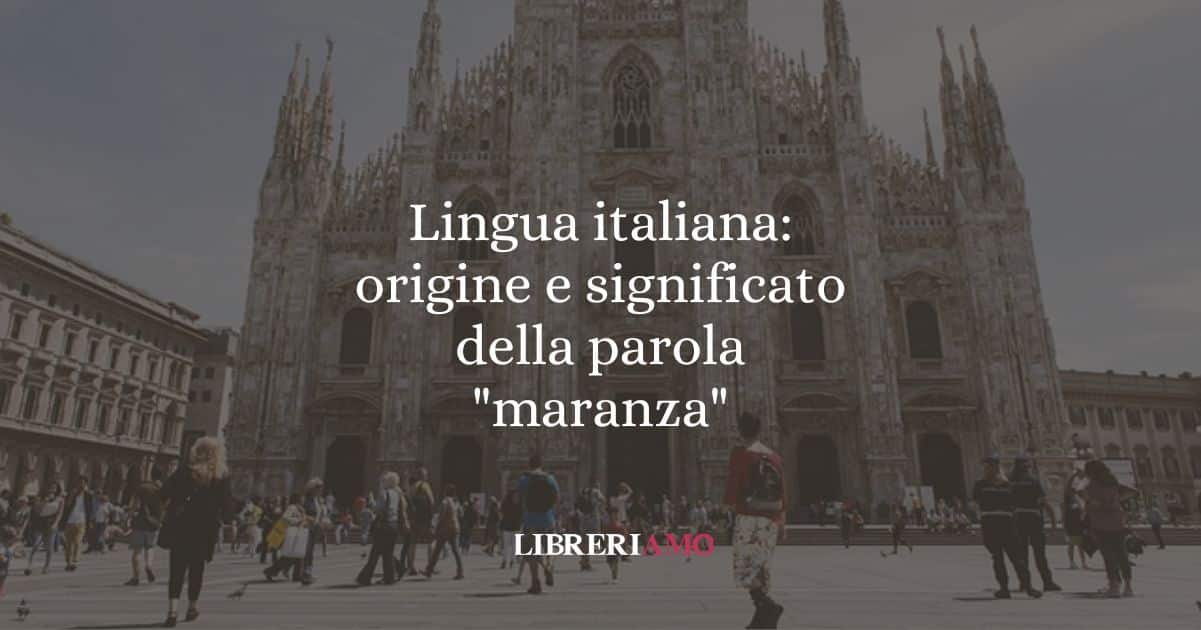La parola della lingua italiana “maranza” è uno degli esempi più interessanti di come il linguaggio giovanile riesca a mutare, rigenerarsi e adattarsi alle trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche di ogni epoca. Apparentemente leggera e gergale, questa voce racchiude invece una complessa stratificazione di significati, che spaziano dal gioco linguistico alla rappresentazione di un fenomeno sociale. Oggi “maranza” è diventata una parola diffusa nel linguaggio quotidiano, grazie soprattutto ai social network, che ne hanno favorito il rilancio e la rielaborazione semantica. Ma la sua storia è molto più lunga e sfaccettata.
Lingua italiana e gergo giovanile
Il termine “maranza” è un sostantivo invariabile, usato sia al maschile sia al femminile, e si riferisce a un giovane – più spesso un ragazzo – che mostra e ostenta un certo stile di strada: abiti appariscenti, scarpe da ginnastica griffate (spesso contraffatte), accessori di marca, orecchini, catene, un linguaggio diretto e, talvolta, volgare. Si tratta di una figura riconoscibile per i comportamenti e l’atteggiamento, che unisce il desiderio di affermarsi con la volontà di appartenere a un gruppo. Non di rado, la parola viene associata alla cultura trap, ai raduni giovanili nelle periferie o nei centri commerciali, e a un immaginario musicale e visivo fortemente influenzato dai media digitali.
L’etimologia di “maranza” rimane incerta, ma le ipotesi più accreditate risalgono al lessico giovanile degli anni Ottanta e Novanta. Secondo studiosi come Emanuele Banfi e Lorenzo Coveri, il termine potrebbe derivare dal meridionale “maranza”, cioè “melanzana”, con una possibile allusione al colore della pelle o ai tratti somatici, e dunque con una sfumatura razzista o etnica. Un’altra ipotesi lega la parola a forme come “marakesch” o “marocco”, che nel gergo giovanile del Nord Italia assumevano un tono dispregiativo per indicare i meridionali o gli immigrati nordafricani. Da qui, “maranza” avrebbe assunto via via il significato di individuo rozzo, tamarro, chiassoso, privo di raffinatezza.
La prima attestazione della parola si trova nel 1988, in un brano di Jovanotti, Il capo della banda:
“Mi chiamo Jovanotti e sono in questo ambiente
di matti di maranza e di malati di mente
fissati con le moto e coi vestiti americani
facciamo tutto ora o al massimo domani.”
In quel contesto, “maranza” indicava una figura tipica della gioventù urbana dell’epoca, legata al mondo delle discoteche, della musica dance e della moda americana: un tamarro metropolitano, amante dell’ostentazione e della libertà. È interessante notare come il termine avesse allora un tono più ironico che denigratorio, usato anche per descrivere con affetto o autoironia un certo tipo di “ragazzino di strada”.
Negli anni Duemila, “maranza” sembrava destinata a scomparire, ma con l’arrivo dei social network e delle piattaforme video come TikTok, ha conosciuto una sorprendente rinascita linguistica. Dal 2019 in poi, il termine ha assunto un nuovo valore simbolico, diventando una sorta di etichetta identitaria per gruppi di adolescenti che si autorappresentano sui social come “maranza”. È proprio la capacità di trasformarsi in autodefinizione ironica a spiegare la sua forza virale: i giovani non rifiutano il termine, ma lo adottano, lo giocano, lo reinventano come segno di appartenenza e, al tempo stesso, di ribellione.
Nel 2022, il “fenomeno maranza” è balzato all’attenzione dei media nazionali, soprattutto dopo alcuni raduni giovanili a Peschiera del Garda e Riccione, che suscitarono allarme e dibattito pubblico. Da allora, “maranza” è diventata una parola onnipresente nei discorsi giornalistici e sociali, caricata di nuovi significati e spesso associata a un’immagine negativa di gioventù disordinata o violenta. Tuttavia, ridurre il termine a un’etichetta di devianza sarebbe un errore: come molti fenomeni giovanili, anche quello dei “maranza” è un segno di disagio ma anche di creatività, un modo per costruire un’identità in un mondo frammentato.
La parola conserva ancora una forte ambiguità semantica. Può essere usata in senso dispregiativo (“è un maranza”, come sinonimo di tamarro o coatto), ma anche con un tono scherzoso o affettuoso (“sei proprio un maranza!”). In alcune zone, specialmente nel Nord Italia, è diventata parte del linguaggio quotidiano, usata per definire chi ostenta un certo stile modaiolo o chi segue tendenze con eccesso di entusiasmo.
Dal punto di vista sociolinguistico, “maranza” riflette un processo tipico delle parole del gergo giovanile: nascono ai margini, vengono rifiutate dagli adulti, poi si diffondono e cambiano significato. È un fenomeno che mostra quanto la lingua sia viva, capace di registrare le trasformazioni culturali e di adattarsi ai nuovi codici espressivi.
Oggi, dire “maranza” significa evocare un mondo preciso: quello dei ragazzi delle periferie, dei video girati con lo smartphone, della musica trap e delle serate tra amici nei parcheggi dei centri commerciali. Ma significa anche, più in profondità, parlare di riconoscimento e appartenenza, di come i giovani costruiscono la loro immagine attraverso linguaggi condivisi e codici comuni.
In fondo, “maranza” non è soltanto una parola. È uno specchio linguistico di un’epoca, un segno di come la lingua italiana si adatti alle nuove realtà sociali e digitali, rivelando, dietro il gergo e la moda, le tensioni e le aspirazioni di una generazione che cerca, a modo suo, di farsi sentire. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dell’Accademia della Crusca: Maranza.