Lingua italiana: “lei”, “voi” o “tu”, quale pronome usare?
Scopriamo qual è l’occorrenza corretta secondo la lingua italiana per pronomi “voi”, “lei” e “tu”, quando usarli e con chi.
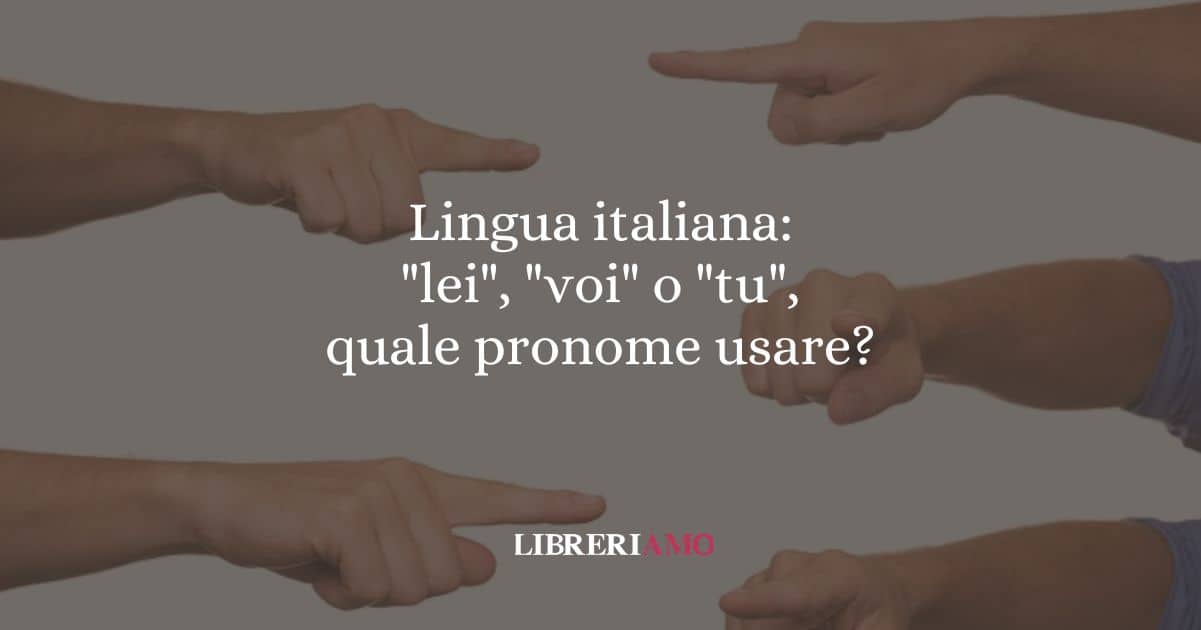
L’uso dei pronomi tu, lei e voi è una delle questioni più affascinanti e delicate della lingua italiana, poiché intreccia linguistica, storia, cultura e costume sociale. Queste forme, che oggi appaiono naturali nei loro rispettivi ambiti d’uso, hanno attraversato nei secoli un’evoluzione complessa, segnata da mutamenti di sensibilità, rapporti di potere e concezioni della cortesia.
Il Medioevo: il dominio del “tu” e il rispetto del “voi”
Nel Medioevo, l’italiano conosceva principalmente due pronomi allocutivi: tu e voi. Il tu era la forma di uso comune, impiegata in quasi tutte le situazioni comunicative, mentre il voi rappresentava un titolo di grande rispetto, riservato a persone di rango elevato o a interlocutori verso i quali si voleva mostrare deferenza. L’idea sottesa al voi era che chi lo riceveva “valesse per due”, un modo per sottolinearne la dignità o la superiorità.
Dante Alighieri, nella Divina Commedia, offre una testimonianza preziosa di questa prassi. Il poeta si rivolge con il tu alla maggior parte dei personaggi che incontra, ma usa il voi nei confronti di figure a cui attribuisce un alto valore morale o intellettuale: Farinata degli Uberti, Cavalcante Cavalcanti, Brunetto Latini e Beatrice. L’uso del voi in questi casi esprime rispetto e ammirazione. Emblematico è anche il dialogo con Cacciaguida: inizialmente Dante gli si rivolge con il tu, ma, non appena scopre la sua identità di avo illustre, passa immediatamente al voi, rimproverando ironicamente i suoi contemporanei romani per l’abuso del tu, segno per lui di una società che aveva smarrito le distinzioni di rispetto.
Il Rinascimento: l’affermazione del “lei”
Nel Quattrocento la situazione cambia. Al binomio tu/voi si aggiunge una nuova espressione: la Vostra Signoria, che si alterna talvolta al voi e altre volte al lei (da la Signoria). L’uso del lei, che si diffonde inizialmente in ambienti di corte, viene poi rafforzato nel Cinquecento dall’influenza della Spagna, dove era comune rivolgersi con usted (abbreviazione di vuestra merced, “vostra grazia”).
Da questo momento in poi, lei si impone progressivamente come pronome di cortesia, sostituendo in larga parte il voi nel parlato formale. Tuttavia, per molti secoli le tre forme convivono: voi rimane la scelta più neutra, tu è la forma dell’intimità, e lei rappresenta la distanza e il rispetto. È interessante notare che tu, pur essendo confidenziale, continua a essere usato in contesti elevati quando il destinatario non è un essere umano ma un’entità superiore o astratta: così Manzoni, nel Cinque maggio, si rivolge alla Fede con il tu, forma non marcata socialmente.
Dall’Ottocento al Novecento: l’equilibrio sociale del “lei”
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, i testi letterari e teatrali testimoniano l’uso ormai consolidato del sistema tripartito tu/voi/lei. Nei drammi di Verga, come Cavalleria rusticana, i rapporti tra familiari si esprimono con il tu, mentre verso gli estranei si usa il lei o, in alcuni casi, il voi in segno di rispetto. In Pirandello, invece, il lei domina come pronome di cortesia formale: in Sei personaggi in cerca d’autore, i personaggi familiari si danno del tu, ma si rivolgono al capocomico con il lei.
Nelle lettere e nei rapporti familiari del tempo, i figli continuano a rivolgersi ai genitori con il voi, mentre i genitori si servono del tu: una dissimmetria che rispecchia l’autorità paterna e materna nella società tradizionale.
L’età contemporanea: dal formalismo alla confidenza nella lingua italiana
Oggi, la distribuzione d’uso dei tre pronomi rispecchia una società più orizzontale, in cui le gerarchie sociali si sono attenuate. Il lei resta la forma di cortesia per eccellenza, da usare in contesti professionali, burocratici o con persone sconosciute. Il tu, invece, si è ampiamente esteso, anche tra individui di età o status diversi, segno di una comunicazione più informale e paritaria.
Le regole di base, come ricorda Luca Serianni, restano comunque tre:
- Tu e lei devono essere reciproci: non è appropriato che uno usi il tu e l’altro risponda con il lei.
- Il passaggio da una forma all’altra può avvenire solo dal lei al tu, e mai viceversa.
- La proposta di dare del tu spetta alla persona considerata “superiore” — per età, posizione o grado — o, nel caso di generi diversi, alla donna.
Nei rapporti dissimmetrici, come tra docenti e studenti, il lei resta invece d’obbligo, almeno da parte degli studenti verso i professori. Per saperne di più: Tu, lei, voi.