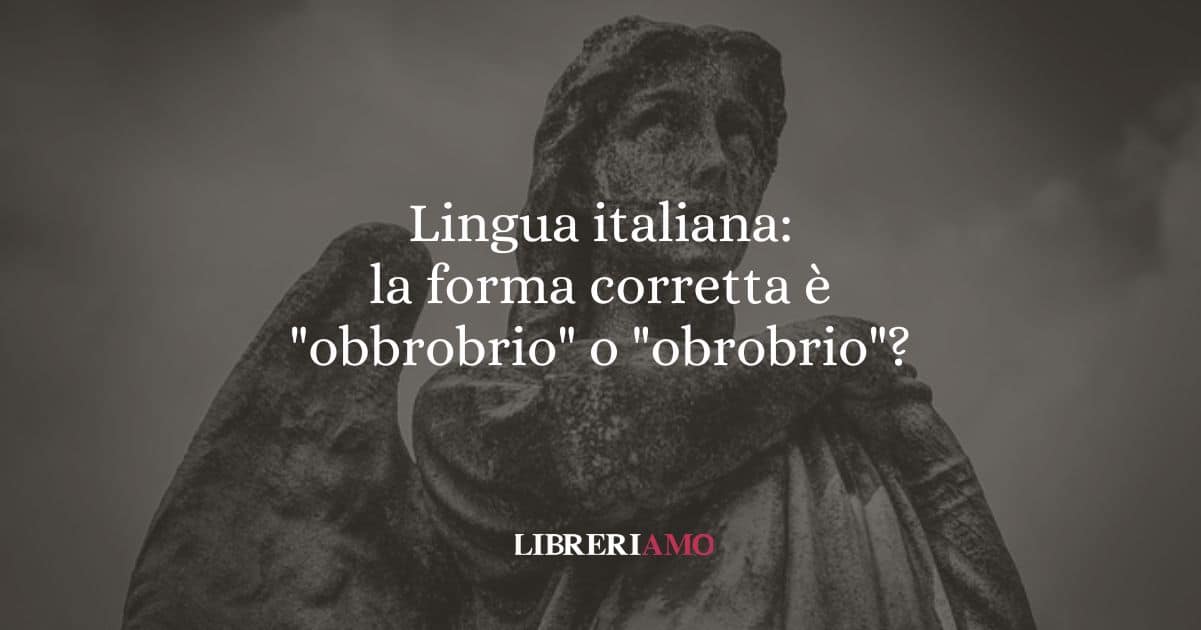La lingua italiana, ricca di sfumature e complessità, non manca di offrire ai parlanti dubbi ricorrenti che spesso riguardano non solo il significato delle parole, ma anche la loro corretta grafia e pronuncia. Uno dei casi più interessanti è quello della parola “obbrobrio”, che molti si chiedono se vada scritta con due b (obbrobrio) o con una sola (obrobrio). A prima vista, entrambe le forme possono sembrare plausibili, ma solo una è corretta e riconosciuta dalla tradizione linguistica e dai dizionari dell’uso.
Origine ed etimologia della parola della lingua italiana
Per comprendere il perché di questa incertezza, bisogna partire dall’etimologia. “Obbrobrio” deriva dal latino opprobrĭum, termine che significa “vergogna, disonore, infamia”, composto dal prefisso ob- (“contro”) e da probrum (“disonore, colpa, disprezzo”). Dal latino classico la parola ha conservato sia il senso che la struttura fonetica, adattandosi poi all’italiano volgare.
Non è un caso che nei testi antichi si trovi anche la variante “oppròbrio”, più vicina alla forma latina originaria. Con il tempo, l’evoluzione fonetica e morfologica della lingua italiana ha portato a una semplificazione e alla stabilizzazione di una grafia unica: “obbrobrio”, con la doppia bb.
Perché nasce il dubbio: obbrobrio o obrobrio?
Il dubbio nasce dal fatto che, nella pronuncia rapida e colloquiale, la sequenza di consonanti bbr può risultare complessa e quindi percepita come una sola b rafforzata. Questo porta molti a credere che la grafia corretta sia “obrobrio”, senza raddoppiare la b.
Tuttavia, la norma ortografica e lessicale è chiara: la doppia b è necessaria, perché rispecchia la derivazione etimologica dal latino opprobrĭum. Eliminare una b significherebbe deformare la parola e allontanarla sia dalla tradizione scritta sia dal suo modello originario.
L’errore “obrobrio” è dunque frutto di una tendenza alla semplificazione, tipica della lingua parlata, che non trova però riscontro nella norma scritta.
Il significato di “obbrobrio”
La parola “obbrobrio” conserva un significato forte e pregnante, usato per indicare:
-
Infamia o disonore: il senso più antico e nobile del termine. Dante, ad esempio, utilizza “obbrobrio” nella Divina Commedia per descrivere la condizione di vergogna eterna dei dannati.
-
Persona, azione o cosa disonorevole: in questo caso, l’obbrobrio diventa ciò che provoca vergogna, scandalo o condanna sociale. Così Muratori parlava dei “ladri e usurai” come obbrobri dell’umanità.
-
Cosa brutta, offensiva per il senso estetico: nell’uso moderno ed enfatico, “obbrobrio” è spesso impiegato per esprimere disgusto davanti a qualcosa di esteticamente sgradevole, ad esempio “questo palazzo è un vero obbrobrio”.
Il termine, quindi, oscilla tra un uso colto e moralmente forte (infamia, disonore) e un uso più comune e colloquiale (bruttezza, cattivo gusto).
La forza espressiva del termine
Rispetto ad altre parole italiane che indicano vergogna o disonore (come onta, disonore, vergogna), “obbrobrio” possiede una carica espressiva più dura e marcata. Il suono stesso della parola, con la sequenza di consonanti robuste, trasmette un senso di pesantezza e di repulsione. Non è un caso che oggi venga spesso impiegata in frasi esclamative del tipo: “Che obbrobrio!”, per indicare non solo disonore morale ma anche ripugnanza estetica o fastidio immediato.
L’uso letterario e moderno
La fortuna della parola è attestata nei secoli. Dante la utilizza in chiave teologica e morale; Muratori in senso sociale e civile; gli scrittori moderni l’hanno impiegata per denunciare ingiustizie, storture e brutture della società.
Oggi, però, il termine appare con maggiore frequenza nel linguaggio giornalistico e colloquiale per denunciare situazioni di degrado o opere architettoniche considerate poco armoniose. “Quell’edificio è un obbrobrio” è un’espressione che ricorre spesso nelle polemiche urbanistiche, proprio perché la parola ha la capacità di sintetizzare, con forza e immediatezza, un giudizio negativo che non è solo estetico ma anche morale.
La questione della pronuncia
Quanto alla pronuncia, nonostante la grafia con doppia b, non sempre nella lingua parlata si percepisce chiaramente il raddoppiamento. La corretta pronuncia prevede ob-brò-brio, con la bb marcata, ma molti parlanti tendono a semplificare in obròbrio. È un fenomeno simile a quello che accade con altre parole complesse, come subbuglio (pronunciato talvolta “subùglio”).
Tuttavia, la norma ortografica è imprescindibile: la grafia accettata e codificata nei dizionari è solo e soltanto obbrobrio. La forma “obrobrio” resta un errore, pur se diffuso e comprensibile dal punto di vista fonetico.
Il dubbio tra obbrobrio e obrobrio ci insegna una lezione importante sul rapporto tra lingua parlata e lingua scritta. Se la prima tende alla semplificazione e all’economia dei suoni, la seconda conserva la memoria storica ed etimologica delle parole, imponendo regole che tutelano la coerenza del sistema linguistico.
Scrivere obbrobrio significa non solo rispettare la norma grammaticale, ma anche mantenere vivo il legame con la tradizione latina e con la storia della nostra lingua. La variante obrobrio può forse sembrare più naturale alla pronuncia, ma resta un errore da evitare nello scritto.
In definitiva, obbrobrio è una parola che porta con sé la forza della sua etimologia e del suo suono, capace di trasmettere infamia, vergogna o bruttezza con un impatto immediato. Un termine che, seppure poco usato nella vita quotidiana, continua a sopravvivere come strumento linguistico potente, e che merita di essere scritto e pronunciato nella sua forma corretta.