Lingua italiana: ti senti più “inizzato” o più “inlaghito”?
Lasciamoci trasportare dalla bellezza delle parole della lingua italiana scoprendone o riscoprendone due: inizzare e inlaghire.
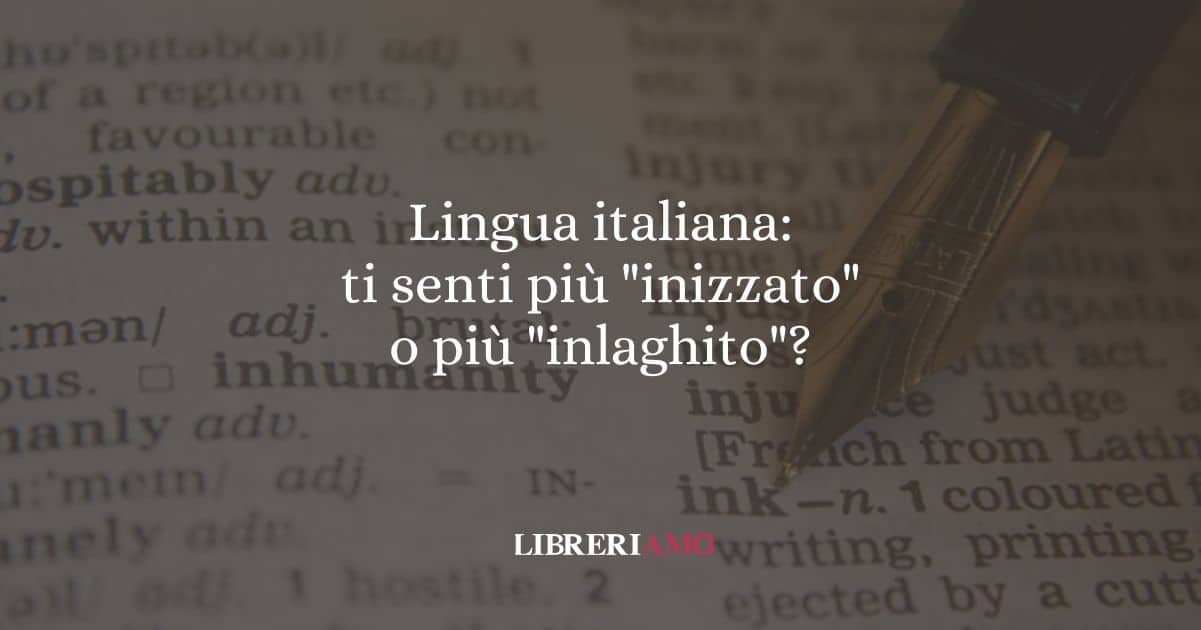
Le parole “inizzato” e “inlaghito”, oggi pressoché sconosciute anche ai più appassionati cultori della lingua italiana, appartengono a quel patrimonio lessicale dimenticato che rivela la straordinaria ricchezza e la plasticità dell’italiano delle origini. Entrambe risalgono ai secoli tra il Medioevo e il Rinascimento, e mostrano in modo esemplare la capacità del volgare italiano di forgiare nuovi termini a partire da immagini concrete e da radici vive, attraverso l’uso del prefisso “in-” in senso illativo, cioè con valore di “rendere dentro”, “trasformare in”.
L’arte delle e nelle parole
La prima, inizzato, è il participio passato del verbo inizzare, mentre la seconda, inlaghito, deriva da un verbo non attestato ma ricostruibile, inlaghire. Se la prima si muove nel campo della passione e dell’azione, la seconda appartiene invece all’immaginario della quiete e della contemplazione. Due parole opposte per significato, ma unite da una stessa radice morfologica e da un identico spirito creativo.
“Inizzare”: l’arte di accendere l’animo
Il verbo inizzare (dal sostantivo izza, affine a aizzare) significa letteralmente provocare all’ira, incitare, stimolare, spingere con energia o con foga a compiere un’azione. È, dunque, un verbo che racchiude una forza dinamica, un movimento interiore che passa da chi parla a chi ascolta, come una scintilla che accende l’animo.
L’etimologia è trasparente: deriva dal verbo aizzare (forse dal longobardo aitan, “spingere”), ma con il prefisso “in-” che rafforza e interiorizza l’azione, come se significasse accendere dentro, infondere ardore. È un verbo tipicamente medievale, dal tono energico e diretto, spesso impiegato in contesti bellici, morali o passionali.
Le prime attestazioni di inizzare si trovano nei testi del XII e XIII secolo, come testimoniano le citazioni riportate in fonti antiche. Nel Cassiano volgare (IX, 6), ad esempio, leggiamo:
“Un saracino… gli stava dinanzi, inizzandolo con volto infiammato alla detta opera compiere.”
Qui la parola esprime con precisione il gesto di chi istiga o infiamma un altro a compiere un’azione, con una sfumatura di coinvolgimento emotivo e fisico: il volto “infammato” dell’istigatore fa eco all’incendio che vuole suscitare nell’altro.
In un passo del Fiore di filosofi si legge invece:
“Poi che Socrate le trovava garrire [le due mogli], sì le inizzava per farle venire a’ capelli.”
Qui l’azione di “inizzare” si traduce in un aizzare quasi giocoso, un incitare alla lite, che rivela come il verbo potesse oscillare tra i registri più seri e quelli più ironici o quotidiani.
Più tardi, nel linguaggio storico e letterario dei cronisti toscani, inizzare assume il valore morale di spingere al male, come nota Livio ( tradotto in volgare):
“Avea una malvagia femmina per moglie, che tutto dì il pugneva e inizzava a mal fare.”
In questo caso, la parola acquista una connotazione etica: l’azione dell’“inizzare” è quella della tentazione, dell’istigazione verso il peccato o la colpa.
Dunque, “inizzato” significa “provocato, incitato, stimolato, infiammato”. È un termine che descrive il passaggio da uno stato di quiete a uno di agitazione o di decisione, sia essa nobile o malvagia. Nella lingua antica, dove i confini tra il corpo e lo spirito erano più labili, inizzare evocava tanto il calore fisico dell’ira quanto il fuoco interiore della volontà.
Oggi diremmo forse “spronato”, “incitato”, “aizzato”, ma nessuna di queste parole conserva la sfumatura psicologica e viscerale di inizzato: quel senso di impulso irresistibile che nasce dentro e si propaga fuori, come una corrente di energia.
“Inlaghito”: la calma resa immagine
Se inizzato appartiene alla sfera dell’ardore, inlaghito ne rappresenta l’antitesi: è la parola della quiete, del silenzio e della limpidezza.
L’aggettivo, attestato in un passo di Imperiali (XVII secolo), descrive uno stato di calma e di purezza visiva:
“Di se stesso / fa immenso fonte al picciolo oceano / del cristallo inlaghito e inargentato.”
Inlaghito significa dunque “reso come un lago”, “che ha l’aspetto o la serenità di un lago”. È il participio passato di un verbo non attestato, inlaghire, formato dal sostantivo lago e dal prefisso in-, con valore illativo, ossia di “diventare lago” o “trasformare in lago”.
La parola non indica soltanto una superficie d’acqua, ma una condizione metaforica dell’animo: l’idea di una calma profonda, di una quiete specchiante. È un termine poetico, visivo, ma anche spirituale: il “cristallo inlaghito” è un’immagine di trasparenza e riflessione, come se il soggetto si fosse disteso nell’acqua per ritrovarvi il proprio volto.
Inlaghito, in questo senso, si oppone semanticamente a “inizzato”: il primo “accende”, il secondo “placa”. Il primo rappresenta il fuoco, il secondo l’acqua; l’uno agisce nel corpo e nell’ira, l’altro nella mente e nella pace. Eppure entrambi testimoniano la forza generativa del prefisso “in-”, capace di creare immagini verbali di trasformazione interiore: rendere ardente, rendere lacustre, rendere altro da sé.
Due volti dell’antico linguaggio figurato nella lingua italiana
L’italiano delle origini amava trasformare le cose in immagini. In un mondo in cui la lingua si costruiva per somiglianza e analogia, parole come inizzato e inlaghito nascevano naturalmente, senza bisogno di regole accademiche.
Oggi, in un’epoca in cui la lingua tende a ridursi a forme schematiche e univoche, questi antichi vocaboli ci ricordano che le parole possono ancora esprimere la trasformazione del mondo in emozione. “Inizzato” e “inlaghito” non sono soltanto due reperti linguistici: sono due metafore della condizione umana — il turbamento e la pace, la fiamma e lo specchio.
Nella loro brevità e sonorità, esse conservano la memoria di una lingua che sapeva farsi corpo e natura, che sapeva dire il mutamento delle cose con la forza di una sola sillaba. E forse proprio per questo, pur essendo ormai cadute nell’oblio, restano testimoni preziose di una poetica del verbo che fu, e che ancora oggi può insegnarci a sentire nella parola la materia viva del mondo.