Lingua italiana: il plurale di euro è “euro” o “euri”?
Scopriamo assieme quale è secondo le regole della lingua italiana il plurale della parola “euro”, se resta invariato oppure si utilizza “euri”.
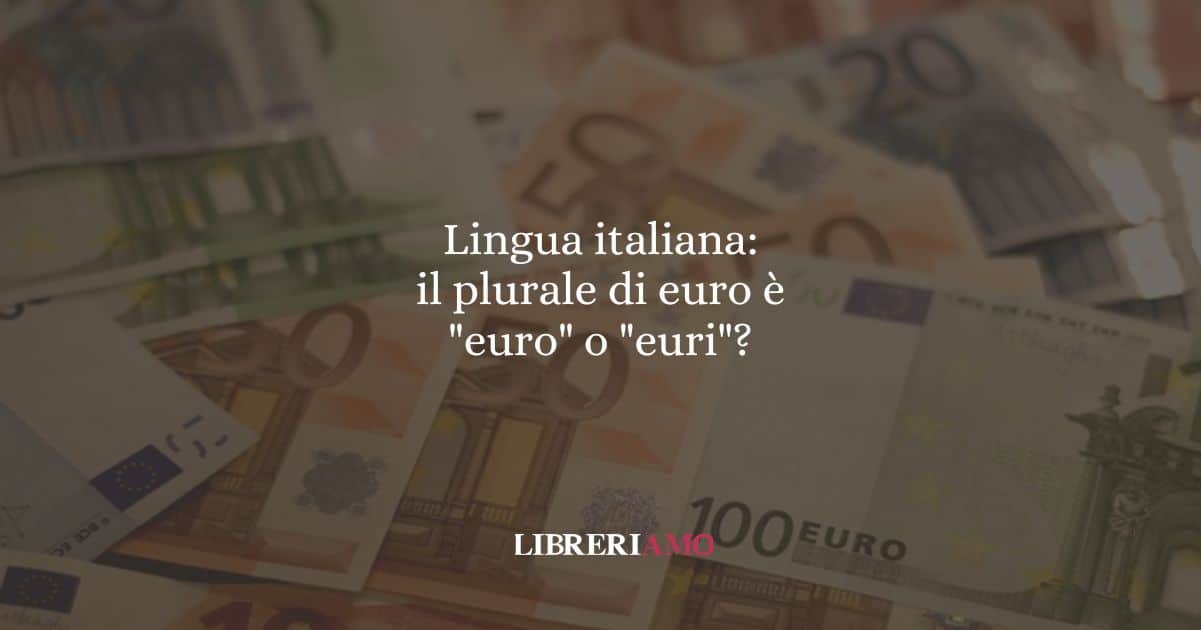
Pochi termini della lingua italiana hanno suscitato tante discussioni linguistiche quanto “euro”, il nome della moneta unica europea entrata in circolazione nel 2002. Dietro questa parola apparentemente semplice si nasconde una questione complessa, che riguarda non solo la grammatica dell’italiano, ma anche la politica linguistica dell’Unione Europea, la differenza tra lingua normativa e lingua d’uso, e persino la percezione identitaria di una parola che, come ha osservato Francesco Sabatini, è la prima “parola europea non nazionale”. Il problema principale riguarda la forma plurale: si deve dire “due euro” o “due euri”? E perché questa incertezza sembra riguardare in modo particolare l’italiano?
Lingua italiana e plurale
Per comprendere il dibattito bisogna partire dalla decisione ufficiale dell’Unione Europea. Il 26 ottobre 1998, una direttiva comunitaria stabilì che in alcune lingue — precisamente inglese, tedesco e italiano — la forma al plurale restasse invariabile, quindi euro/euro. Per tutte le altre lingue, invece, la parola avrebbe seguito la naturale morfologia del plurale: per esempio euros in spagnolo, euros in francese, eurot in estone, e così via. Questa scelta asimmetrica è il punto di partenza delle perplessità che molti parlanti italiani ancora oggi manifestano: perché mai proprio nella nostra lingua, che ha un sistema morfologico chiaro e produttivo, il plurale dovrebbe essere bloccato?
L’italiano, infatti, è una lingua fortemente flessiva. I nomi maschili che terminano in -o formano regolarmente il plurale in -i: treno/treni, libro/libri, tavolo/tavoli. In questo quadro, “euro” appare formalmente come un normale sostantivo maschile, e sarebbe spontaneo trasformarlo in “euri”. Non sorprende, dunque, che l’istinto di molti parlanti nativi porti naturalmente verso il plurale euri, una forma che circola soprattutto nel parlato informale, nel linguaggio familiare e in alcuni contesti colloquiali.
Tuttavia, la direttiva europea ha imposto all’italiano un funzionamento diverso, rendendo “euro” ufficialmente invariabile. È questo scarto tra norma e uso spontaneo a generare confusione. Se la motivazione della direttiva fosse stata quella di garantire un’uniformità assoluta tra tutte le lingue dell’Unione, probabilmente sarebbe stata recepita con maggiore naturalezza. Ma così non è: al plurale, le lingue europee si comportano in modo diverso, e solo l’italiano, l’inglese e il tedesco sono state chiamate a “bloccare” la flessione naturale del nome.
Il presidente dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, ha dedicato spazio alla questione nel numero 23 de La Crusca per voi, sostenendo la legittimità della forma invariabile. Secondo Sabatini, “euro” è una parola con una fisionomia particolare, dotata di una valenza semantica che la isola dal contesto morfosintattico normale. Non sarebbe quindi un semplice nome comune, ma un termine nuovo, anomalo, portatore di un valore simbolico: è la prima parola europea, non appartenente originariamente al patrimonio di nessuna lingua nazionale, e per questo meritevole di un trattamento speciale.
Questa interpretazione, però, non elimina del tutto le perplessità. Molti linguisti ritengono che la lingua non dovrebbe piegarsi a imposizioni esterne quando queste confliggono con la sua morfologia naturale. Altri sottolineano che l’invariabilità non comporta vantaggi reali per la comunicazione, e che anzi genera incertezza nei parlanti, abituati a regole chiare e produttive. Dal punto di vista dell’uso, infatti, la situazione rimane fluida: la maggioranza delle comunicazioni istituzionali, dei giornali e dei testi formali rispetta l’invariabilità, ma nel parlato comune euri continua a circolare, spesso con una sfumatura ironica o scherzosa — anche se per molti è una forma percepita come naturale e non marcata.
Un altro elemento che alimenta il dibattito riguarda la grafia delle banconote e delle monete, dove la parola appare invariabile in tutti i paesi dell’Unione. Questa uniformità grafica, però, non corrisponde a un’uniformità linguistica: la pronuncia varia da paese a paese, e lo stesso accade per il plurale nelle lingue in cui è flesso. L’unica vera costante è la scritta sulle banconote, ma questa, naturalmente, non può essere presa come criterio linguistico.
C’è poi un’osservazione di tipo sociolinguistico: quando una norma è percepita come artificiale, il parlante tende a eluderla. In molte situazioni informali, dire “dieci euro” può suonare rigido, mentre “dieci euri” appare più spontaneo. È probabile, dunque, che la coesistenza delle due forme continuerà ancora a lungo, con una distinzione progressiva: euro come forma ufficiale e istituzionale; euri come forma popolare, affettiva o colloquiale.
Per concludere
In conclusione, come dice anche l’Accademia della Crusca, oggi la forma corretta secondo la norma ufficiale è chiarissima: il plurale di “euro” è “euro”. Ma la storia non finisce qui. La lingua non è un sistema immobile, e spesso si muove in direzione diversa da quella indicata dalle istituzioni. Come nota l’autrice del testo da cui questo articolo prende spunto, l’uso parlato resterà probabilmente vario, e sarebbe auspicabile che nessuno si scandalizzasse ascoltando “euri”. Una lingua viva non è fatta di imposizioni rigide, ma di equilibri tra norme, usi e necessità comunicative. E “euro”, con la sua natura ibrida e la sua storia recente, è uno degli esempi più affascinanti di questo delicato equilibrio.