Lingua italiana: il significato del neologismo “amichettismo”
Scopriamo assieme cosa si intendente quando si adopera il neologismo della lingua italiana “amichettismo”.
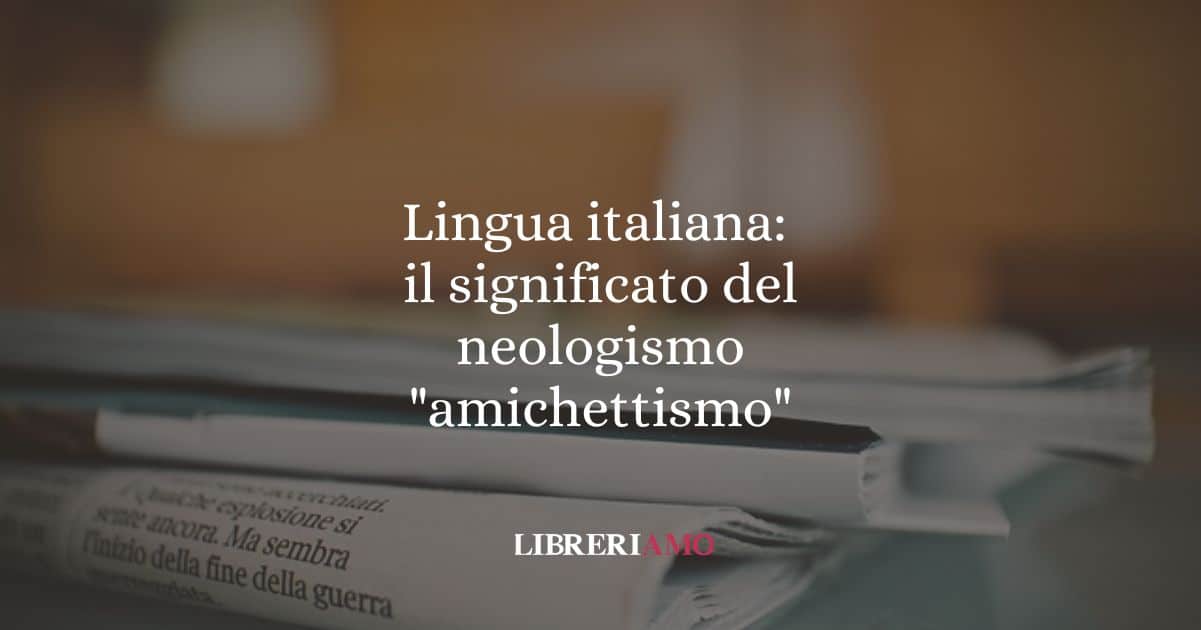
Nel lessico politico e giornalistico degli ultimi anni, nel vocabolario della lingua italiana, si è affacciata una parola nuova, che nel giro di poco tempo è diventata oggetto di discussione e polemica: amichettismo. Il termine, pur suonando quasi ironico per la sua costruzione morfologica, ha un significato tutt’altro che leggero: indica infatti una pratica di favoritismo clientelare, messa in atto da esponenti politici o da chi ricopre posizioni di potere, a vantaggio di amici e sostenitori.
La genesi del vocabolo è piuttosto recente e ben documentata. Coniato dal giornalista e scrittore Fulvio Abbate nel 2021, è stato usato per la prima volta in un articolo dell’“Huffington Post” per commentare la vicenda del musicista Roberto Angelini, accusato di aver impiegato senza contratto una lavoratrice nel proprio ristorante. In quell’occasione, Abbate notava come la solidarietà espressa al musicista da parte di colleghi e amici avesse un carattere quasi tribale, di protezione reciproca, definendo la dinamica appunto come esempio di “amichettismo”.
Lingua italiana e neologismi
Dal punto di vista linguistico, amichettismo nasce dall’unione di amichetto – diminutivo di “amico” con sfumatura spregiativa – e del suffisso -ismo, lo stesso che ritroviamo in termini come nepotismo, familismo, clientelismo. La derivazione è quindi immediatamente riconoscibile e colloca il neologismo in una tradizione di parole legate a forme di corruzione, favoritismo o gestione privatistica del potere.
Il diminutivo “amichetto” non va inteso come espressione affettuosa, ma come indicazione di un rapporto di amicizia superficiale, di convenienza, che diventa criterio di selezione e promozione anziché la competenza. È proprio questo carattere spregiativo a conferire al termine un’efficacia polemica notevole: parlare di “amichettismo” significa svelare e ridicolizzare pratiche clientelari che, pur condannate pubblicamente, continuano a prosperare.
Dalle prime attestazioni alla diffusione
Dopo l’esordio nel 2021, il termine ha conosciuto un periodo di circolazione limitata, soprattutto in contesti giornalistici e nel linguaggio politico legato agli ambienti della sinistra romana. Tuttavia, è stato nel 2024 che amichettismo ha fatto il salto di qualità, entrando stabilmente nel dibattito pubblico.
A determinare questa svolta è stata una dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rivendicava la distanza del suo governo dalle pratiche di “amichettismo” attribuite ai precedenti governi di centrosinistra. L’uso del termine da parte di una figura istituzionale di primo piano ha dato legittimazione e visibilità alla parola, che ha cominciato a ricorrere con frequenza crescente negli articoli di cronaca politica.
Le statistiche confermano questa crescita: nel 2024 la parola compare decine di volte sulle principali testate nazionali, da la Repubblica al Corriere della Sera, entrando anche nei repertori lessicografici ufficiali come il Devoto-Oli 2025 e i neologismi Treccani.
Il significato politico e sociale
Il successo del termine si spiega con la sua capacità di sintetizzare un fenomeno radicato nella vita politica italiana: la tendenza a nominare amici, conoscenti o fedelissimi in posizioni di rilievo, indipendentemente dai meriti. Non si tratta, naturalmente, di una pratica esclusiva di una parte politica, ma di un costume trasversale che attraversa governi e schieramenti.
Proprio per questo motivo amichettismo si è progressivamente svincolato dall’originario riferimento agli ambienti della sinistra e ha assunto un valore generico, valido per descrivere qualsiasi comportamento di favoritismo clientelare. Le polemiche sulle nomine nel settore della cultura, gli incarichi conferiti in aziende pubbliche o enti locali, i rapporti personali tra leader e collaboratori: sono tutti contesti in cui il termine è stato utilizzato come etichetta critica.
Un neologismo tra satira e denuncia
Uno degli aspetti più interessanti di amichettismo è la sua ambivalenza: la parola conserva un tono ironico, quasi infantile per via del diminutivo, ma al tempo stesso denuncia pratiche di grande rilievo politico e civile. È proprio questo contrasto che ne ha favorito la fortuna: parlare di “amichettismo” significa smascherare comportamenti discutibili riducendoli a un circolo vizioso di “amichetti”, togliendo loro quella patina di legittimità che la politica spesso rivendica.
Non a caso, accanto ad “amichettismo” hanno fatto la loro comparsa altre formazioni occasionali come parentismo, cognatismo, amantismo: parole create ad hoc per stigmatizzare dinamiche di potere fondate su legami personali piuttosto che istituzionali.
Una riflessione sul linguaggio politico
La rapida affermazione di amichettismo dimostra come la lingua politica italiana sia estremamente ricettiva ai neologismi, soprattutto quando riescono a catturare in modo efficace e immediato fenomeni complessi. Non si tratta solo di lessico: il successo di queste parole rivela il bisogno, da parte dell’opinione pubblica e dei media, di strumenti linguistici capaci di semplificare e criticare la realtà politica.
Ogni volta che una parola nuova entra in circolazione, non descrive soltanto un fatto, ma contribuisce a costruirne la percezione collettiva. In questo senso, parlare di “amichettismo” significa inquadrare un comportamento entro una cornice di disvalore, denunciandolo come pratica distorta che mina i principi di trasparenza e meritocrazia.
Amichettismo è un neologismo giovane, ma la sua traiettoria è già significativa. Nato da una penna giornalistica come etichetta ironica, si è trasformato in parola politica di uso frequente, fino a conquistare spazio nei dizionari. La sua diffusione racconta molto della società italiana, ancora segnata da pratiche di favoritismo e da una certa sfiducia verso le istituzioni.
Come spesso accade, la lingua intercetta i fenomeni sociali e li restituisce con parole nuove, capaci di sintetizzare in un colpo solo indignazione, satira e denuncia. L’“amichettismo” resta dunque un termine di moda, ma anche uno specchio impietoso di abitudini dure a morire: quelle in cui il potere, più che meritocrazia, sembra premiare amicizie e fedeltà personali. Per saperne di più rimandiamo a questo esaustivo articolo redatto dall’Accademia della Crusca: Amichettismo