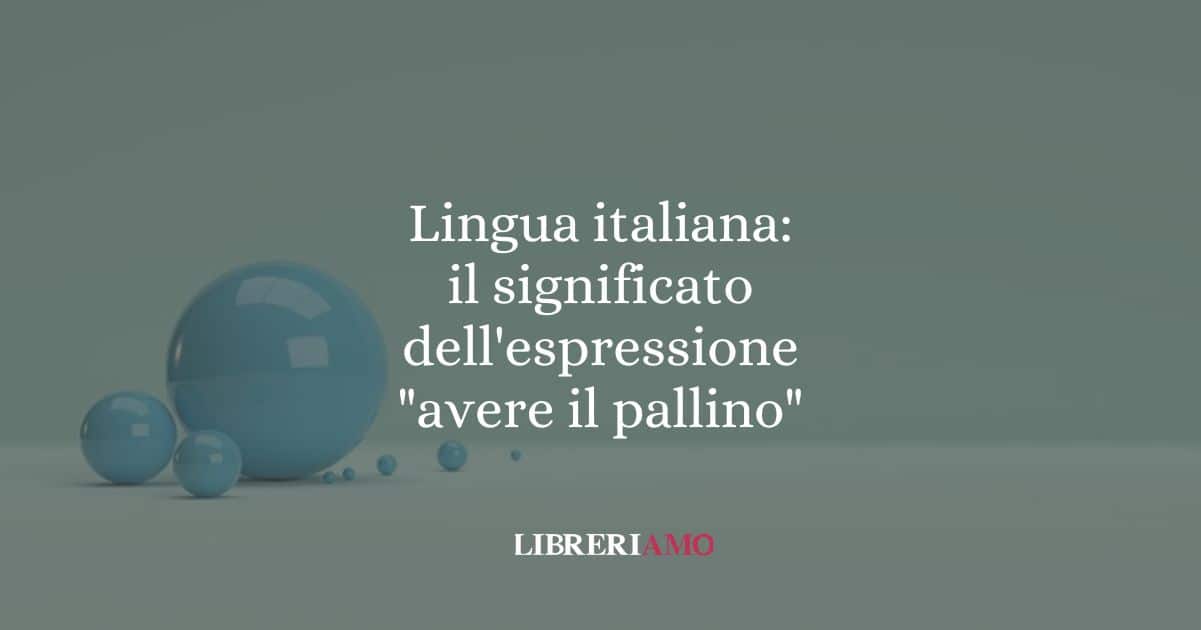La lingua italiana è ricca di espressioni idiomatiche che, nel corso del tempo, si sono staccate dal loro significato originario per assumere valori figurati, spesso più incisivi ed evocativi. Una di queste locuzioni è “avere il pallino”, che oggi viene comunemente usata per indicare una passione, una fissazione, un’idea che ritorna in modo costante nella mente di una persona. Ma come spesso accade con i modi di dire, dietro le parole si cela una lunga storia fatta di usi concreti, trasformazioni culturali e contaminazioni letterarie.
Origine ludica nella lingua italiana: il pallino nei giochi
Per comprendere l’origine dell’espressione bisogna tornare al mondo dei giochi, in particolare a due passatempi molto popolari: il biliardo e le bocce. In entrambi i casi, il pallino rappresenta la palla più piccola, quella che funge da bersaglio. I giocatori devono avvicinare le proprie palle al pallino, calcolando abilmente le distanze e regolando con attenzione i propri tiri. È proprio questa dinamica – il puntare insistentemente a un obiettivo preciso – che ha favorito il passaggio dal significato concreto a quello figurato: come i giocatori cercano di colpire il pallino, così una persona può “avere il pallino” di un’idea, di un interesse, di un’attività.
L’espressione inizia a diffondersi soprattutto nel Novecento, quando questi giochi, pur conosciuti già nell’Ottocento, diventano veri e propri fenomeni sociali. È significativo che, proprio negli anni in cui il biliardo e le bocce erano passatempi di largo consumo, il linguaggio quotidiano abbia accolto questa metafora.
Dal gioco alla lingua: il significato figurato
Un passaggio importante nella storia della locuzione è testimoniato dalla Appendice al Dizionario moderno di Alfredo Panzini, curata da Bruno Migliorini e pubblicata nel 1950. Qui si registra il significato figurato di “pallino” come “mania, fissazione”. Migliorini nota che “avere il pallino in testa” significa perseguire con ostinazione un obiettivo, esattamente come nel gioco. La fissazione ludica diventa così un modo per parlare di passioni e ossessioni della vita quotidiana.
Un esempio letterario lo troviamo nel racconto La bellezza del vivere di Piero Chiara (1976), in cui si descrive la passione di un personaggio per il biliardo: “Fissazione costante del notaio Arca era il pallino, altrimenti detto casino.” Qui il confine tra gioco e ossessione personale si annulla, offrendo una chiara dimostrazione dell’evoluzione semantica dell’espressione.
“Avere il pallino di” o “avere il pallino per”?
Un aspetto interessante riguarda la costruzione sintattica della locuzione. È più corretto dire “avere il pallino di” o “avere il pallino per”?
Entrambe le forme sono attestate nella letteratura e nell’uso comune, anche se non con la stessa frequenza. Nel dizionario Il Nuovo De Mauro, ad esempio, compare esclusivamente la costruzione in di: “ha il pallino della pulizia”, “ho il pallino della matematica”. Questa reggenza risulta più diffusa e flessibile, perché consente di introdurre non solo nomi, ma anche frasi.
Tuttavia, l’uso della preposizione per non è affatto raro. Nel CORIS/CODIS, un ampio corpus dell’italiano scritto contemporaneo, si registrano circa 70 esempi con di contro 5 con per. Quest’ultima costruzione, sebbene minoritaria, sembra accentuare la sfumatura di determinazione e intenzionalità: avere il pallino per qualcosa non significa soltanto esserne ossessionati, ma avere una spinta concreta ad agire in quella direzione.
Un esempio moderno si trova in Alessandro Piperno (Inseparabili, 2012), dove compare l’espressione “un vecchio amico con il pallino per gli affari”. In altri testi, come La scuola cattolica di Edoardo Albinati (2016), troviamo invece il “pallino dell’imprenditoria”. Entrambe le costruzioni, dunque, sono possibili, anche se l’uso consolidato privilegia di.
Varianti e trasformazioni
Nel corso del tempo, l’espressione ha assunto diverse varianti. Talvolta il “pallino” non è introdotto da avere, ma da essere: “X è il pallino di Y”, oppure “è un mio vecchio pallino”. In altri casi si aggiungono aggettivi che rafforzano l’idea di ossessione, come in “pallino fisso”, espressione affine a “chiodo fisso”.
Interessante è anche l’uso letterario che sposta il significato dal biliardo alla caccia. Nel romanzo La malora di Beppe Fenoglio (1954) si legge: “Siccome per questa ragazza io avevo allora un pallino in un’ala…”. Qui il termine rimanda al pallino del fucile, ossia al piccolo proiettile da caccia. L’idea di colpire un bersaglio rimane, ma il contesto è diverso.
In chiave popolare, si trova anche un uso romanesco, come in Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini (1959): “sti giorni a me m’ha attraversato sempre er pallino pe’ a testa de sistemamme”. Qui il pallino diventa quasi un pensiero ossessivo che attraversa la mente, un moto continuo e irrefrenabile.
Un simbolo di passioni e fissazioni
Oggi, quando diciamo che qualcuno “ha il pallino della fotografia” o “il pallino del calcio”, non pensiamo più né al biliardo né alle bocce, ma il legame con il gioco è ancora sotteso. L’immagine del pallino come piccolo bersaglio da raggiungere rimane un potente simbolo della determinazione umana, ma anche della sua tendenza a fissarsi su idee talvolta futili.
Che si tratti di un hobby, di una professione o di un’ossessione quotidiana, “avere il pallino” restituisce l’idea di un interesse che diventa centrale, che cattura l’attenzione e non la lascia andare. Un modo di dire che, pur nato in un contesto ludico, ha trovato nella lingua comune un terreno fertile per esprimere la complessità delle passioni umane.
L’espressione “avere il pallino” è un perfetto esempio di come la lingua trasformi esperienze concrete in metafore universali. Dalla precisione del gioco del biliardo alla fissazione personale, dalle bocce alla letteratura, il pallino ha compiuto un lungo viaggio semantico. Oggi ci ricorda che le passioni – grandi o piccole – sono ciò che danno colore e direzione alla vita, anche quando diventano vere e proprie fissazioni. Per saperne di più rimandiamo a questo articolo dell’Accademia della Crusca: Abbiamo il pallino di qualcosa o per qualcosa?