Lingua italiana e scuola: significato del verbo tracopiare
Scopriamo il significato del verbo della lingua italiana “tracopiare”, quando nasce e quando si diffonde nei parlanti.
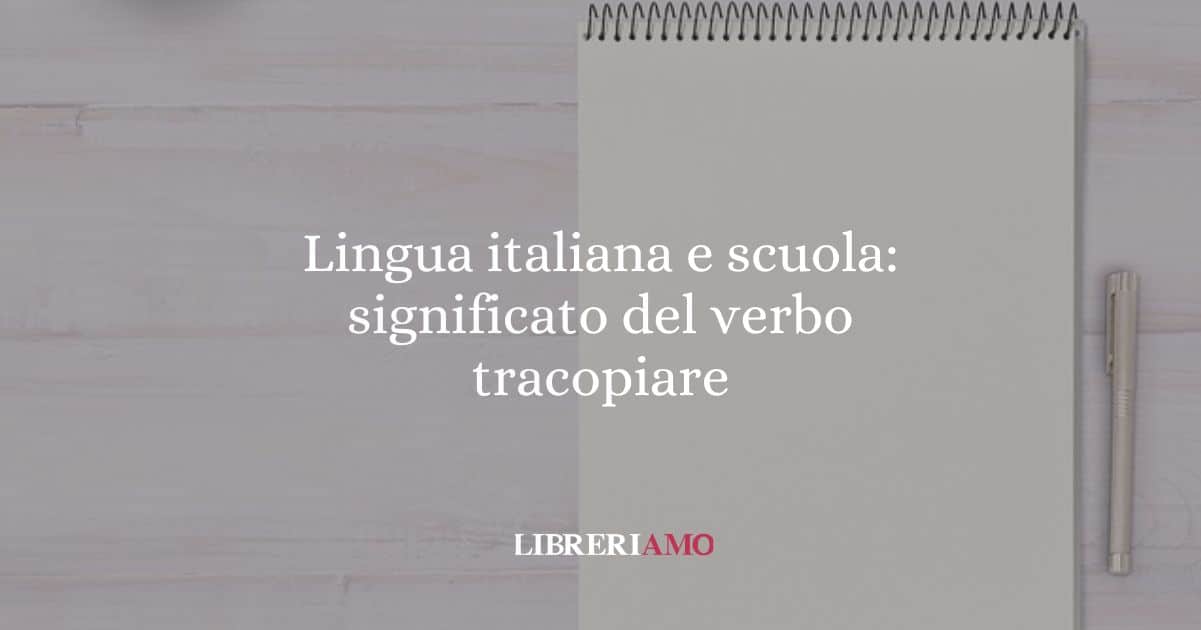
Il verbo “tracopiare” rappresenta un interessante esempio di come la lingua italiana, nella sua continua evoluzione, sappia conservare e reinventare forme verbali che nascono da esigenze pratiche ma che, nel tempo, assumono anche un valore culturale e linguistico significativo. Apparentemente marginale, questo verbo nasconde invece una storia antica e stratificata, che affonda le radici nel latino medievale e si estende fino ai nostri giorni, attraversando ambiti tecnici, artistici e letterari.
Origine e formazione del verbo
Il verbo tracopiare deriva da copiare, con l’aggiunta del prefisso tra- (dal latino trans-), che significa “attraverso”, “oltre”. Il prefisso conferisce al verbo un valore di passaggio o di trasferimento, evidenziando l’azione di trasporre fedelmente da un modello a un altro. Si tratta di un processo morfologico comune nella lingua italiana, dove il prefisso tra- (come in trascrivere, trasmettere, trasporre) suggerisce il superamento di un limite, un attraversamento spaziale o concettuale.
Già nel Glossarium mediæ et infimæ latinitatis di Du Cange, importante repertorio del lessico latino medievale, è attestato il verbo transcopiare con il significato di “trascrivere”. Ciò indica che la radice di tracopiare è molto più antica di quanto si possa pensare, e che la sua presenza nel lessico italiano moderno non è una semplice innovazione recente, ma piuttosto la sopravvivenza o la rielaborazione di una voce ereditata da un passato colto e specialistico.
Le prime attestazioni nella lingua italiana: dal Seicento alla medicina del primo Novecento
Secondo il GRADIT (Grande dizionario italiano dell’uso), tracopiare è attestato con il significato moderno di “ricalcare un disegno” solo a partire dalla fine del XX secolo, ma fonti più antiche ne documentano l’uso ben prima. Già nel Seicento, Domenico Ferreri impiega il verbo in Il curioso discreto (1648) con il significato di “trasferire” o “riprodurre”, parlando di “idee tracopiate” da una mente eterna: un uso metaforico e filosofico, che suggerisce la trasmissione di un modello ideale a un’esecuzione concreta.
Successivamente, nell’Ottocento, troviamo esempi in contesti letterari e devozionali, come in Encomio funereo di Maria Cristina, regina delle Due Sicilie (1836) di Salvatore Romano, dove si parla di “tracopiare in sé tutte le virtù”. In questo caso, il verbo assume un valore morale: “imitare”, “riprodurre interiormente” le qualità di un modello.
Più tecnico è invece l’uso che si trova nel “Giornale della R. Accademia di medicina di Torino” (1911), dove un medico afferma di “tracopiare su foglietti di carta trasparente i punti stimolati e localizzati”. Qui il verbo assume chiaramente il valore pratico e concreto di “ricalcare”, anticipando l’accezione moderna legata al disegno e alle arti grafiche.
Dall’imitazione alla ricalcatura: l’uso contemporaneo
È però solo a partire dagli anni Novanta del Novecento che tracopiare entra in un uso più diffuso con il significato di “ricalcare un disegno o una figura su carta velina, su vetro o su una superficie luminosa”. Questo significato, attestato dal GRADIT, è probabilmente frutto dell’ambiente tecnico e artistico, dove il gesto del ricalcare è frequente e la necessità di un verbo specifico si è fatta sentire.
Un esempio celebre si trova in I ferri del mestiere di Carlo Fruttero e Franco Lucentini (2003), dove tracopiare viene usato in senso figurato: “seguire da vicino, imitare fino a ricalcare”. In questo caso, il verbo trascende l’ambito tecnico e diventa metafora del processo creativo: l’atto di ricalcare un modello diventa immagine del rischio di imitazione sterile, contrapposta alla libertà dell’invenzione artistica.
Negli ultimi decenni, il verbo continua a comparire, seppur sporadicamente, in testi accademici e divulgativi, come nell’articolo Disegno e Camera Lucida nel Carnet de voyage (2013), dove tracopiare è messo tra virgolette, segno che non è ancora pienamente stabilizzato nell’uso comune. Tuttavia, la sua presenza nei contesti specialistici dell’arte, della grafica e dell’illustrazione testimonia una vitalità linguistica che ne giustifica la legittimità.
Una parola “di confine”
Tracopiare è un verbo che vive in una zona di confine: tra il tecnico e il figurato, tra l’uso colto e quello pratico, tra la tradizione e la neologia. È interessante notare che, pur essendo registrato dal GRADIT e dal GDLI, esso è assente dai principali dizionari dell’uso contemporaneo come il Vocabolario Treccani, il Sabatini-Coletti o il Zingarelli 2025. Questa assenza, tuttavia, non ne compromette la validità linguistica: il verbo esiste, è usato, e ha una storia documentata di oltre quattro secoli.
Il suo significato si muove lungo una linea di continuità semantica: da “trascrivere” a “ricalcare”, passando per “imitare” e “riprodurre”. È un percorso che rispecchia, in fondo, il processo stesso della copia, che da sempre accompagna la storia della cultura e dell’arte. Copiare, tracopiare, ricalcare: tutte azioni che implicano un rapporto di fedeltà o di distanza rispetto a un modello, un esercizio che può essere tanto meccanico quanto creativo.
Da una ricerca sul web risultano circa 770 occorrenze dell’infinito “tracopiare” e oltre 500 del participio “tracopiato”, dati che, pur modesti, confermano un uso reale, seppur circoscritto. Si tratta dunque di un verbo “di nicchia”, ma pienamente legittimo, che risponde a un’esigenza espressiva specifica e che gode di una certa riconoscibilità, soprattutto nei contesti grafici, artistici e filologici.
In definitiva, tracopiare non è una parola inventata o spurio neologismo, ma un verbo perfettamente formato secondo le regole morfologiche dell’italiano, documentato in fonti antiche e ancora presente in usi moderni. È una voce che dimostra come la lingua, lungi dall’essere un sistema statico, si modelli continuamente sulle necessità comunicative, recuperando talvolta forme dimenticate o adattandole a nuovi contesti.
Il verbo tracopiare ci invita a riflettere sul potere della lingua di reinventarsi senza perdere memoria di sé. Esso attraversa i secoli con discrezione, cambiando significato ma conservando il suo nucleo etimologico di “trasferimento”. È una parola che racconta il dialogo costante tra tradizione e innovazione, tra il gesto dell’artista che ricalca e quello dello scrittore che riscrive, tra il copiare per imitare e il copiare per comprendere. Per saperne di più: Sul verbo tracopiare.