Lingua italiana: è corretto scrivere “buondì” o “buon dì”?
Scopriamo quale è la grafia corretta secondo le norme della lingua italiana, per il saluto “buondì”/”buon dì”.
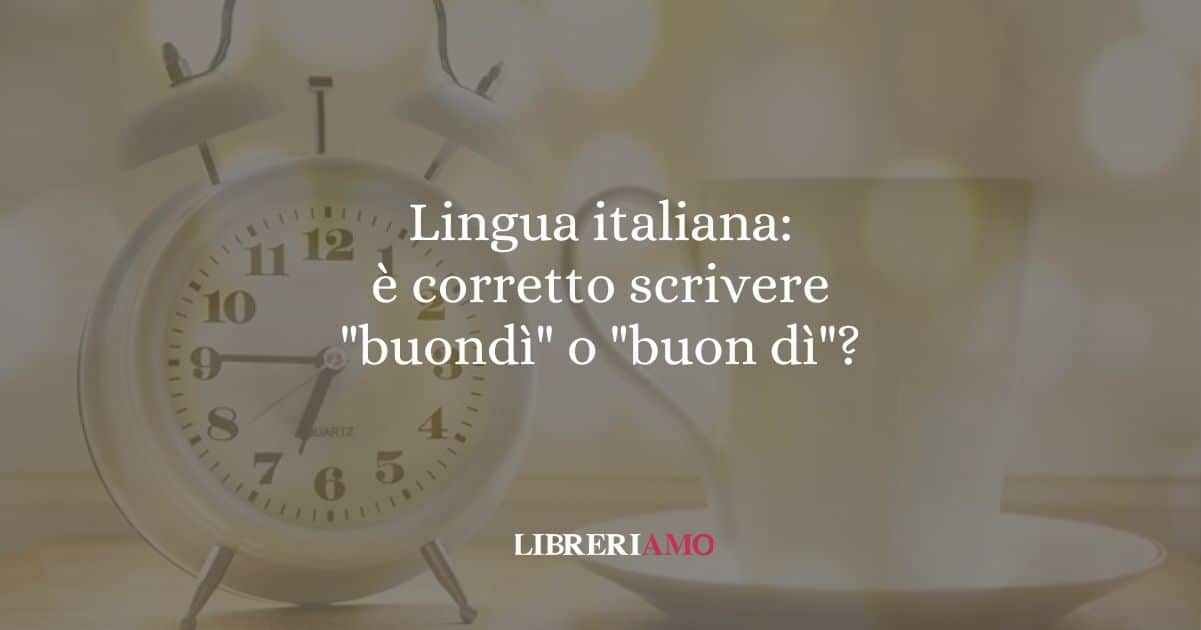
Nella lingua italiana non mancano casi in cui due grafie convivono, spesso legittimamente, lasciando ai parlanti e agli scriventi una certa libertà di scelta. Uno di questi è rappresentato dalla formula di saluto “buondì” o “buon dì”, che continua a sollecitare dubbi e discussioni tra chi scrive. La domanda iniziale è semplice: meglio la grafia univerbata (Buondì) o quella analitica (Buon dì)? La risposta, come spesso accade nella storia della lingua, è meno univoca di quanto sembri.
Il DOP – Dizionario italiano multimediale e multilingue d’ortografia e di pronunzia (Roma, ERI, 2010), nella voce dedicata, osserva che entrambe le soluzioni sono possibili, pur precisando che la forma univerbata buondì è “meno comune”. Questo dato ci invita a guardare alla tradizione storica e agli usi moderni, per comprendere meglio le ragioni della prevalenza di una grafia sull’altra.
La tradizione nella lingua italiana: dal Decameron a Manzoni
La formula “Buon dì” affonda le radici nei primi secoli della nostra lingua. Già nel Decameron di Giovanni Boccaccio troviamo esempi chiari: “Buon dì, madonna: sono ancora venute le damigelle?” (VIII 7, 75) e “Buon dì Calandrino” (IX 3, 6). Qui la locuzione mostra la sua vitalità come tipico saluto mattutino, legato al ritmo della giornata e all’incontro tra persone.
L’uso si consolidò a tal punto che nacquero formule composite, come “Buon dì e buon anno”, che non si riferiva solo al capodanno ma fungeva da saluto generico e beneaugurante. È noto l’esempio riportato da Annibale Caro, detto Belo, nella commedia Il pedante (1529): “Oh bon dì, Luzio – Buon dì e buon anno”. L’accoppiata dei due auguri doveva avere un forte valore rituale, quasi stereotipato.
Più tardi, nel Seicento, la formula è ancora ben viva, come dimostra un passo citato da Alessandro Manzoni nella Storia della colonna infame. Lo sventurato Piazza, interrogato sui rapporti con il sospetto untore Mora, dichiara: “è amico, signor sì, buon dì e buon anno, è amico signor sì; val a dire che lo conosceva appena di saluto”. Qui il saluto serve persino come argomento difensivo, a dimostrazione che la formula era allora percepita come un segno minimo e superficiale di conoscenza.
Buon giorno e Buon dì: la competizione dei saluti
Accanto a “Buon dì”, troviamo anche la variante “Buon giorno”, che oggi ci appare naturale e più comune, ma che inizialmente era secondaria. Lo stesso Belo, nella già citata commedia, alterna le due formule: “Orsù! Buon giorno – Buon giorno e buon anno”.
Nel Cinquecento il Bibbiena, nella Calandria, testimonia la percezione diffusa che il saluto mattutino fosse piuttosto “Buon dì”: “Ma oimè!, che saluto gli darò io? Dirò: Buon dì? non è da mattina. Buona sera? non è tardi […]”. L’oscillazione dimostra come le due forme coesistessero, pur con prevalenze variabili.
Il vero punto di svolta arriva con Carlo Goldoni, il grande riformatore del teatro italiano nel Settecento, il cui ruolo nella stabilizzazione dell’italiano moderno è forse sottovalutato. Nei suoi testi, infatti, Buon giorno prevale nettamente: 58 occorrenze contro appena 2 di Buon dì. Con lui, il saluto destinato a imporsi nella norma dell’italiano contemporaneo si afferma in modo chiaro.
Dalla norma alla consuetudine moderna
Oggi la situazione si è in parte rovesciata: mentre “Buon giorno” si è imposto come formula standard, adatta in contesti formali e informali, “Buon dì” ha assunto un ruolo secondario e colloquiale. Il suo uso può avere una sfumatura scherzosa, familiare o affettuosa, non sempre adatta a situazioni di formalità o rispetto.
Un esempio recente lo troviamo in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera (7 luglio 2011), in cui una lettrice scrive a Beppe Severgnini: “Buondì Beppe (uso il tu spero di non sbagliare)”. L’incipit mostra chiaramente l’uso colloquiale, quasi complice, della formula.
Univerbazione o grafia analitica?
Resta la questione grafica: scrivere “Buon dì” o “Buondì”? La tradizione letteraria e documentaria, da Boccaccio a Manzoni, testimonia largamente la grafia analitica. L’univerbazione è più recente e risponde a un processo frequente nella lingua, che tende a unire locuzioni d’uso quotidiano (stamattina, stasera, addio).
Tuttavia, come osserva il DOP, la grafia univerbata è meno comune e resta percepita come marginale. A rafforzare l’opportunità di preferire la forma analitica interviene anche un dato extralinguistico: la presenza sul mercato del celebre “Buondì Motta”, brioche lanciata nel 1953 e ancora oggi marchio notissimo. L’univerbazione, in questo caso, rischia di confondere la formula di saluto con il nome commerciale, inducendo alcuni a preferire Buon dì proprio per mantenere un distinguo netto.
In definitiva, entrambe le grafie – Buon dì e Buondì – sono corrette e legittime, ma non equivalenti in termini di frequenza, storia e sfumature d’uso. La grafia analitica gode di una lunga tradizione letteraria, appare più comune e consente di evitare ambiguità con il marchio commerciale. La grafia univerbata, pur corretta, resta meno diffusa e più colloquiale.
Possiamo dunque dire che chi scrive Buon dì si colloca nel solco della tradizione e della chiarezza; chi scrive Buondì si affida a una soluzione moderna, compatta e informale. La scelta finale, come spesso accade in lingua, dipenderà dal contesto e dal tono che si intende dare al saluto: più formale e neutro nella versione analitica, più colloquiale e familiare in quella univerbata.