Lingua italiana: origine e significato di “apotropaico”
Scopriamo il significato della parola greca “apotropaico” utilizzato anche nella lingua italiana, sempre più spesso.
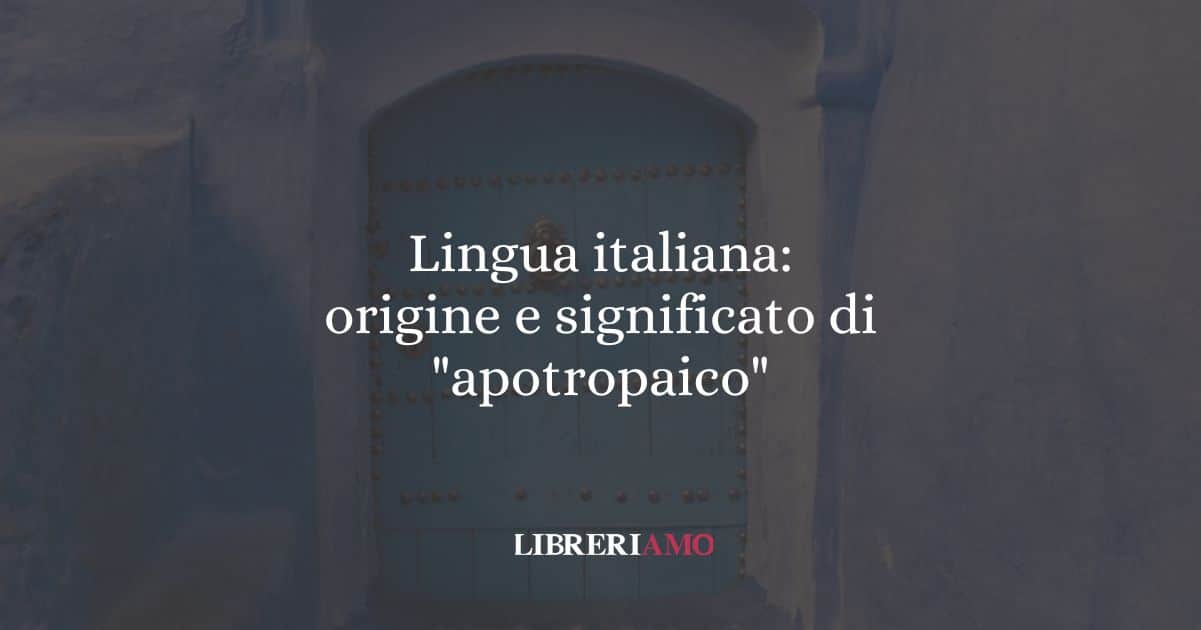
Il termine in uso anche nella lingua italiana “apotropaico” appartiene a quel gruppo di parole che, pur derivando dall’antichità più remota, continuano a mantenere una vitalità nel linguaggio e nell’immaginario collettivo. Non è una parola di uso quotidiano, ma quando viene evocata porta con sé un’aura di mistero, di magia e di protezione. Essa definisce oggetti, atti, animali o formule destinati ad allontanare o annullare un’influenza maligna, secondo credenze radicate in molte culture antiche. Il suo valore, però, non si limita alla superstizione: “apotropaico” racconta un pezzo importante della storia del pensiero umano, del rapporto con il sacro e con la paura.
Etimologia, origini e uso nella lingua italiana
La parola deriva dal greco apotrópaios, a sua volta da apó (“via, lontano”) e trépō (“volgere, deviare”). Già nell’antichità classica, dunque, il termine aveva la funzione di designare ciò che “respinge”, che “volge altrove” forze oscure o malefiche. Da qui l’aggettivo “apotropaico”, che in italiano si è diffuso attraverso la mediazione della cultura latina e medievale.
Il fatto che una parola simile sia sopravvissuta nei secoli ci mostra quanto profonda sia la radice di questa esigenza: l’uomo, da sempre, cerca strumenti per difendersi da ciò che percepisce come minaccia invisibile. Prima che la scienza fornisse spiegazioni naturali ai fenomeni, il mondo era popolato da forze ostili, spiriti e influssi maligni. Il linguaggio apotropaico è, in un certo senso, il riflesso di questa lotta millenaria contro l’ignoto.
Oggetti e simboli apotropaici nell’antichità
Il mondo antico era costellato di segni apotropaici. Nel bacino del Mediterraneo, culture diverse condividevano l’idea che fosse possibile allontanare il male attraverso oggetti o immagini dal forte potere simbolico.
Tra i più diffusi vi erano:
-
Le maschere gorgoniche, con il volto mostruoso di Medusa, capaci di pietrificare chi osava guardarle: erano scolpite su templi e scudi.
-
L’occhio, simbolo onniveggente che respinge lo sguardo malvagio: un’immagine che sopravvive ancora oggi nel celebre “occhio blu” del Medio Oriente.
-
La mano (come la mano di Fatima o la “figa” apotropaica romana), rappresentazione semplice e potente del gesto che ferma o devia.
-
Il fallo, simbolo di forza vitale e generativa, presente su amuleti e incisioni murarie, utilizzato per contrastare il malocchio e favorire la fertilità.
-
Le pietre rare e le gemme, alle quali si attribuivano virtù protettive e curative.
Questi oggetti erano spesso collocati anche nelle tombe, a difesa dei defunti contro spiriti maligni o forze distruttive che avrebbero potuto turbare il riposo eterno. L’apotropaico, dunque, non proteggeva soltanto i vivi, ma garantiva anche la continuità della vita oltre la morte.
L’aspetto rituale: parole e gesti
L’apotropaico non si limitava agli oggetti materiali. Anche formule magiche, canti e invocazioni avevano questa funzione. La parola, nel mondo antico, era ritenuta dotata di un potere intrinseco: pronunciare un nome o una frase poteva influenzare la realtà.
Non meno importanti erano i gesti rituali. Molti di essi, nati in epoche remote, sopravvivono ancora oggi in forme apparentemente innocue. Fare le corna, toccare ferro, o compiere determinati scongiuri sono residui di pratiche apotropaiche che continuano a testimoniare la persistenza della credenza in influenze da respingere.
Dal sacro al quotidiano
Ciò che colpisce del termine “apotropaico” è la sua capacità di attraversare epoche e contesti diversi, adattandosi alle trasformazioni culturali. Nel Medioevo cristiano, ad esempio, gli oggetti apotropaici vennero reinterpretati alla luce della fede: croci, reliquie, immagini sacre divennero strumenti di difesa contro il demonio.
In epoca moderna e contemporanea, l’apotropaico ha perso parte della sua connotazione magico-religiosa per assumere un valore più simbolico o antropologico. Gli studiosi lo utilizzano per descrivere fenomeni culturali legati alla superstizione, al folklore, ma anche all’arte. Non mancano esempi nel design urbano: le statue di leoni o gargoyle poste agli ingressi degli edifici medievali avevano chiaramente una funzione apotropaica.
L’apotropaico come categoria culturale
Oggi parlare di “apotropaico” significa riconoscere la presenza, ancora viva, di un modo di pensare arcaico che non è mai stato del tutto superato. Nonostante i progressi della scienza, gli esseri umani continuano a coltivare rituali di protezione: un amuleto portafortuna, un gesto fatto prima di un esame, una frase ripetuta prima di un evento importante.
In questo senso, l’apotropaico non è soltanto un concetto archeologico, ma un atteggiamento esistenziale. Esprime la volontà di avere un margine di controllo sull’imprevedibile, di addomesticare l’incertezza attraverso simboli condivisi.