Lingua italiana: è corretto usare “troppo” come comparativo?
Scopriamo assieme se secondo le norme della lingua italiana è corretto usare l’avverbio “troppo” con funzione comparativa.
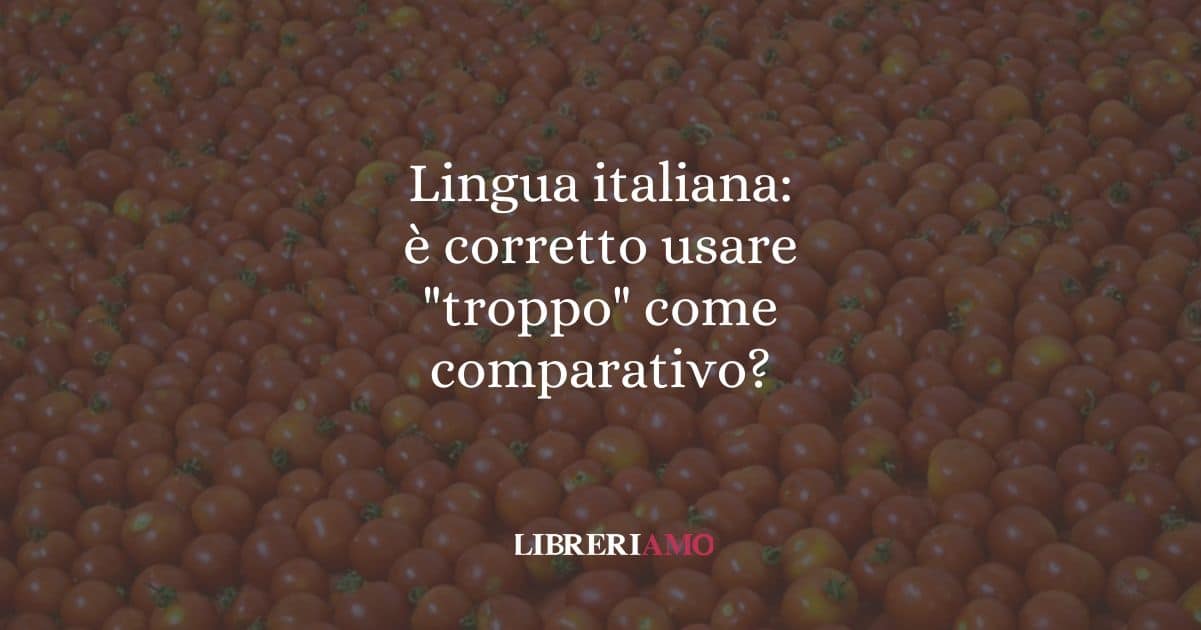
Il lessico della lingua italiana riserva non poche sorprese quando si affrontano in profondità le sfumature semantiche e gli sviluppi storici dei termini. Tra questi, l’avverbio “troppo” offre un caso particolarmente interessante: oggi percepito come indicatore di eccesso, spesso connotato negativamente, “troppo” in realtà ebbe nel passato un uso molto più ampio, che ne faceva un equivalente di “molto” anche nei costrutti comparativi e superlativi.
“Troppo” nella lingua italiana
Gli esempi ricavati dal Corpus OVI (Opera del Vocabolario Italiano) testimoniano chiaramente che, nel Due-Trecento, “troppo” si combinava con i comparativi di aggettivi e avverbi. Alcuni casi sono illuminanti:
-
per lo temperato mangiare sta il corpo troppo meglio (Giordano da Pisa);
-
le vivande troppo peggio che ghiande (Novellino);
-
e sì se’ tu troppo migliore e più savio di me (Novellino);
-
li ministri… sono in troppo peggiore stato che gli altri (Domenico Cavalca);
-
ed esser mi parea troppo più lieve (Dante, Purgatorio XII, 116).
In tutti questi esempi, “troppo” non indica un eccesso inconciliabile con il confronto, ma piuttosto una quantità o un grado considerevole. In altre parole, vale esattamente come “molto”. Così, “troppo meglio” equivale a “molto meglio”, “troppo peggiore” a “molto peggiore”, e così via.
“Troppo” come sinonimo di “molto”
Nell’italiano antico “troppo” non era confinato all’uso avverbiale. Poteva funzionare anche come aggettivo e come pronome, sempre con il valore di “molto” o “molti”:
-
egli sono troppi buoni archieri (Milione);
-
ne ucisono troppi e ne presero assai (Fatti dei Romani).
Addirittura, “troppo” riusciva a rafforzare un superlativo assoluto, come nel passo pisano di Raineri sardo: di troppo grandissimo danno. Si trattava quindi di un termine estremamente flessibile, capace di coprire un campo semantico molto più ampio rispetto a quello che gli attribuiamo oggi.
Le radici etimologiche
Dal punto di vista etimologico, “troppo” deriva dal francese antico thorp (latinizzato in troppus), con chiara parentela con “truppa”. Già in latino tardo, e poi nelle lingue romanze, questa base lessicale poteva indicare sia una grande quantità (multum), sia un eccesso (nimis). L’ambivalenza semantica ha permesso all’italiano antico di usare “troppo” in entrambi i valori, fino a che la lingua moderna non ha ristretto il campo d’uso al secondo, quello di “eccessivamente”.
Il mutamento semantico
Col tempo, l’accezione di “troppo” come “molto” si è progressivamente perduta. Le edizioni del Vocabolario della Crusca fino alla quarta lo registravano con entrambe le sfumature, ma dal Seicento in avanti l’italiano standard ha privilegiato il senso di eccesso. Questo spostamento semantico ha portato alla percezione, ancora viva oggi, che “troppo” non sia compatibile con il comparativo, poiché il confronto richiede termini proporzionati, mentre l’eccesso esorbitante romperebbe la logica della comparazione.
Così, espressioni come “troppo meglio” o “troppo peggiore” oggi suonano scorrette, o quantomeno colloquiali e poco sorvegliate. L’italiano moderno ha affidato stabilmente il ruolo di intensificatore positivo a “molto”.
Una sopravvivenza nel parlato
Nonostante l’esclusione dallo standard, l’uso di “troppo” come sinonimo di “molto” non è del tutto scomparso. Resiste nei dialetti e riemerge ciclicamente nella lingua parlata, soprattutto in contesti giovanili e informali.
Un esempio tipico è l’uso esclamativo: “Giorgio è troppo simpatico!”, che non significa “eccessivamente simpatico”, ma piuttosto “molto simpatico”, quasi come un superlativo assoluto (simpaticissimo). È probabile che questa reinterpretazione sia nata da frasi ellittiche come “Giorgio è troppo simpatico per fare la parte del cattivo”: eliminata la subordinata, l’avverbio è stato risemantizzato come intensificatore positivo.
Questa tendenza non è marginale: nell’italiano contemporaneo “troppo” ha trovato un nuovo spazio espressivo, soprattutto tra i giovani e nei registri colloquiali, come rafforzativo di qualità positive o negative.
La riemersione nei comparativi
Accanto a questa evoluzione, si nota anche un parziale ritorno dell’uso antico nei comparativi. In rete e in contesti parlati si incontrano frasi come: “Il diametro del perno è troppo più grande del foro per potercelo inserire”. Qui “troppo” conserva il valore di “eccessivamente”, ma entra comunque in un costrutto comparativo (più grande di).
Pur non essendo ancora accolto come uso standard, questo fenomeno mostra che l’antico valore di “troppo” come intensificatore dei comparativi non è del tutto morto: riaffiora in modo spontaneo, specialmente in registri tecnici, comici o informali.
Una riflessione diacronica
Il percorso di “troppo” è esemplare di come le lingue evolvano ridistribuendo i valori semantici delle parole. Da avverbio polisemico e flessibile, capace di indicare tanto quantità quanto eccesso, si è ristretto all’uso moderno di “eccessivamente”. Tuttavia, proprio la vitalità della lingua parlata lo sta spingendo a recuperare almeno in parte il significato originario di “molto”.
Questo dimostra come i mutamenti linguistici non siano mai lineari o irreversibili: antichi usi possono riaffiorare, se trovano un terreno fertile nella comunicazione quotidiana. Nel caso di “troppo”, il parlato giovanile e i media digitali hanno avuto un ruolo decisivo nel riattivarne il valore positivo. Per saperne di più: Meglio evitare il troppo coi comparativi.