Lingua italiana: è corretto “purtroppo” o “pultroppo”?
Vediamo assieme quale delle due forme tra “purtroppo” e “pultroppo” è la forma corretta secondo le norme della lingua italiana.
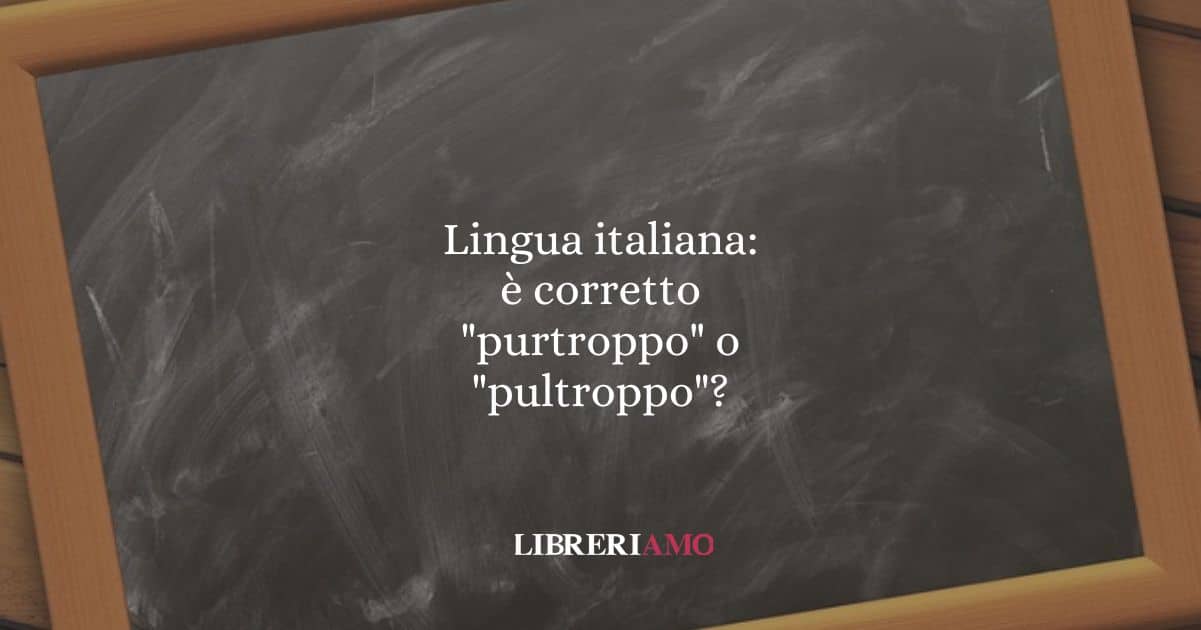
Il lessico della lingua italiana custodisce parole dalla storia complessa, talvolta sorprendente, altre volte ingannevole, soprattutto quando la loro forma è stata nascosta da secoli di semplificazioni fonetiche e trasformazioni morfologiche. Tra queste parole figura «purtroppo», un avverbio comunissimo nel parlato e nello scritto, utilizzato per esprimere rammarico, sconforto, dispiacere o fatalità. Accanto a purtroppo, tuttavia, compare spesso una variante scorretta ma molto diffusa: «pultroppo». Una forma che affiora regolarmente nei messaggi informali, online, nei social network e persino in contesti pubblici, dando vita a un fenomeno di errore ortografico che merita qualche riflessione.
Lingua italiana e paretimologie
Partiamo dall’unica forma corretta: purtroppo. Essa deriva da una locuzione più antica: per troppo, cioè «per eccesso», «per una ragione eccessiva», «per una sventura troppo grande». Questa espressione si è contratta nel corso dei secoli, come spesso accade nella storia delle lingue, fondendo suono e significato fino a diventare un’unica parola. Il passaggio da per troppo a purtroppo non è lineare nell’aspetto, ma è perfettamente coerente dal punto di vista fonetico: la /e/ di per tende a indebolirsi e a trasformarsi in /u/, mentre la consonante /r/ può subire assimilazioni con la consonante iniziale della parola successiva. Il risultato è appunto pur troppo, forma ancora attestata nella lingua letteraria, da cui deriva direttamente purtroppo.
Il significato moderno dell’avverbio conserva tracce dell’idea originaria: «per un fatto eccessivo, per una sventura», e quindi «ahimè», «sfortunatamente». È una parola che porta con sé un’aura di fatalismo: indica una realtà spiacevole che non si può cambiare o che si constata con amarezza. La forza emotiva di purtroppo è parte integrante della comunicazione quotidiana: lo usiamo per introdurre cattive notizie, per scusarci, per prendere atto di limiti e circostanze negative. È un avverbio che disegna i contorni dell’esistenza umana, con le sue cadute, i suoi vincoli e la sua imperfezione.
Se purtroppo è parola antica e solida nella struttura, la forma pultroppo è invece una deviazione grafica e fonetica senza alcun fondamento etimologico. Perché allora così tante persone la utilizzano? Le cause sono diverse, e tutte istruttive per comprendere come funziona l’italiano contemporaneo.
La prima causa è fonetica. Nel parlato, soprattutto nel parlato rapido, la sequenza delle consonanti in purtroppo tende a essere poco percepita con precisione: pur-troppo, con il gruppo /rt/ non sempre nitido. Molti parlanti realizzano inconsapevolmente una semplificazione fonetica che porta alla percezione della parola come pul-troppo, sostituendo /r/ con /l/, una consonante alveolare che può scivolare con facilità nella pronuncia, soprattutto in molte aree geografiche dell’Italia. Questa sostituzione non è un caso: lo scambio tra /r/ e /l/ — un fenomeno noto come rotacismo o lambdacismo — è ben documentato nella fisiologia del linguaggio infantile e in certi regionalismi.
La seconda causa riguarda l’influenza della scrittura digitale. La velocità della comunicazione online, l’assenza di rilettura, l’uso di tastiere non sempre comode e l’assenza di autocorrettori efficaci favoriscono l’emergere di forme distorte. Pultroppo appare spesso come un errore di battitura che, ripetuto e condiviso, finisce per radicarsi nella memoria visiva dei parlanti.
Una terza causa è di ordine cognitivo. Per molti, pultroppo «suona bene», cioè appare plausibile perché segue una sorta di regola immaginaria: le parole italiane con pul- sono molte (pulire, pulsare, pungere → pungolare, purtroppo → pultroppo), e la sostituzione di una consonante crea una forma percepita come fluida, quasi naturale. La lingua, dal resto, ha meccanismi di analogia molto potenti: se una forma assomiglia ad altre forme già note, il nostro cervello è portato a considerarla accettabile.
La norma
Ma l’italiano normativo è inequivocabile: pultroppo è sbagliato, non ha storia, non ha etimologia, non ha dignità linguistica. Rimane un errore frequente ma privo di legittimità grammaticale. È interessante osservare che persino gli strumenti di correzione automatica lo segnalano come errore, perché non rientra nemmeno tra le varianti rare o arcaiche apprezzate nei testi letterari.
La vicenda di purtroppo/pultroppo ci offre un insegnamento più generale: anche le parole più comuni possono generare dubbi e distorsioni, e la percezione soggettiva non sempre coincide con la correttezza linguistica. La forma corretta, purtroppo, è parte di una storia lunga e coerente, mentre pultroppo rappresenta un tipico caso di interferenza tra parlato, velocità comunicativa e analogie improprie.
Conoscere queste differenze non significa soltanto evitare errori: significa comprendere meglio l’evoluzione della lingua italiana e i meccanismi che rendono possibile — e talvolta problematica — la comunicazione quotidiana. In un mondo in cui le parole corrono veloci tra messaggi, notifiche e conversazioni frammentate, ricordare la forma corretta purtroppo non è solo un esercizio di precisione: è un modo per mantenere vivo il legame con la storia profonda della lingua e con la sua capacità di esprimere, con esattezza e bellezza, anche il dispiacere.