Lingua italiana: è corretto usare il termine “degenero”?
Scopriamo se usare il neologismo della lingua italiana “degenero” è corretto o è semplicemente una parola sgrammaticata.
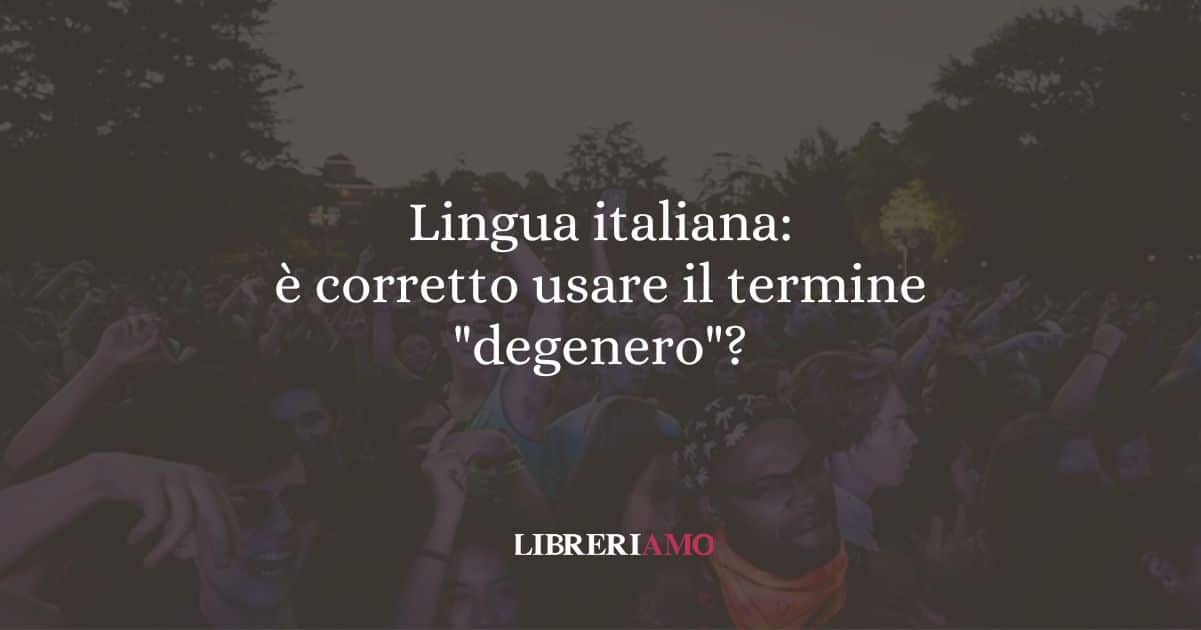
Nella lingua italiana e nel linguaggio giovanile contemporaneo, poche parole hanno avuto un’ascesa così rapida e trasversale come degenero. È un termine che suona rumoroso, energico, quasi sfrontato — e infatti lo è. Nata nei primi anni Duemila, in particolare nell’ambiente urbano lombardo, degenero è passata dai blog e dai social alle conversazioni quotidiane, fino a entrare nel linguaggio mediatico, pur senza essere ancora accolta dai principali dizionari dell’italiano. Eppure, come spesso accade con le parole nate “dal basso”, il suo successo linguistico è il segnale di un cambiamento culturale più profondo: un modo nuovo e ironico, ma anche identitario, di vivere e nominare la realtà.
Lingua italiana e neologismi
Dal punto di vista grammaticale, degenero è un sostantivo maschile deverbale derivato dal verbo degenerare — “mutare in peggio, perdere le qualità originarie” — senza l’aggiunta di suffissi. È un processo perfettamente regolare nella morfologia italiana, analogo a quello che produce parole come arrivo da arrivare o distacco da distaccare. Tuttavia, a differenza di questi esempi “neutri”, degenero porta con sé una sfumatura espressiva più vivace, più emotiva, e nel suo uso comune si allontana dal senso strettamente etimologico.
Il significato originario — “mutamento in peggio” — sopravvive in alcuni contesti più formali o giornalistici (“il dibattito è degenerato”, “evitare fenomeni di degenero nella movida”), ma è soprattutto il secondo valore, quello colloquiale e gergale, ad aver conquistato l’uso quotidiano: degenero come sinonimo di “gran confusione, baldoria incontrollata”, spesso connotata da un tono divertito, ironico, euforico. Dire “ieri sera è stato un degenero” equivale, nel linguaggio dei giovani, a dire che la serata è sfuggita a ogni controllo — ma in senso positivo: un caos vitale, una festa senza limiti, un momento di libertà totale.
La prima attestazione documentata del termine risale al 2007, in un blog milanese dedicato alla “lingua e mitologia urbana”. Tuttavia, già nel 2006 il nome compare nella denominazione di una casa discografica indipendente, Degenero Records, segno che la parola circolava in certi ambienti giovanili underground, legati alla musica punk e alternative. La diffusione successiva è stata rapida: dai blog ai social (Twitter/X nel 2009), poi ai giornali (dal 2008 in la Repubblica), fino a una presenza stabile nel lessico quotidiano di una generazione.
Ciò che rende degenero interessante non è solo la sua storia recente, ma il modo in cui ha ribaltato il significato originario del verbo da cui deriva. Se degenerare indica un peggioramento, una perdita di forma o di valore, degenero nel linguaggio dei giovani rovescia questa connotazione negativa: diventa sinonimo di vitalità, di eccesso liberatorio, di partecipazione collettiva. In altre parole, ciò che “degenera” non è necessariamente qualcosa che va distrutto o condannato, ma qualcosa che si trasforma, che rompe gli schemi — anche solo per una notte.
Questa reinterpretazione semantica è tipica del linguaggio giovanile, che spesso si appropria di parole “serie” per reinventarle in chiave ironica o affettiva. È un processo di ri-significazione, cioè di ribaltamento simbolico: l’ordine adulto vede “confusione”, i giovani vedono “divertimento”; dove gli uni percepiscono “perdita di controllo”, gli altri leggono “esperienza collettiva, intensità, energia”. Degenero, in questo senso, è una parola che esprime appartenenza: chi la usa si riconosce in un certo modo di vivere e raccontare la socialità contemporanea.
Dal punto di vista geografico, il termine ha avuto la sua culla linguistica in Lombardia, da cui si è poi diffuso in Toscana e in altre regioni, soprattutto attraverso i social e i media digitali. La sua presenza è fortemente connessa al contesto della movida, delle feste studentesche, dei raduni spontanei, ma anche ai toni iperbolici tipici del linguaggio online. “Facciamo il degenero”, “stasera degenero totale”, “è stato un degenero assurdo”: frasi che circolano nei post, nei video, nei messaggi vocali, e che raccontano più di un semplice evento caotico — raccontano uno stato d’animo, un atteggiamento verso la vita.
Curiosamente, degenero non è un caso isolato. Come osservano gli studiosi di linguistica, la sua formazione può essere stata influenzata da parole come degrado o declino, anch’esse derivate da verbi con il prefisso de-, che indica privazione o discesa. Tuttavia, a differenza di queste parole ormai “istituzionalizzate”, degenero mantiene una carica espressiva nuova, fresca, capace di adattarsi a contesti diversi — dal linguaggio ironico dei social a quello più riflessivo dei media.
Il fatto che la parola non compaia ancora nei grandi dizionari dell’italiano — nemmeno nelle edizioni più recenti del Treccani, del Devoto-Oli o dello Zingarelli — non ne riduce la legittimità. Al contrario, dimostra come il lessico viva e si evolva prima di essere codificato. Degenero è una parola pienamente italiana, formata secondo regole regolari e coerenti, ma nata al di fuori dei canali tradizionali della lingua “colta”. È, per così dire, una parola dal basso, cresciuta nell’ecosistema digitale e poi migrata verso l’uso comune.
In fondo, degenero rappresenta una fotografia linguistica della contemporaneità: un termine che unisce caos e creatività, ribellione e ironia. È la testimonianza di come i giovani non solo parlano diversamente, ma costruiscono nuovi significati, reinventando la lingua come spazio di libertà. Nella loro voce, “fare il degenero” non è sinonimo di perdere il controllo, ma di affermare la propria presenza nel mondo — rumorosa, irriverente, ma profondamente vitale.
E così, da semplice “mutamento in peggio”, degenero diventa il simbolo di un mutamento in meglio del linguaggio: un piccolo segno della sua inesauribile capacità di adattarsi, cambiare, e — proprio come la società che lo parla — “degenerare” in qualcosa di nuovo.