Lingua italiana: è corretto scrivere “aldilà” o “al di là”?
Scopriamo se secondo le norme della lingua italiana è corretto scrivere “al di là” o la forma univerbata “aldilà”, o magari entrambe in contesti diversi.
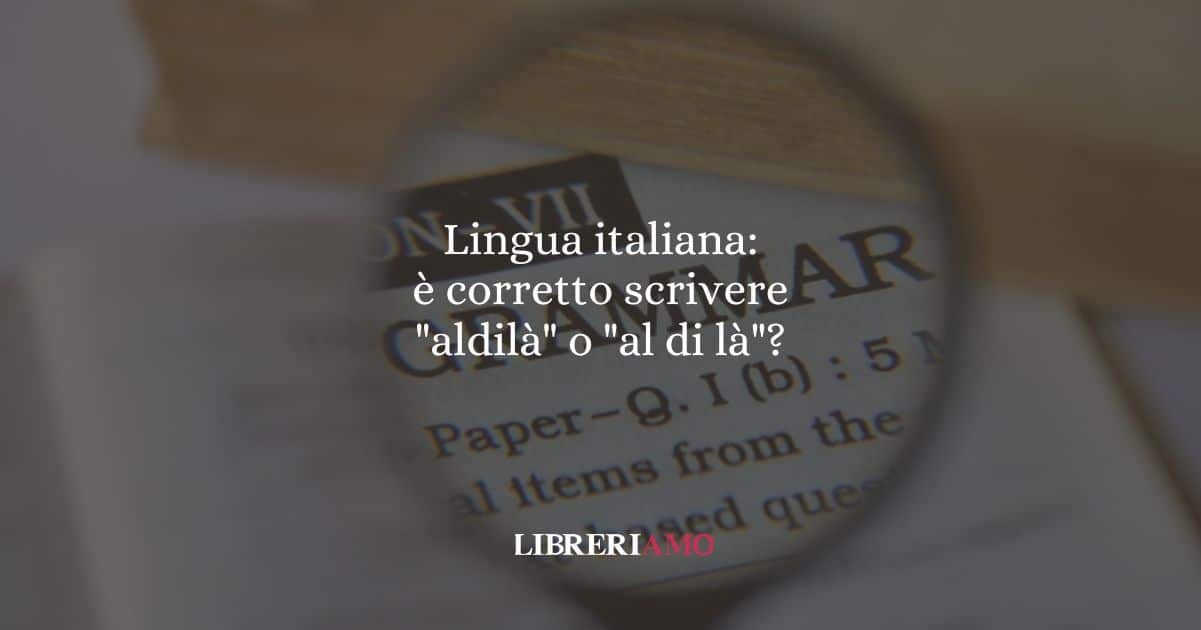
La lingua italiana, ricca di sfumature e di evoluzioni storiche, presenta spesso dubbi che riguardano non tanto la corretta ortografia quanto la distinzione tra forme univerbate e forme separate. Il caso di “al di là” e “aldilà” è uno dei più interessanti: due grafie quasi identiche, ma non sovrapponibili, che hanno assunto nel tempo funzioni differenti, tanto nell’uso scritto quanto in quello parlato. Comprendere questa distinzione non è soltanto un esercizio grammaticale, ma anche un modo per osservare come una lingua plasmi i propri strumenti per esprimere concetti astratti, direzioni, metafore, e persino un’intera concezione dell’aldilà inteso come vita dopo la morte.
Lingua italiana e forme univerbate
La prima distinzione fondamentale riguarda la funzione grammaticale. “Al di là”, scritto separatamente, è una locuzione avverbiale o preposizionale, e viene utilizzato per indicare uno spazio, reale o figurato, che si trova oltre un limite. È l’equivalente di espressioni come “oltre”, “più avanti”, “dall’altra parte”. In frasi come “al di là del fiume”, “al di là delle apparenze” o “al di là del confine”, la locuzione conserva una forte dimensione spaziale, fisica o metaforica. È interessante notare come l’italiano contemporaneo utilizzi quasi esclusivamente questa versione per indicare ciò che è oltre un determinato limite, mentre altre forme storiche, come “di là da”, sono oggi meno frequenti, pur restando corrette e avendo un sapore più letterario.
La locuzione “al di là” è rifatta sul francese au-delà, che presenta la stessa costruzione e lo stesso significato. Ciò rivela la forte influenza francese sulla lingua italiana tra Settecento e Ottocento, periodo in cui molte locuzioni preposizionali e avverbiali italiane furono rimodellate sul modello della lingua d’oltralpe. La presenza di “di” in italiano, come nelle costruzioni al di sopra, al di sotto, al di qua, al di là, segue uno schema ormai fortemente consolidato, che rende questa locuzione perfettamente naturale nell’uso moderno.
Diverso è il caso di “aldilà”, scritto in un’unica parola. Qui la univerbazione non risponde a una regola generale della lingua — infatti, non esiste una norma precisa che stabilisca quando si debba scrivere un’espressione univerbata o separata — ma riflette l’uso consolidato nella tradizione linguistica e letteraria italiana. “Aldilà” funzionava e funziona tuttora come sostantivo maschile, e indica l’“oltretomba”, la “vita dopo la morte”, l’universo metafisico delle credenze religiose o spirituali. È comune trovare frasi come “L’aldilà è un mistero”, “Credono nell’aldilà”, oppure “La domanda sull’aldilà accompagna l’umanità da sempre”. In questi casi, la parola ha una funzione puramente nominale, designa un concetto autonomo e compatto, e grazie alla univerbazione si distingue chiaramente dalla locuzione preposizionale.
Questa differenza d’uso non è puramente formale: nasconde una diversa modalità di percepire i concetti espressi dalle due forme. “Al di là” esprime movimento, passaggio, superamento; “aldilà” esprime invece un luogo o una condizione statica, spesso carica di significati religiosi, filosofici e simbolici. Le due forme convivono, dunque, perché rispondono a esigenze espressive distinte. L’italiano ha preferito evitare l’ambiguità con una soluzione semplice e intuitiva: grafia separata per la locuzione, grafia univerbata per il sostantivo.
Nonostante ciò, il confine non è sempre stato così netto. In passato era più frequente trovare usi variabili, e soprattutto il sostantivo “aldilà” non era sempre scritto in forma univerbata. L’italiano, come ogni lingua viva, conosce oscillazioni, e qualche autore moderno o contemporaneo potrebbe occasionalmente usare una forma per l’altra, per scelta stilistica o per variazione espressiva. Ma nella norma attuale — la norma dell’uso, quella che si ricava dall’osservazione della lingua parlata e scritta — la distinzione è ormai piuttosto stabile.
Cosa sono i conglomerati?
È interessante anche notare come la forma più antica, “di là da”, oggi sopravviva quasi solo in contesti letterari o in espressioni fisse come “di là da venire”, che indica un evento molto lontano nel tempo, quasi irrealizzabile. Questa forma, considerata più elegante e dal sapore arcaico, mostra come la lingua abbia progressivamente semplificato il proprio sistema preposizionale, preferendo costruzioni più regolari come al di là, al di sopra, al di sotto. L’evoluzione verso forme più uniformi e prevedibili è uno dei tratti caratteristici del cambiamento linguistico.
In conclusione, la domanda “al di là o aldilà?” non ha una risposta unica, perché entrambe le forme sono corrette, ma non intercambiabili. La distinzione si basa sulla funzione grammaticale e sul significato: locuzione avverbiale o preposizionale per indicare un superamento (“al di là”), sostantivo maschile per indicare l’oltretomba (“l’aldilà”). È una differenza sottile ma fondamentale, che permette alla lingua di mantenere chiarezza e precisione. Ed è anche un esempio perfetto di come l’italiano sappia articolarsi con eleganza tra espressione concreta e concetto astratto, tra direzione spaziale e domanda metafisica.
Il book-game per scoprire l’italiano giocando e allenando la mente
Se non volete scoprirvi impreparati su questa o altre curiosità linguistiche, vi consigliamo il libro “501 quiz sulla lingua italiana” (Newton Compton Editori, 2025) di Saro Trovato: ben 501 quiz, attraverso i quali ciascuno potrà misurare, in maniera obiettiva, la propria conoscenza della lingua italiana. Si va dalla coniugazione dei verbi al corretto uso di apostrofi e accento, passando per test che invitano a mettersi alla prova circa l’origine delle parole della lingua italiana e quiz per dimostrare la conoscenza di chi sono i padri fondatori della nostra amata lingua, da Dante a Manzoni.
Il tutto senza limiti: si dalla grammatica all’ortografia, dalla storia della lingua al suo utilizzo parlato e contemporaneo. Una bella sfida da affrontare da soli o da condividere in gruppo, con gli amici o in famiglia, per divertirsi ma anche per esercitare le proprie capacità mnemoniche, dedicata a tutti gli amanti dell’immenso patrimonio linguistico italiano: un tesoro da tutela intriso di identità, cultura, creatività, memoria collettiva. Un “libro sociale” da condividere e da regalare.