Lingua italiana: ha senso dire “giovane ragazzo”
Scopriamo assieme se secondo le norme della lingua italiana l’espressione “giovane ragazzo” è sensata o è una ridondanza evitabile.
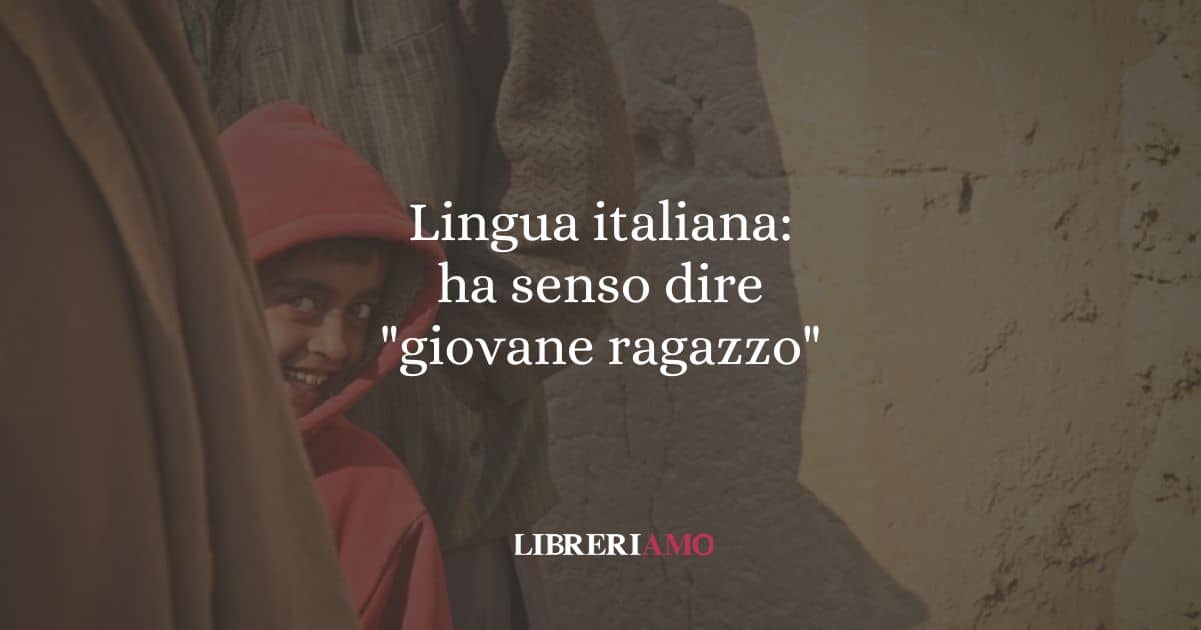
L’espressione della lingua italiana “giovane ragazzo” – insieme alla sua forma femminile “giovane ragazza” – è una di quelle formule che, a prima vista, fanno sorridere per la loro apparente tautologia. A cosa serve, infatti, aggiungere giovane a ragazzo, quando il significato del secondo termine già implica giovinezza? Eppure, come accade spesso nella storia della lingua, dietro ciò che appare una semplice ridondanza si nasconde un processo complesso di stratificazione semantica, mutamento sociolinguistico e interferenza tra codici. L’analisi delle attestazioni storiche e delle tendenze dell’italiano contemporaneo mostra che questa costruzione, lungi dall’essere un mero errore o un’esuberanza giornalistica, affonda le radici in una lunga tradizione d’uso e riflette importanti trasformazioni nella percezione sociale dell’età e dei ruoli generazionali.
Lingua italiana e giovinezza
Un primo passo utile consiste nel considerare separatamente i due componenti del sintagma. L’aggettivo giovane, dal latino iuvenis, è stato da sempre associato a un’età di transizione, quella “della giovinezza e, in genere, della prima età della vita”, come riporta il Grande Dizionario della Lingua Italiana (GDLI). Già in Petrarca – “Giovene donna sotto un verde lauro vidi, più bianca e più fredda che neve” – l’aggettivo ha un valore poetico e universale, non strettamente anagrafico: indica non solo un’età, ma una condizione dell’animo e della bellezza.
Nel Medioevo e nel Rinascimento, giovane si combina spesso con termini come donna, dama o pastorello, ma non con ragazzo o ragazza, che entreranno più tardi nell’uso comune. Interessante, tuttavia, è il caso di espressioni antiche come “garzone giovane di XV anni” (in Testi fiorentini del XIII secolo), dove giovane compare insieme a una determinazione dell’età. Si trattava, dunque, di un aggettivo che specificava una condizione fisiologica e sociale, e non solo cronologica.
Il termine ragazzo, dal canto suo, ha un’evoluzione semantica più recente. Nel lessico ottocentesco e novecentesco si estende dall’età adolescenziale fino alla giovinezza adulta, e assume anche sfumature affettive o morali: “è un buon ragazzo”, “è ancora un ragazzo” sono formule che non indicano l’età, ma un atteggiamento, una disposizione d’animo. In questo senso, la parola si emancipa dal suo valore anagrafico per diventare un indicatore sociale e psicologico. Nelle definizioni di Fanfani e Tommaseo, ragazzo può anche essere sinonimo di “persona ingenua” o “poco matura”, e lo stesso accade per ragazza, che nel XIX secolo viene usato anche come sinonimo di nubile (“è rimasta ragazza”) o con valore professionale (“ragazza di bottega”, “ragazza delle pulizie”).
Proprio questo slittamento semantico spiega la possibilità di combinare i due termini. Se ragazzo smette di indicare necessariamente un’età e diventa un marcatore sociale o psicologico, l’aggettivo giovane torna a qualificare in senso stretto la fascia anagrafica: un giovane ragazzo è dunque un ragazzo che è “ancora” giovane, cioè non adulto, non uomo, come accade spesso nel linguaggio giornalistico o sociologico. L’espressione risponde quindi al bisogno di precisare una soglia intermedia, in una società in cui le categorie di “infanzia”, “adolescenza” e “giovinezza” si sono progressivamente spostate e confuse.
Le attestazioni letterarie e giornalistiche confermano questa tendenza. Il GDLI registra l’espressione in Carlo Levi – “Egli avrebbe potuto, senza contraddire il suo ingenuo semplicismo di giovane ragazzo di buona famiglia…” (Cristo si è fermato a Eboli, 1945) – e, più tardi, in una citazione di Panorama del 1990 (“una storia sadomaso fra un uomo della upper class e una giovane ragazza”). In entrambi i casi, l’aggettivo sembra introdurre un’attenuazione o una sfumatura di ingenuità e inesperienza, che ragazzo o ragazza da soli non avrebbero reso con altrettanta forza.
Dalla seconda metà del Novecento in poi, la diffusione dell’espressione aumenta, grazie soprattutto all’influsso dei linguaggi mediatici e traduttivi. In molti casi, giovane ragazza è calco diretto del francese jeune fille o dell’inglese young girl, entrambi sintagmi perfettamente regolari nelle rispettive lingue, ma ridondanti in italiano.
L’importazione acritica di questi modelli ha favorito la diffusione del costrutto, prima nella lingua giornalistica e poi nel parlato comune. Nei registri burocratici e sociologici, inoltre, esso assume una funzione classificatoria: giovane ragazzo o giovane ragazza identificano i soggetti in età minorile o preadulta, in contrapposizione a categorie come giovane adulto o giovane donna. Da qui la sua frequenza nei resoconti di cronaca (“un giovane ragazzo di 17 anni è rimasto ferito…”) o nelle indagini sociologiche (“gruppi di giovani ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni”).
In prospettiva linguistica, dunque, la costruzione appare come l’esito di una doppia convergenza: da un lato, la tradizione italiana di giovane garzone e giovin signore, che introduceva un aggettivo attenuativo; dall’altro, l’influsso contemporaneo di modelli stranieri, che ne hanno consolidato l’uso nel linguaggio dei media. Il risultato è un sintagma percepito come naturale, benché tecnicamente ridondante.
A livello socioculturale, l’espansione di giovane ragazzo/ragazza risponde al fenomeno del giovanilismo linguistico, ossia alla tendenza a valorizzare la giovinezza come condizione permanente. In un contesto in cui i trentenni sono ancora detti “ragazzi” e i quarantenni “giovani uomini”, l’aggettivo giovane non serve più a distinguere per età, ma a enfatizzare una qualità desiderabile, quasi uno stato dell’essere. Come osservava Luca Serianni nella Prima lezione di grammatica (2008), simili ridondanze nascono “dalla scarsa pianificazione e dalla marcata espressività proprie del parlato”, ma si fissano nel linguaggio pubblico, dove diventano segnali di empatia e immediatezza.
La paura del tempo che passa
Il sintagma “giovane ragazzo” è dunque il sintomo di un mutamento più ampio: l’indebolimento delle categorie linguistiche legate all’età e la tendenza a sfumare le distinzioni tra adolescenza e maturità. In questo senso, non si tratta di un semplice errore, ma di una spia di evoluzione culturale. Forse, come suggerisce Paolo D’Achille, ragazzo e ragazza stanno progressivamente assumendo il ruolo di determinanti sociali, più che anagrafici: designano chi, nella percezione collettiva, è “ancora” giovane, o desidera apparirlo.
Così, la formula “giovane ragazzo” ci restituisce, in filigrana, l’immagine di una società che teme la vecchiaia e prolunga indefinitamente la giovinezza, persino nelle parole. In fondo, come scriveva Parini nel Giovin signore, la giovinezza non è solo un’età della vita, ma un modo di stare nel mondo — e l’italiano, con la sua ridondanza affettuosa, continua a ricordarcelo. Per saperne di più rimandiamo all’esaustivo articolo dell’Accademia della Crusca a cura della docente Gabriella Alfieri: Giovane ragazzo/ragazza.