Lingua italiana: si dice “procrastinare” o “procastinare”?
Scopriamo qual è la forma corretta della parola della lingua italiana che descrive l’atteggiamento della persone che rimandano gli impegni al futuro.
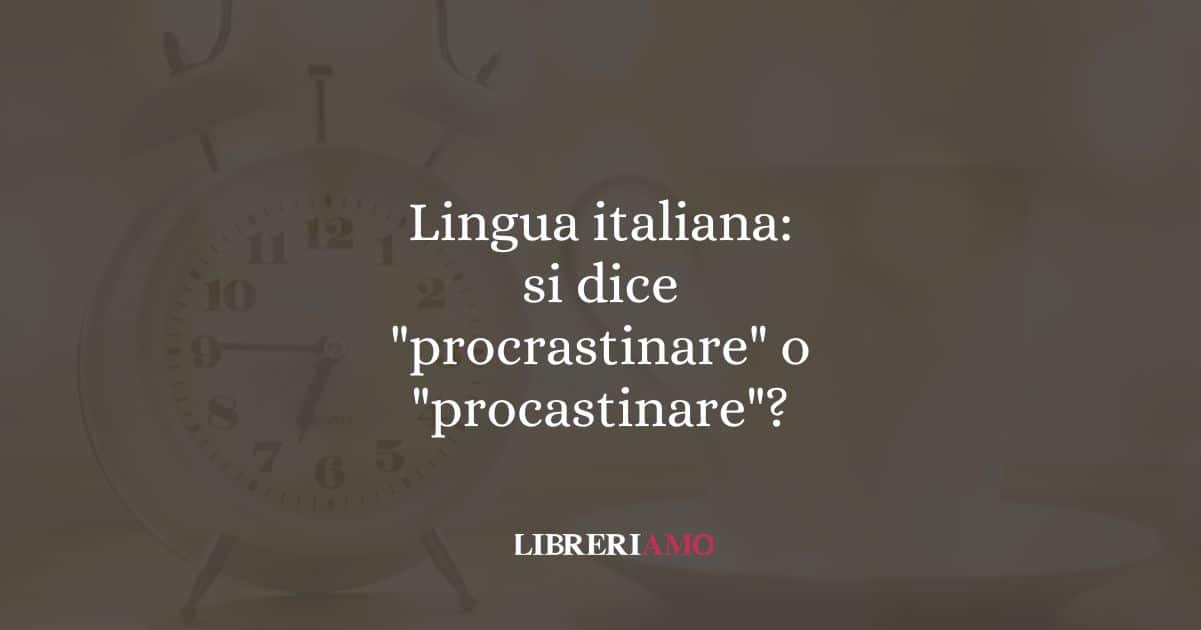
Nella lingua italiana capita spesso che alcune parole, pur avendo una forma ufficiale e corretta, generino confusione nell’uso quotidiano. È il caso di “procrastinare”, verbo che significa rinviare, rimandare, differire a un tempo futuro. Una parte dei parlanti, infatti, tende a utilizzare o a scrivere la variante deformata “procastinare”, che tuttavia non ha fondamento né etimologico né lessicografico.
Il fenomeno non è raro: molte parole lunghe, di origine dotta o che contengono sequenze consonantiche meno familiari, finiscono per essere adattate in forme semplificate. Ma in questo caso il problema non è soltanto ortografico: riguarda anche la comprensione del percorso etimologico del termine e, di conseguenza, la sua corretta pronuncia e scrittura.
Lingua italiana: l’etimologia di “procrastinare”
Per stabilire quale sia la forma corretta, occorre tornare alle origini. “Procrastinare” deriva dal latino procrastinare, verbo composto da due elementi:
-
pro- = “avanti, in avanti”;
-
crastinus = “del domani”, a sua volta da cras = “domani”.
Il significato letterale è dunque “rinviare a domani”. È evidente come il senso etimologico coincida perfettamente con l’uso attuale: procrastinare significa spostare a un futuro indefinito (spesso con l’idea di una scelta evitante o pigra) ciò che dovrebbe essere fatto nel presente.
In latino il termine è ampiamente attestato, sia in testi giuridici sia in contesti morali e filosofici. Il verbo passa direttamente alle lingue romanze e al lessico dotto italiano senza subire variazioni sostanziali.
Perché nasce l’errore “procastinare”
Se “procrastinare” è la forma corretta e documentata, da dove deriva allora l’errata variante “procastinare”?
Si tratta di un tipico caso di sincope consonantica, cioè la caduta di una consonante ritenuta superflua o difficile da pronunciare. La sequenza -cras- tra due consonanti (pro-cras-tinare) può sembrare “ostica”, e molti parlanti, inconsciamente, la semplificano eliminando la r centrale: da qui la diffusione di “pro-cast-inare”.
Il meccanismo psicologico è simile a quello che porta a deformazioni in altre parole: basti pensare a “conoscenza” che diventa “cognoscenza” per alcuni o, al contrario, a “obbligo” che viene talvolta ridotto a “obligo”. In tutti questi casi si tratta di errori di ipercorrettismo o di semplificazione fonetica.
Le attestazioni nei dizionari
Se consultiamo i principali vocabolari italiani – Treccani, Zingarelli, Devoto-Oli – troviamo solo ed esclusivamente la voce “procrastinare”. Nessuna fonte lessicografica accredita “procastinare”, che è considerata una forma errata, un refuso o una deformazione popolare.
Lo stesso accade nelle lingue sorelle: in francese esiste procrastiner, in spagnolo procrastinar, in inglese to procrastinate. In tutti i casi la presenza della r dopo pro- è costante e imprescindibile.
Questo dettaglio rafforza ulteriormente l’idea che “procastinare” sia una variante senza alcun fondamento storico o linguistico.
L’uso attuale e la percezione della parola
Nonostante la chiarezza delle fonti, “procastinare” continua a circolare, soprattutto nel linguaggio informale, sul web e nei social network. È facile imbattersi in post o commenti in cui la grafia scorretta viene adoperata senza consapevolezza.
La ragione è duplice:
-
Difficoltà fonetica: la sequenza -cras- è inconsueta e richiede più attenzione nell’articolazione;
-
Diffusione virale degli errori: una volta che una forma scorretta circola ampiamente in rete, tende a consolidarsi come se fosse legittima, soprattutto per i parlanti meno abituati a verificare le fonti linguistiche.
Tuttavia, in contesti formali – saggi, giornalismo, accademia – “procastinare” è percepito come un errore evidente e penalizzante.
Il valore concettuale di “procrastinare”
Oltre all’aspetto ortografico, “procrastinare” è un termine che porta con sé un valore concettuale molto interessante. Indica infatti una tendenza psicologica e comportamentale molto diffusa: quella di rimandare, di posticipare impegni e responsabilità.
In psicologia il fenomeno della procrastinazione è studiato come atteggiamento che può derivare da ansia, perfezionismo, paura del fallimento o semplice disorganizzazione. L’italiano, come molte altre lingue, ha ereditato dal latino non solo la parola, ma anche un concetto universale e profondamente umano.
Ecco perché è importante salvaguardarne la forma corretta: essa non è solo una questione di grafia, ma anche di fedeltà a un’eredità linguistica e culturale che dura da secoli.
Tra “procrastinare” e “procastinare” non c’è alcun dubbio: la forma corretta è la prima, coerente con l’etimologia latina, riconosciuta da tutti i vocabolari e in linea con le corrispondenti parole delle lingue straniere.
“Procastinare” è invece un errore diffuso, frutto di semplificazione fonetica e di circolazione incontrollata nel linguaggio informale. Non va quindi considerato accettabile in contesti formali o colti, anche se la sua diffusione spiega quanto gli usi comuni possano talvolta deviare dalla norma.
In definitiva, usare “procrastinare” in modo corretto significa rispettare non solo la grammatica e la storia della nostra lingua, ma anche dare il giusto peso a un concetto che descrive un tratto molto umano: la tentazione, sempre presente, di rimandare a domani ciò che dovremmo fare oggi.