Lingua italiana: origine e significato di “capro espiatorio”
Scopriamo l’origine di un’espressione che ha origini addirittura veterotestamentarie ed è arrivata fino a noi entrando nella lingua italiana.
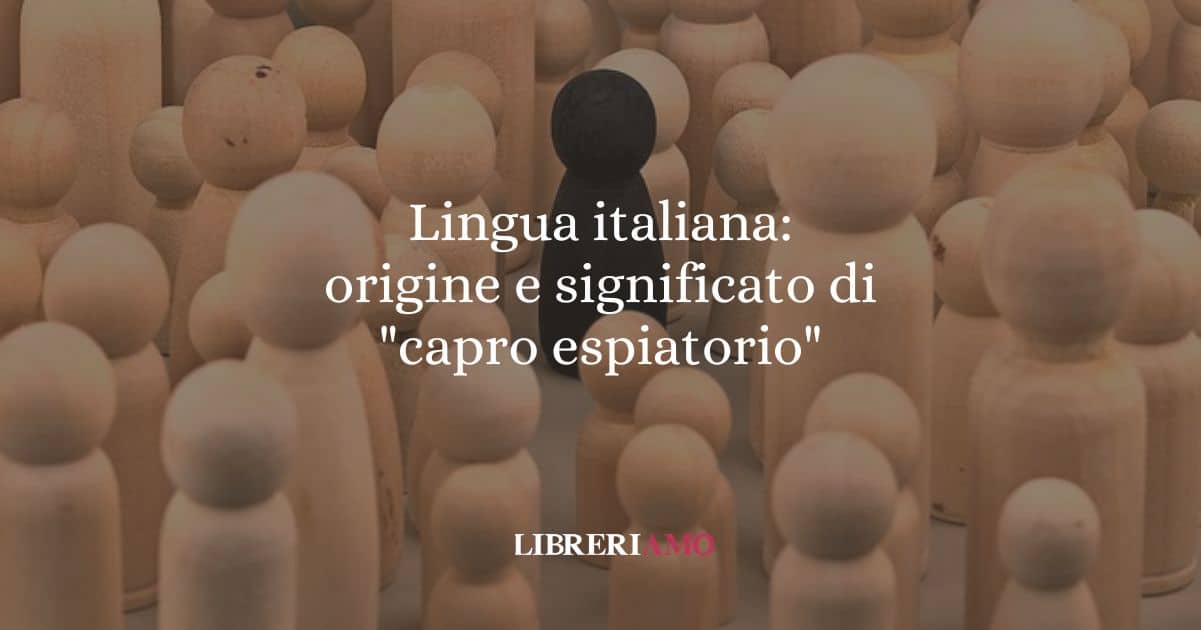
L’espressione “capro espiatorio” è oggi di uso frequente nella lingua italiana e in molte altre lingue europee. Con essa si intende una persona o un gruppo che viene ritenuto colpevole di un male collettivo e sul quale si scaricano responsabilità, errori e tensioni sociali, spesso in maniera ingiusta e sproporzionata. Per comprendere fino in fondo il significato e la forza di questa formula, è necessario risalire alla sua origine biblica e ai rituali che le hanno dato vita.
Le origini nel Levitico e l’uso nella lingua italiana
Il termine proviene dal Libro del Levitico (capitolo 16), uno dei testi fondamentali della Torah, che descrive le norme rituali del popolo ebraico. In occasione dello Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, il sommo sacerdote aveva il compito di celebrare un rito particolare che coinvolgeva due capri. Uno veniva sacrificato a Dio, mentre l’altro — detto appunto capro espiatorio o capro emissario (dal latino hircus emissarius, traduzione dell’ebraico ‘ăzā’zēl) — era simbolicamente caricato di tutte le colpe e i peccati della comunità.
Il sacerdote imponeva le mani sul capo dell’animale, trasferendo così i peccati del popolo. Poi il capro veniva condotto nel deserto e abbandonato, portando con sé il peso delle colpe e liberando la comunità dal male. Questo rito aveva un significato di purificazione collettiva: attraverso il sacrificio simbolico dell’animale, il popolo d’Israele rinnovava la propria alleanza con Dio e trovava una nuova possibilità di ricominciare.
Un rito condiviso da molte culture
Il Levitico ci restituisce la testimonianza più celebre di questo rituale, ma pratiche simili erano conosciute anche da altre civiltà antiche. Babilonesi, Assiri e Greci conoscevano la dinamica del trasferimento simbolico del male su un animale o su un essere umano, destinato poi all’allontanamento o alla morte.
Nell’Atene classica, ad esempio, durante le cerimonie delle Targelie, si sceglieva una vittima — chiamata pharmakos — che veniva caricata delle colpe della comunità e scacciata dalla città, a volte addirittura uccisa. In questo modo, la società si liberava simbolicamente dalle impurità e dalle tensioni interne.
Questa somiglianza tra culture diverse rivela un tratto comune dell’umanità: la necessità di individuare un soggetto su cui riversare colpe e paure, trasformandolo in un “contenitore” del male collettivo.
Dal rito al linguaggio comune
Con il tempo, il termine “capro espiatorio” è uscito dal contesto rituale e religioso per diventare un’espressione figurata della lingua comune. Oggi viene usata per indicare una persona, un gruppo o persino un’istituzione che viene accusata o punita per alleggerire la responsabilità degli altri.
Si pensi, ad esempio, a un’azienda che, di fronte a un fallimento, individua un dipendente come responsabile unico, anche se le cause del problema sono strutturali e diffuse. Oppure ai fenomeni politici e sociali in cui un’intera categoria (gli immigrati, i giovani, gli anziani, le minoranze) viene indicata come causa dei mali della società. In tutti questi casi, il “capro espiatorio” diventa il bersaglio su cui scaricare colpe, liberando gli altri da un senso di responsabilità.
Il meccanismo psicologico e sociale
La dinamica del capro espiatorio è tanto antica quanto attuale. Funziona perché rassicura la collettività, offrendo un bersaglio concreto e circoscritto alle paure e alle tensioni diffuse. Invece di affrontare la complessità dei problemi, si riduce tutto a una responsabilità individuale.
Questo meccanismo è stato analizzato da molti studiosi, tra cui il filosofo e antropologo René Girard, che ha visto nel sacrificio del capro espiatorio un principio universale delle società umane. Secondo Girard, il trasferimento della colpa su una vittima designata non è soltanto un atto rituale, ma una strategia di sopravvivenza delle comunità, capace di prevenire conflitti interni e di mantenere un’apparente coesione sociale.
Esempi storici
La storia offre innumerevoli esempi di “caccia al capro espiatorio”. Nel Medioevo, durante le pestilenze, gli ebrei furono spesso accusati di avvelenare i pozzi, diventando vittime di persecuzioni. Nel corso dei secoli, altre minoranze religiose o etniche sono state additate come responsabili di calamità naturali, crisi economiche o tensioni sociali.
In tempi più vicini a noi, il meccanismo si ripete in forme diverse: pensiamo ai migranti accusati di portare disoccupazione o insicurezza, o alle donne colpevolizzate per aver infranto ruoli tradizionali. La forza dell’immagine del “capro espiatorio” è proprio questa: svela una dinamica che, pur con volti diversi, attraversa le epoche e le culture.
Un invito alla responsabilità
Usare consapevolmente l’espressione “capro espiatorio” significa riconoscere che spesso i colpevoli designati non sono i veri responsabili. L’origine biblica ci ricorda che il rito aveva una funzione simbolica, collettiva, e non coincideva con una reale attribuzione di colpe. Oggi, invece, troppo spesso si tende a trasformare persone reali in capri espiatori, caricandole di un peso sproporzionato e ingiusto.
Riflettere su questa espressione è dunque un invito alla responsabilità: affrontare i problemi nella loro complessità, senza cercare scorciatoie che semplificano la realtà ma producono ingiustizie.
L’espressione “capro espiatorio”, radicata nel Levitico e nei rituali antichi, è diventata una metafora universale per descrivere il meccanismo con cui le società e gli individui cercano di liberarsi dal peso della colpa. Il suo valore linguistico e simbolico resta intatto: ogni volta che la usiamo, rievochiamo inconsciamente l’immagine di quell’animale caricato di peccati e condotto nel deserto.
Conservarne la memoria ci aiuta a non ripetere, nella vita quotidiana e nella storia, l’ingiustizia di attribuire colpe a chi non le porta davvero, ricordandoci che la vera espiazione nasce non dal sacrificio di una vittima, ma dalla capacità collettiva di assumersi responsabilità.