Lingua italiana: origine e significato del curioso verbo prillare
Scopriamo assieme l’origine e il significato di un verbo della lingua italiana ormai utilizzato solo in rarissime occasioni: prillare.
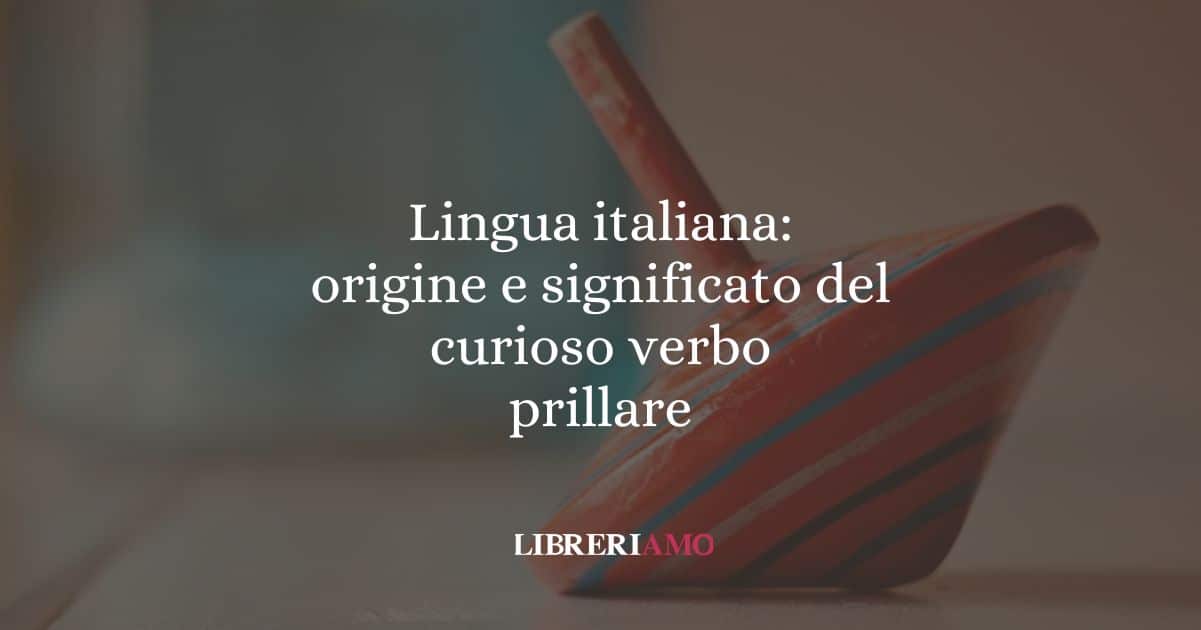
Il verbo della lingua italiana “prillare” è una di quelle parole che, pur appartenendo oggi al lessico letterario o regionale, conserva nella sua sonorità e nella sua storia una vivacità straordinaria. È un termine che sembra quasi evocare il suono e l’immagine del movimento che descrive: qualcosa che ruota, vibra, gira con agilità e rapidità, come una trottola o un fuso che danza nell’aria. Non a caso, la parola è di origine onomatopeica, e il suo suono, breve e scattante, richiama immediatamente l’idea del moto circolare e continuo, simile a quello di un birillo o di un oggetto che si muove con leggerezza e ritmo.
In un’epoca come la nostra, in cui il linguaggio tende sempre più verso la semplificazione e l’uniformità, riscoprire termini come prillare significa riappropriarsi di una ricchezza espressiva che la lingua italiana possiede e che spesso dimentichiamo. Dietro un verbo apparentemente minore si nasconde una straordinaria potenzialità evocativa: un modo di descrivere il mondo che unisce suono, gesto e immagine.
Origine e uso nella lingua italiana
Secondo i dizionari etimologici, prillare è una voce onomatopeica affine a birillo, e si afferma nel lessico toscano e letterario a partire dal tardo Ottocento, anche se le sue radici fonosimboliche rimandano probabilmente a un uso più antico e popolare. L’associazione con birillo non è casuale: entrambi i termini richiamano la rotazione, il moto rapido e allegro, e quel suono breve e vibrante che imita il rumore di un oggetto in movimento.
Il verbo nasce dunque da una percezione sonora e visiva: prillare è un termine che non solo descrive un’azione, ma ne restituisce quasi la sensazione fisica, come accade in molte parole onomatopeiche del patrimonio linguistico italiano (frullare, scintillare, gorgogliare, tremolare). Il suo suono contiene una musicalità intrinseca che lo rende immediatamente figurativo: basta pronunciarlo per immaginare qualcosa che ruota, brilla, o si muove con energia.
I significati principali
Nel suo uso più comune e letterario, prillare significa “girare rapidamente intorno a sé stesso”. È un verbo che descrive il movimento del fuso, della trottola, di un piattello, o più in generale di un oggetto che compie un movimento rotatorio vivace.
Eugenio Montale, in un celebre verso, scrive:
“nell’aria prilla il piattello, si rompe ai nostri colpi!”
Qui prillare suggerisce la traiettoria rapida e sospesa del piattello che, colpito, vibra e ruota nell’aria prima di frantumarsi. È un’immagine dinamica, quasi cinematografica, in cui il verbo dà corpo al movimento, ne cattura la tensione e la fugacità.
In un passo di Italo Calvino, invece, leggiamo:
“Intascò le biglie, facendole prillare tra le dita in fondo alla tasca del pastrano.”
Qui il verbo assume un tono più intimo e concreto: il piccolo gesto delle dita che fanno ruotare le biglie tra i palmi diventa quasi un segno di nervosismo o di riflessione. Prillare, in questo contesto, non è solo un movimento, ma un modo di riempire il silenzio, di trasformare un pensiero in gesto.
Emilio Cecchi, parlando di anfore che “imperceptibilmente prillavano sulla base affusolata”, ci offre invece un’immagine di oscillazione delicata: il verbo si carica di sfumature sottili, evocando il movimento lento e continuo di oggetti in equilibrio instabile. In questo senso, prillare si avvicina a tremolare o ondeggiare, ma mantiene una sua specificità, data dall’idea di un moto circolare, quasi danzante.
Usi estesi e figurativi
L’uso di prillare non si limita agli oggetti: può riferirsi anche alle persone, come notava già Tommaso Landolfi in un verso ironico e vivace:
“A ben mostrare la tua nuova gonna / Tu mi prilli dinanzi sul tappeto.”
In questo caso il verbo assume una valenza quasi teatrale: la donna che “prilla” davanti all’interlocutore compie piroette leggere, mostra la sua grazia e la sua civetteria. Il gesto è pieno di movimento e allegria, ma anche di una consapevole esibizione.
Nel linguaggio figurato, prillare può estendersi a tutto ciò che si muove con rapidità, leggerezza o capriccio: il vento che fa ruotare le foglie, un pensiero che gira nella mente, un sentimento che vibra come una trottola. R. Longhi parla di “rovesci improvvisi di foglie prillate dal vento”, e il verbo, ancora una volta, traduce in suono la vivacità della scena naturale.
Ciò che colpisce, nel verbo prillare, è la sua capacità poetica di incarnare un ritmo. È un verbo che non descrive soltanto: suggerisce, anima, dà corpo al movimento. In esso convivono la precisione del gesto e la leggerezza della musica. Ogni volta che compare in un testo, introduce una qualità visiva e sonora che arricchisce la frase, come un piccolo vortice linguistico.
Si potrebbe dire che prillare appartiene a quella categoria di parole “in movimento” della lingua italiana, come frullare, svolazzare, turbinare, che nascono dall’osservazione del mondo e dalla volontà di imitarne il ritmo. È un verbo che rende visibile il moto e udibile il suono, riunendo percezione visiva e acustica in un’unica immagine.
Il valore letterario e la sua rarità
Oggi prillare è considerato un termine toscano e letterario, quindi raro nel linguaggio comune. Tuttavia, la sua presenza in autori di grande rilievo — da Montale a Calvino, da Pascoli a Cecchi — ne testimonia la forza espressiva e la versatilità. Ogni volta che un autore lo utilizza, sembra voler evocare qualcosa di più di un semplice movimento: prillare diventa un segno di vita, di energia, di circolarità del tempo o del pensiero.