Lingua italiana: è corretto scrivere “taboo”, “tabu” o “tabù”?
Vediamo se secondo le norme della lingua italiana c’è un discrimine di correttezza tra le tre diverse forme “taboo”, “tabù”, “tabu”, e se sì, quale.
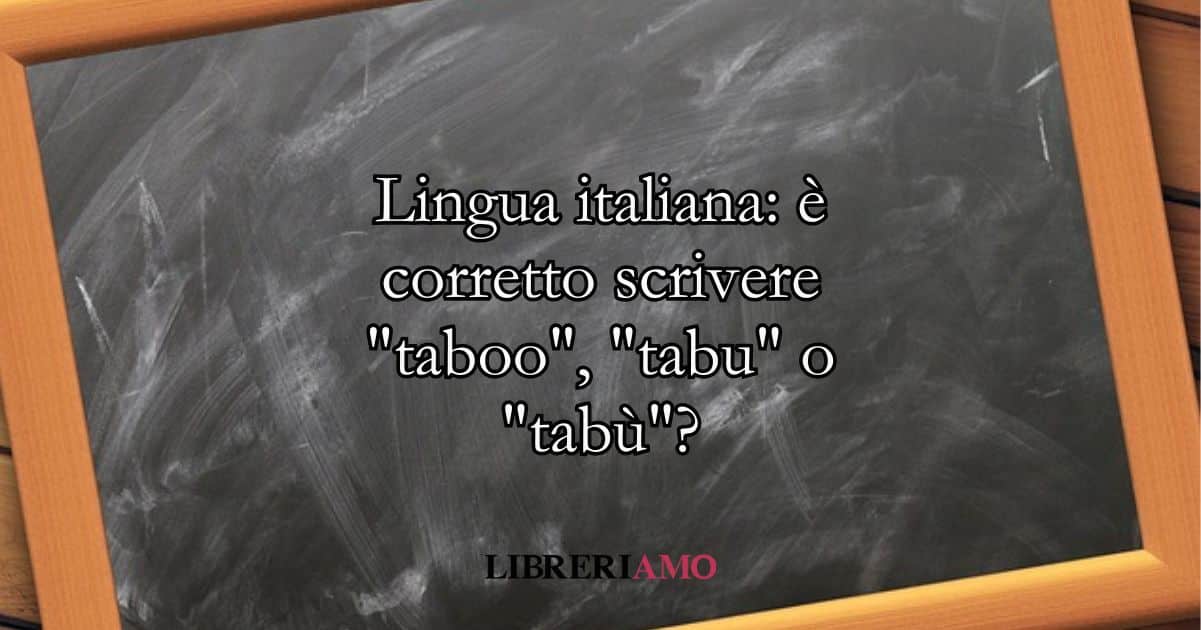
La lingua italiana, come ogni lingua viva, è un organismo in continua trasformazione, un terreno di incontro tra influenze storiche, culturali e linguistiche. Un esempio interessante di questa dinamica è offerto dalla parola tabù e dalle sue varianti grafiche: taboo, tabu e tabù. Queste tre forme convivono oggi nella scrittura italiana, ma non con lo stesso valore né con la medesima accettazione linguistica. Analizzarne la provenienza, l’evoluzione e l’uso ci permette di comprendere non solo la storia di una parola, ma anche la natura profondamente porosa e dinamica dell’italiano contemporaneo.
Origini polinesiane e approdo nella lingua italiana
Il termine tabù ha una storia affascinante. La parola ha origine nelle lingue polinesiane, in particolare nel tongano “tapu” o “tabu”, che significa ‘proibito’, ‘sacro’, ‘intoccabile’. Fu l’esploratore inglese James Cook a registrare per la prima volta questa parola nel suo diario durante i viaggi nel Pacifico alla fine del XVIII secolo. La forma con la doppia “o”, taboo, è quella che si è consolidata in inglese, lingua nella quale ha avuto grande fortuna a partire dal XIX secolo.
In italiano, come spesso accade con i prestiti, la parola è entrata inizialmente attraverso mediazione francese e inglese. La forma tabù, con l’accento sull’ultima sillaba, si è imposta come adattamento fonetico e grafico italiano del termine straniero. Ma da qui nasce la varietà delle forme in circolazione.
Tabù: la forma oggi corretta
La forma tabù, con accento grafico sull’ultima vocale, è oggi quella considerata corretta nei vocabolari italiani e nella norma ortografica. Compare nei principali dizionari della lingua italiana, tra cui il Vocabolario Treccani, lo Zingarelli e il Devoto-Oli. Si tratta di un sostantivo maschile invariabile: un tabù, i tabù. L’accento acuto sulla “u” finale serve a indicare la pronuncia tronca, cioè l’accento posto sull’ultima sillaba, secondo le regole ortografiche italiane che richiedono l’accento grafico per distinguere questo tipo di parole.
L’uso della forma tabù è ormai stabilizzato nella lingua scritta formale: è la versione che troveremo nei saggi accademici, nei giornali, nei libri scolastici e nei documenti ufficiali. È anche la forma preferita nei contesti in cui è importante mantenere una coerenza con le norme ortografiche italiane, come nei concorsi pubblici o nelle prove di scrittura.
Tabu: una forma “semplificata”
La variante tabu, senza accento grafico, è anch’essa presente in italiano, anche se in misura molto minore. È spesso usata nei testi informali, in contesti orali riportati per iscritto, o in ambienti dove prevale una scrittura più disinvolta e meno attenta alla correttezza ortografica. Tuttavia, l’assenza dell’accento può creare ambiguità, in particolare in lettura, poiché in italiano la regola vuole che i sostantivi tronchi, cioè accentati sull’ultima sillaba, siano sempre indicati con accento grafico.
Scrivere tabu senza accento è quindi una forma non standard, che può essere tollerata in ambiti colloquiali ma che risulta scorretta nei contesti accademici e professionali. È un po’ come scrivere perche invece di perché: il significato si intuisce, ma si percepisce subito la dissonanza rispetto alla norma.
Taboo: l’anglicismo
La forma taboo è, a tutti gli effetti, un anglicismo non adattato. Si tratta della parola inglese originaria, e in italiano il suo uso è da considerarsi straniero e non corretto se non in contesti precisi. Per esempio, può comparire in citazioni dirette da testi in inglese, in titoli di opere straniere, o in scritti dove si voglia sottolineare l’origine anglosassone del concetto o la sua valenza culturale specifica. Scrivere taboo in un saggio o in un articolo giornalistico italiano senza una giustificazione tematica o stilistica è un errore.
Tuttavia, la presenza della forma taboo si è fatta più frequente negli ultimi decenni, complice l’influenza dell’inglese nei media, nella pubblicità e nei social network. La parola può apparire, ad esempio, in titoli di canzoni, in marchi o in slogan commerciali, dove l’uso dell’inglese ha una funzione evocativa più che comunicativa.
Sinonimia e differenze di registro
Dal punto di vista semantico, tutte e tre le forme rimandano allo stesso concetto: un divieto culturale, morale o sociale fortemente interiorizzato. Il significato non cambia, ma ciò che varia è il registro d’uso. Tabù è la forma corretta e formale; tabu è una variante trascurata, non conforme alla norma ortografica; taboo è una parola straniera, da usare solo in contesti specifici. In un certo senso, la differenza non è solo ortografica ma anche sociolinguistica: ogni grafia dice qualcosa sul contesto, sull’intenzione comunicativa e sul grado di attenzione alla lingua.
In conclusione, la forma corretta in italiano standard è tabù, con l’accento sulla “u”. È l’unica forma riconosciuta dai vocabolari e quella da usare in testi formali. Tabu, senza accento, è una semplificazione che può talvolta apparire in contesti informali ma non è consigliata. Taboo è un anglicismo, da evitare nella scrittura italiana se non per ragioni specifiche. La questione, più ampia, è un esempio di come la lingua italiana continui a evolversi sotto l’influenza di altre lingue e dei nuovi media, senza perdere però il proprio impianto normativo. In tempi di globalizzazione, distinguere tra uso corretto e uso stilisticamente motivato diventa una competenza sempre più necessaria per chi scrive e parla con consapevolezza.