Lingua italiana: ti è mai capitato di provare l’uggiolina?
Scopriamo assieme qual è il significato letterale della rara parola della lingua italiana “uggiolina” e quali sono le sue varie accezioni.
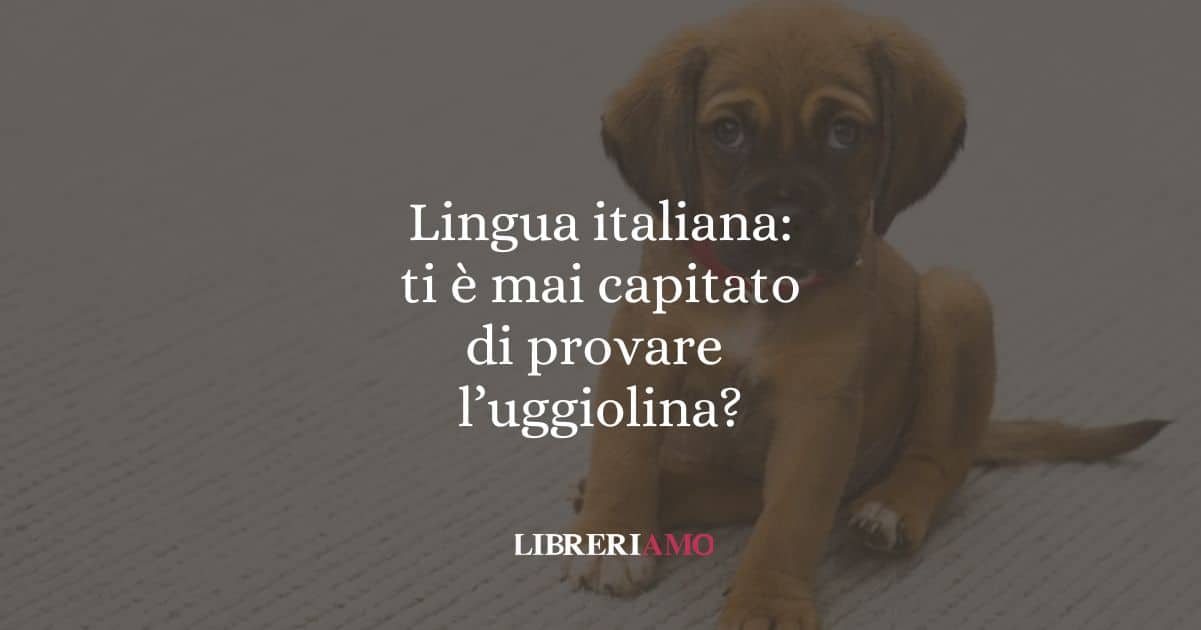
Tra le parole ormai rare, quasi dimenticate, della lingua italiana, “uggiolina” occupa un posto di particolare fascino. Piccola, sonora, dal tono quasi ironico, essa racchiude in sé una sfumatura psicologica e fisica che l’italiano contemporaneo ha smarrito, sostituendola con termini più neutri, meno coloriti e senz’altro meno evocativi. “Uggiolina” è un sostantivo femminile che designa un vago senso di fastidio, di inquietudine o di disagio, ma anche — in un’altra accezione — un leggero languore allo stomaco, un principio di fame o di malessere indefinito. È, dunque, una parola che oscilla tra il corpo e l’anima, tra la sensazione fisica e quella emotiva, come molte delle parole che nascono dall’osservazione profonda della vita quotidiana.
Origine e struttura della parola della lingua italiana
Etimologicamente, uggiolina deriva da “uggia”, termine più antico e anch’esso oggi poco frequente, che indicava la noia, il tedio, la molestia o l’avversione. “Uggia”, a sua volta, ha radici nel latino odium — “odio” — attraverso forme popolari come ogium o ugium, che trasmisero alla lingua volgare il senso di un sentimento di lieve repulsione o insofferenza. Da “uggia” si forma il diminutivo “uggiolina”, con l’aggiunta del doppio suffisso -olin(a), che ne attenua il significato e insieme lo rende più concreto, più domestico.
È una parola onomatopeica e affettiva, perché il suo suono riproduce in qualche modo la sensazione che descrive: quella leggera vibrazione, quell’irrequietezza sottile che non arriva a diventare dolore o disgusto, ma che non può nemmeno essere ignorata. Nella forma e nella musicalità, “uggiolina” appartiene a quella famiglia di parole italiane che sembrano “nate in bocca”, frutto della parlata popolare e di una sensibilità linguistica immediata e corporea.
Le testimonianze letterarie
La parola è attestata nella lingua letteraria, anche se in modo sporadico. Eugenio Cecchi, critico letterario e scrittore del primo Novecento, scrive:
“Mi sentivo in corpo… quell’uggiolina di uno che conosce i suoi polli e, davanti a certi spettacoli, capisce a volo che un giorno o l’altro, fatalmente, tornerà a provarcisi con la maledettissima penna.”
Qui uggiolina indica un malessere interiore, una leggera repulsione mista a ironia, il disagio di chi sa già che non potrà sottrarsi a un destino — nel caso di Cecchi, quello della scrittura — pur conoscendone le fatiche e le contraddizioni. È un sentimento di sottile autoironia, di consapevole inquietudine.
Anche Aldo Palazzeschi, in un passo altrettanto significativo, usa il termine per esprimere un sentimento fisico e psicologico insieme:
“Quattro ore sotto terra! E sempre con quell’uggiolina allo stomaco che è facile comprendere, di non rivedere la luce del Signore.”
In questo caso, la parola tocca il confine tra angoscia e fisiologia: un disagio reale, localizzato nello stomaco, ma che nasce da una paura esistenziale, dalla consapevolezza del pericolo e della precarietà.
Infine, nel più celebre dei tre esempi, Carlo Collodi la utilizza in Le avventure di Pinocchio:
“Intanto incominciò a farsi notte, e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un’uggiolina allo stomaco, che somigliava moltissimo all’appetito.”
Qui l’uggiolina è una fame lieve, un vuoto che non è ancora sofferenza ma che prelude a essa. È la fame ingenua e innocente di un bambino di legno, un piccolo disagio fisico che diventa anche simbolo di curiosità e di scoperta del mondo.
In queste tre citazioni — Cecchi, Palazzeschi, Collodi — la parola percorre tre diverse tonalità dell’esperienza umana: l’ironia intellettuale, l’angoscia fisica e la fame innocente. Tre declinazioni di un unico sentimento di mancanza o turbamento, espresso con una grazia che solo una lingua sensibile come l’italiano sa rendere.
Uggiolina e l’universo di “uggia”
L’area semantica di “uggiolina” appartiene a un più vasto campo di parole derivate da uggia, un termine che Dante stesso usò in Inferno VII per descrivere la noia morale dei prodighi e degli avari:
“Perché tieni? e perché burli?”, dicevano, / “non far che l’uggia ti vinca.”
Nel Medioevo, uggia era una forma del fastidio spirituale, una stanchezza dell’anima. In epoca successiva, la parola si laicizza, scendendo dal piano morale a quello psicologico e quotidiano. “Uggiolina” ne rappresenta la versione più lieve, domestica, persino affettuosa: non la grande noia metafisica, ma il piccolo fastidio di ogni giorno, la sensazione indefinita che accompagna il vivere.
Un sentimento sottile: tra corpo e mente
La bellezza di “uggiolina” sta nella sua ambiguità semantica. È una parola-soglia, che non distingue rigidamente tra fisico e psichico. Può descrivere un malessere corporeo (“un’uggiolina allo stomaco”) o uno stato d’animo (“un’uggiolina in corpo”), senza che l’uno escluda l’altro. È, in fondo, la parola dell’inquietudine leggera, quella che precede il dolore ma non lo raggiunge mai, come una nube passeggera sul cielo limpido del quotidiano.
L’oblio e la riscoperta
Oggi “uggiolina” è pressoché scomparsa dall’uso. I dizionari moderni la registrano come voce rara o letteraria, e le generazioni più giovani difficilmente ne conoscono il significato. È stata sostituita da espressioni più generiche — disagio, fastidio, malessere — che però non hanno la stessa delicatezza evocativa.
Riscoprire “uggiolina” significa recuperare un frammento di quella lingua sensoriale che l’italiano popolare e letterario del passato sapeva maneggiare con tanta finezza. È una parola che racconta il corpo e l’anima insieme, che unisce l’esperienza fisica al pensiero, la fame alla malinconia, la noia alla speranza.
“Uggiolina” è una piccola perla linguistica: una parola umile, quasi dimenticata, ma capace di restituire la complessità delle sensazioni umane più sottili. Nel suo suono c’è un’eco di pigrizia e di dolcezza, nel suo significato una vibrazione tra disagio e languore. Non descrive un dolore, ma la sua soglia: quel punto in cui il corpo e la mente si accorgono di mancare di qualcosa — di cibo, di luce, di serenità — e lo esprimono con un sospiro.
In un’epoca in cui le parole tendono a semplificarsi e a ridursi all’essenziale, “uggiolina” ci ricorda che il linguaggio può ancora accogliere la sfumatura, il mezzo tono, il disagio che non è dramma ma semplice, umanissima inquietudine.