Italiano: quando utilizzare l’espressione latina “pro forma”?
Scopriamo assieme quando e come utilizzare correttamente questa espressione latina ormai entrata a tutti gli effetti nel lessico italiano.
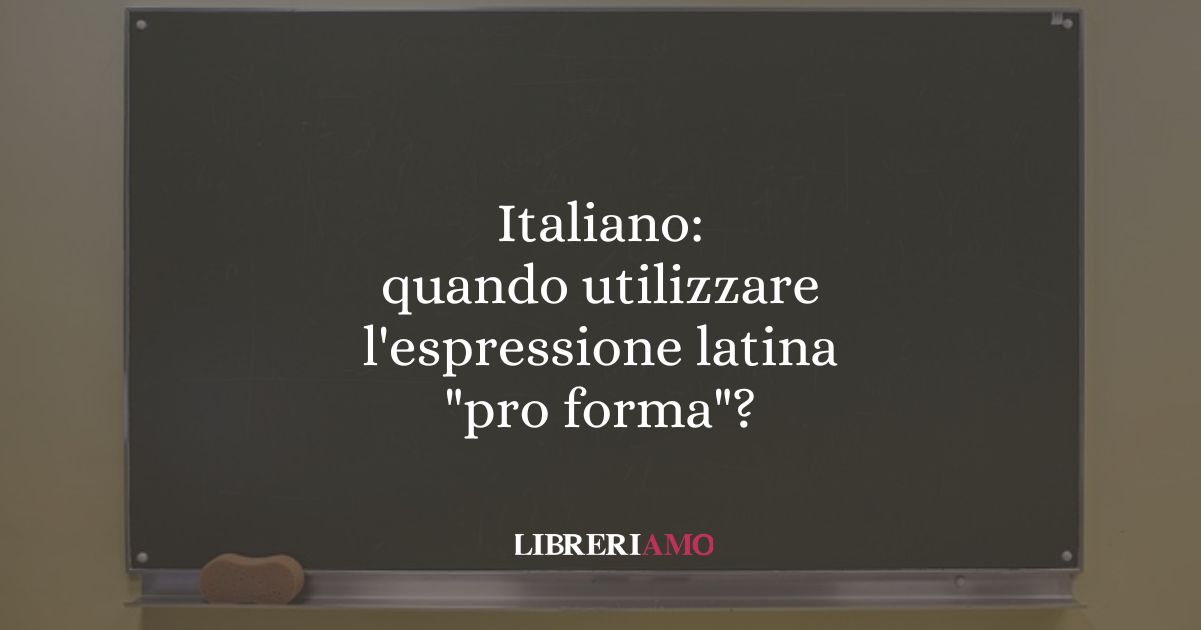
Anche l’italiano, come tutte le lingue romanze, ha una radice profonda nel latino. Tuttavia, il legame non è uniforme: molte parole giungono all’italiano attraverso trasformazioni fonetiche e morfologiche, mentre altre conservano intatta la veste originaria. È questo il caso di pro forma, locuzione latina che appartiene alla categoria dei latinismi integrali o “crudi”, ossia espressioni che non hanno subito adattamenti e che sono entrate nel nostro lessico come unità indipendenti. Analizzare questa espressione significa ripercorrere la storia del latino nella nostra lingua, chiarire la funzione grammaticale che essa assume e i molteplici usi che si sono affermati nel tempo.
Un latinismo integrale nel linguaggio italiano: il valore storico di pro forma
Per comprendere la particolarità di pro forma, occorre richiamare il concetto di latinismo. Le parole di origine latina in italiano non sono poche, ma non costituiscono la totalità del nostro vocabolario. Alcune arrivano per via popolare, altre per via dotta, altre ancora come forestierismi integrali. Pro forma appartiene a quest’ultima categoria: non si è fusa nel sistema fonetico e morfologico italiano, ma è stata accolta così com’era, rimanendo una locuzione latina indeclinabile.
Il latino prō significa “a favore di”, ma può avere anche il valore di “davanti”, mentre formā è l’ablativo singolare di fōrma, -ae, cioè “aspetto, bellezza, configurazione”. Letteralmente, dunque, pro forma può essere tradotto come “a favore della forma” o “per la forma”. Già questa traduzione mette in luce il suo valore semantico: si tratta di un’azione compiuta non per sostanza, ma per salvare l’apparenza, per rispettare una convenzione formale.
Gli usi grammaticali di pro forma
La locuzione pro forma ha conosciuto nel tempo un ventaglio di usi che la rendono estremamente versatile.
-
Avverbiale: è la funzione più antica e diffusa, con il significato di “per pura formalità, per salvare le apparenze”. Si trova spesso in testi burocratici, giuridici o giornalistici: ad esempio, “si è espresso pro forma”, nel senso che ha preso posizione senza convinzione, solo per rispetto delle convenzioni.
-
Aggettivale: usato invariabilmente, soprattutto in contesti economici e amministrativi. Si parla di “bilancio pro forma”, “fattura pro forma”, “dati pro forma”. Qui il valore è quello di “puramente convenzionale” o “a scopo formale”.
-
Sostantivale: in uso più recente, soprattutto nel linguaggio comune e giornalistico. Si dice “è un pro forma” per indicare una mera formalità, un atto convenzionale privo di reale efficacia.
Questa molteplicità d’impieghi dimostra quanto la locuzione sia penetrata nell’uso, adattandosi a diversi registri e ambiti disciplinari.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda il genere di pro forma quando viene utilizzato come sostantivo. In linea teorica, poiché il sostantivo forma è femminile in latino e in italiano, ci si aspetterebbe che l’intera locuzione si accordasse al femminile. Eppure, l’uso prevalente è il maschile: si dice un pro forma, non una pro forma.
Questa apparente incongruenza si spiega considerando pro forma come un’espressione indeclinabile, assimilabile ai forestierismi. In italiano, gli elementi non pienamente riconducibili alla categoria dei nomi assumono di norma il genere maschile, che rappresenta il “default”. È lo stesso fenomeno che si osserva con nulla osta o pro memoria, anch’essi di genere maschile nonostante la presenza di sostantivi originariamente femminili. Solo in rari casi si trova una pro forma, spesso in contesti dove l’ellissi ha fatto sì che l’espressione venisse sentita come femminile perché legata, per esempio, a “fattura pro forma”.
La diffusione e la storia nell’italiano
La locuzione compare nei testi italiani già nel Cinquecento, come testimoniano cronache e lettere. A volte veniva riportata tra virgolette, segno della percezione di estraneità rispetto al lessico pienamente italiano. Secondo alcuni studi, l’espressione potrebbe aver seguito un percorso particolare: attestata in inglese già nel Quattrocento, si sarebbe diffusa poi in Francia e, da lì, sarebbe penetrata nella nostra lingua. In ogni caso, la presenza nei documenti italiani del XVI secolo dimostra che la sua circolazione era già consolidata.
Non è un caso che molti latinismi integrali, come pro forma, abbiano avuto fortuna soprattutto nei linguaggi specialistici: diritto, burocrazia, medicina, economia. Il prestigio del latino come lingua di autorità e di sapere ha garantito la sopravvivenza di queste espressioni, che, proprio per il loro carattere “non tradotto”, mantenevano un’aura di ufficialità.
Esiste anche la questione della grafia: alcuni dizionari riportano la forma univerbata proforma, considerata però minoritaria e antiquata. Oggi prevale nettamente la forma separata, percepita come più fedele alla tradizione latina. Quanto alla pronuncia, non c’è unanimità: la o di pro può essere aperta o chiusa, mentre in forma si tende a preferire la o chiusa.
Oltre agli aspetti linguistici, pro forma ci parla di un atteggiamento culturale. L’espressione è legata al concetto di formalità, di rispetto delle convenzioni anche quando prive di sostanza. In questo senso, diventa quasi una metafora dell’agire umano, sospeso tra ciò che ha valore intrinseco e ciò che viene compiuto “per salvare la facciata”.
Pro forma è una locuzione che condensa in sé il destino dei latinismi nell’italiano: importata senza adattamenti, oscillante tra usi specialistici e quotidiani, capace di assumere funzioni grammaticali diverse e di sollevare questioni di genere e grafia. La sua fortuna dimostra come il latino continui a vivere nella nostra lingua, non solo come eredità strutturale, ma come presenza viva, che ancora oggi ci permette di esprimere concetti difficili da rendere con parole “più italiane”.
E proprio nella sua natura di “formalità”, pro forma si rivela tutt’altro che vuota: è testimonianza di un legame con il passato che continua a modellare il nostro presente linguistico e culturale. Per saperne di più rimandiamo all’esaustivo articolo redatto dall’Accademia della Crusca: Questa non è una risposta pro forma.