Italiano e parentela: un “cugino” fino a quando è un parente?
Scopriamo assieme l’origine del termine italiano di parentela “cugino” e fino a quale grado si può considerare un parente.
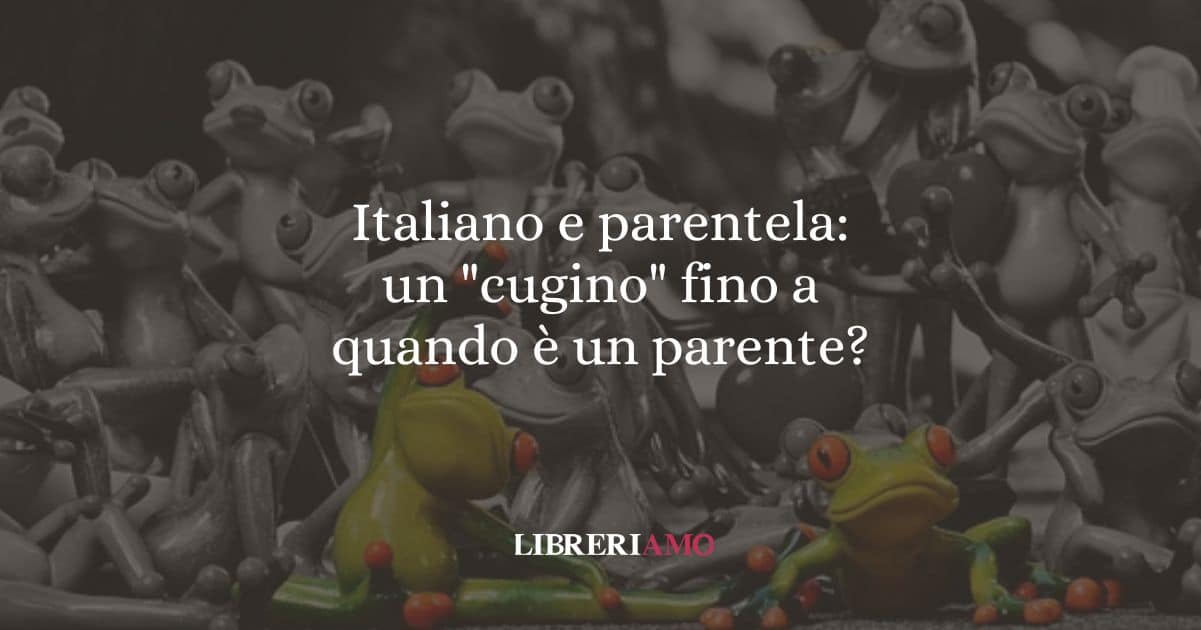
Il vocabolo italiano “cugino”, di uso quotidiano e apparentemente semplice, nasconde in realtà un’interessante complessità linguistica, storica e giuridica. È un termine che appartiene all’ambito familiare ma anche al linguaggio del diritto, e la sua definizione precisa implica la comprensione del concetto di parentela e del modo in cui essa viene calcolata in gradi nel diritto civile italiano. Inoltre, come spesso accade nelle parole della nostra lingua, “cugino” porta con sé una stratificazione semantica che racconta anche l’evoluzione del modo in cui le società hanno percepito i legami familiari.
L’origine del termine italiano
Dal punto di vista etimologico, cugino deriva dal latino consobrīnus, termine che indicava il figlio della sorella della madre, ossia il cugino “uterino”, legato da un vincolo di sangue materno. Col tempo, il termine ha ampliato il proprio significato fino a includere qualunque figlio di fratelli o sorelle, quindi il parente che condivide con noi almeno un nonno o una nonna. La parola latina consobrīnus a sua volta deriva da soror (“sorella”), e l’aggiunta del prefisso con- indica la comunanza: consobrīnus significa dunque “colui che ha la stessa sorella come madre”. Nel passaggio dal latino all’italiano, la parola ha subito un’evoluzione semantica, generalizzandosi, e oggi cugino è usato senza distinzione di linea paterna o materna.
La parentela e le sue linee
Per comprendere fino a che punto un cugino possa essere considerato parente, è necessario chiarire cosa si intenda per parentela. Nel diritto e nella consuetudine linguistica, si definiscono parenti in linea retta le persone che discendono direttamente l’una dall’altra: genitori, figli, nonni, nipoti. Si parla invece di parenti in linea collaterale quando le persone condividono un antenato comune, ma non discendono l’una dall’altra. È il caso dei fratelli, degli zii e nipoti, e dei cugini.
Il cugino, dunque, appartiene alla linea collaterale: non discende direttamente da noi, ma condivide con noi uno stipite comune, cioè un nonno o una nonna. È proprio questa posizione intermedia, tra prossimità affettiva e distanza genealogica, a rendere la figura del cugino tanto familiare quanto giuridicamente “lontana”.
Il grado di parentela dei cugini
Il diritto civile italiano, seguendo una tradizione che risale al diritto romano, calcola i gradi di parentela contando le generazioni. Nella linea retta, si contano le persone fino allo stipite comune (escluso). Nella linea collaterale, invece, si sale fino allo stipite comune e poi si discende fino all’altro parente.
Nel caso dei cugini, il calcolo è il seguente: si parte da un cugino, si sale al suo genitore (cioè lo zio dell’altro), poi si sale al nonno (lo stipite comune), quindi si discende all’altro zio e infine all’altro cugino. Si contano quattro passaggi, e quindi i cugini sono parenti di quarto grado.
Questo dato, apparentemente tecnico, ha importanti conseguenze giuridiche. Per esempio, il Codice civile italiano considera parenti prossimi — con effetti legali significativi, come nel diritto successorio o nel diritto penale — solo i parenti fino al terzo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii e nipoti). I cugini, dunque, non rientrano tra i parenti prossimi ai fini legali, anche se nella vita quotidiana sono spesso considerati parte stretta della famiglia.
Linea collaterale e affinità
Va poi distinta la parentela dall’affinità, ossia il legame che unisce ciascun coniuge ai parenti dell’altro. Per esempio, il cugino del marito è affine di quarto grado rispetto alla moglie, perché il marito e il cugino sono parenti di quarto grado. Tuttavia, gli affini di ciascun coniuge non hanno tra loro alcun legame giuridico diretto: il cugino del marito non è, legalmente, parente né affine della moglie.
Il cugino nella cultura familiare
Oltre la dimensione giuridica, la parola cugino ha anche un forte valore affettivo e culturale. In molte famiglie italiane, i cugini rappresentano una sorta di “secondi fratelli”, con cui si condividono giochi, vacanze e ricordi d’infanzia. Nelle generazioni passate, quando le famiglie erano numerose e spesso vivevano nello stesso quartiere o addirittura nella stessa casa, i cugini costituivano una rete di solidarietà e compagnia fondamentale.
Il termine ha assunto anche una sfumatura colloquiale: si usa dire “siamo come cugini” per indicare un rapporto di affetto e familiarità che non è però di parentela diretta. Nella cultura popolare, il cugino è spesso rappresentato come un familiare vicino ma non invadente, una figura affettuosa ma libera dai vincoli di responsabilità tipici dei fratelli.
Il cugino tra diritto e sentimento
Questa duplice natura — legale e affettiva — rende la parola “cugino” un caso emblematico di come il linguaggio rispecchi la complessità dei rapporti umani. Dal punto di vista del diritto, il cugino è un parente di quarto grado, quindi piuttosto “lontano”. Tuttavia, dal punto di vista della vita quotidiana, egli resta spesso un parente prossimo nel cuore, depositario di legami che sfuggono alla rigidità delle definizioni giuridiche.
In sintesi, “cugino” è una parola che intreccia biologia, diritto e cultura. Linguisticamente, deriva da un’antica idea di parentela materna; giuridicamente, rappresenta il quarto grado di parentela in linea collaterale; affettivamente, è spesso sinonimo di famiglia allargata, di memoria condivisa, di legami che superano la distanza del sangue. Come molte parole della lingua italiana, “cugino” dimostra che il linguaggio non è mai soltanto una questione di regole, ma anche di vita: esso conserva la traccia di ciò che siamo stati e di come continuiamo, attraverso le parole, a sentirci uniti.