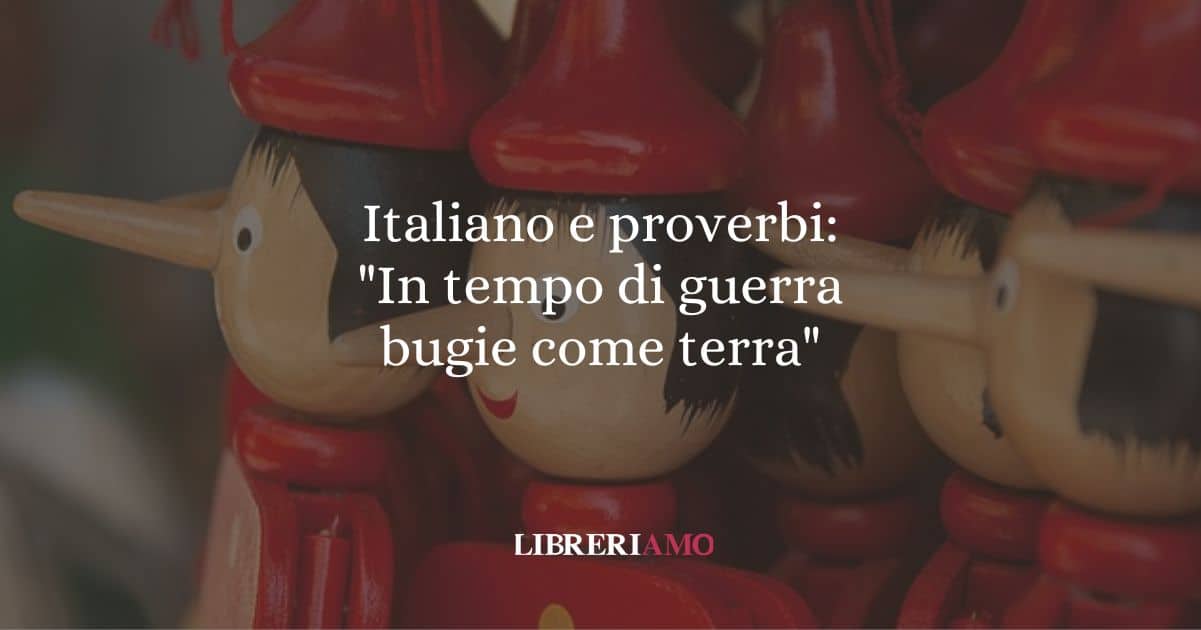Il proverbio italiano “In tempo di guerra bugie come terra”, tramandato e ricordato anche grazie al lavoro di raccolta e riflessione di Benedetto Croce, conserva ancora oggi una straordinaria attualità. L’immagine semplice e concreta che veicola – la menzogna abbondante e diffusa come la terra stessa – racchiude in poche parole un’intera concezione della storia e della condizione umana nei momenti di conflitto. È un detto che nasce dalla saggezza popolare, ma che al tempo stesso tocca questioni morali e politiche: la verità, la propaganda, la manipolazione, la fragilità della parola in situazioni estreme.
Origine e valore del proverbio italiano
Come spesso accade con i proverbi, non abbiamo un autore unico: si tratta di un sapere collettivo, sedimentato nei secoli, che Benedetto Croce ha avuto il merito di raccogliere e valorizzare nei suoi studi di letteratura e di tradizione popolare. L’immagine delle “bugie come terra” richiama l’abbondanza e la diffusione capillare: la terra è ovunque, non c’è luogo che non ne sia coperto; così, in tempo di guerra, la menzogna diventa ubiquitaria, insinuandosi in ogni discorso, in ogni comunicazione, in ogni giustificazione.
Il proverbio sottolinea una verità universale: la guerra, più di ogni altra condizione storica, si accompagna alla manipolazione dell’informazione. Non si combatte solo con le armi, ma anche con le parole, con le notizie, con i racconti che servono a legittimare le proprie azioni e a delegittimare quelle del nemico.
Guerra e menzogna: un binomio antico
Già gli autori antichi avevano notato questo legame. Tucidide, nello scrivere la Guerra del Peloponneso, aveva osservato come i conflitti non solo dividessero le città, ma deformassero anche il linguaggio e la percezione della verità. Machiavelli, nei suoi scritti politici, riconosceva che in guerra l’inganno e la simulazione erano strumenti legittimi, parte integrante dell’arte militare.
Il proverbio italiano coglie questa dimensione con la semplicità propria della saggezza popolare. In guerra non si cercano notizie oggettive, ma narrazioni utili. Le bugie diventano necessarie, quasi inevitabili: servono a sostenere il morale, a creare consenso, a nascondere le proprie debolezze e ad amplificare le sconfitte del nemico.
La propaganda: la bugia organizzata
Il proverbio italiano in questione si presta perfettamente a descrivere fenomeni moderni come la propaganda. Nel Novecento, con le due guerre mondiali, la menzogna non fu più solo spontanea o episodica, ma organizzata sistematicamente dagli Stati. I manifesti, i cinegiornali, i giornali stessi erano strumenti per diffondere messaggi costruiti ad arte: notizie esagerate, manipolate, talvolta completamente inventate.
Benedetto Croce, filosofo della libertà e della responsabilità etica, non poteva non cogliere in questo proverbio il riflesso di un problema profondo: la verità come vittima della guerra. L’esperienza del suo tempo, attraversato da dittature e conflitti mondiali, confermava tristemente la saggezza del detto popolare.
Non bisogna però pensare alla menzogna solo come strumento di potere. Spesso, in tempo di guerra, anche le persone comuni si rifugiano nella bugia per proteggersi o per proteggere gli altri. Mentire può voler dire salvare una vita, nascondere un perseguitato, non rivelare informazioni al nemico. In questo senso, le bugie non sono soltanto propaganda ingannevole, ma anche mezzi di resistenza e di difesa.
Il proverbio, con la sua ampiezza di significato, non distingue: parla di bugie come terra, lasciando intendere che la menzogna, in tutte le sue forme, dilaga e si diffonde inevitabilmente. La guerra crea un clima in cui la verità non ha più spazio, e ogni parola diventa sospetta.
Attualità del proverbio
Nell’epoca contemporanea, il proverbio risuona con forza ancora maggiore. Le guerre del XXI secolo non si combattono soltanto sui campi di battaglia, ma anche nelle arene digitali. Fake news, disinformazione, manipolazione delle immagini e delle notizie: tutto ciò conferma che, in tempo di conflitto, le bugie diventano uno strumento di dominio tanto importante quanto i carri armati o i missili.
La velocità con cui oggi le informazioni circolano amplifica il fenomeno. Se nel passato le bugie si diffondevano attraverso i giornali o la voce del popolo, oggi viaggiano in tempo reale attraverso i social network, diventando immediatamente globali. “Bugie come terra” è un’immagine che, se già allora risultava potente, oggi descrive un terreno informativo contaminato e difficile da distinguere tra vero e falso.
Una lezione morale
Il proverbio non si limita a descrivere un fenomeno, ma contiene anche un monito. Ci ricorda che la guerra, oltre a distruggere vite e città, mina il fondamento stesso della convivenza civile: la fiducia nella parola e nella verità. La menzogna diffusa come la terra lascia cicatrici profonde, che non si cancellano con la fine del conflitto.
Benedetto Croce, da storico e filosofo, vedeva nei proverbi non soltanto curiosità linguistiche, ma condensazioni di esperienza collettiva. In questo caso, la sapienza popolare anticipa le analisi politiche e filosofiche: mette in guardia contro l’illusione che in guerra si possa avere accesso alla verità.
“In tempo di guerra bugie come terra” non è soltanto un proverbio: è un avvertimento universale. Ci dice che la guerra non porta mai chiarezza, ma opacità; non porta verità, ma menzogne diffuse e pervasive. È un invito alla prudenza, a non credere ciecamente a ciò che viene detto nei momenti di conflitto, a mantenere uno spirito critico.
Il detto popolare, riscoperto da Benedetto Croce, ci parla ancora oggi con sorprendente lucidità: ci ricorda che, finché esisteranno guerre, esisteranno anche bugie. E che l’unica arma contro di esse è la consapevolezza.