Italiano: perché gli attori esclamano “merda, merda, merda”?
Scopriamo perché prima di uno spettacolo teatrale ogni attore italiano che si rispetti esclama con i colleghi: “merda, merda, merda!!”.
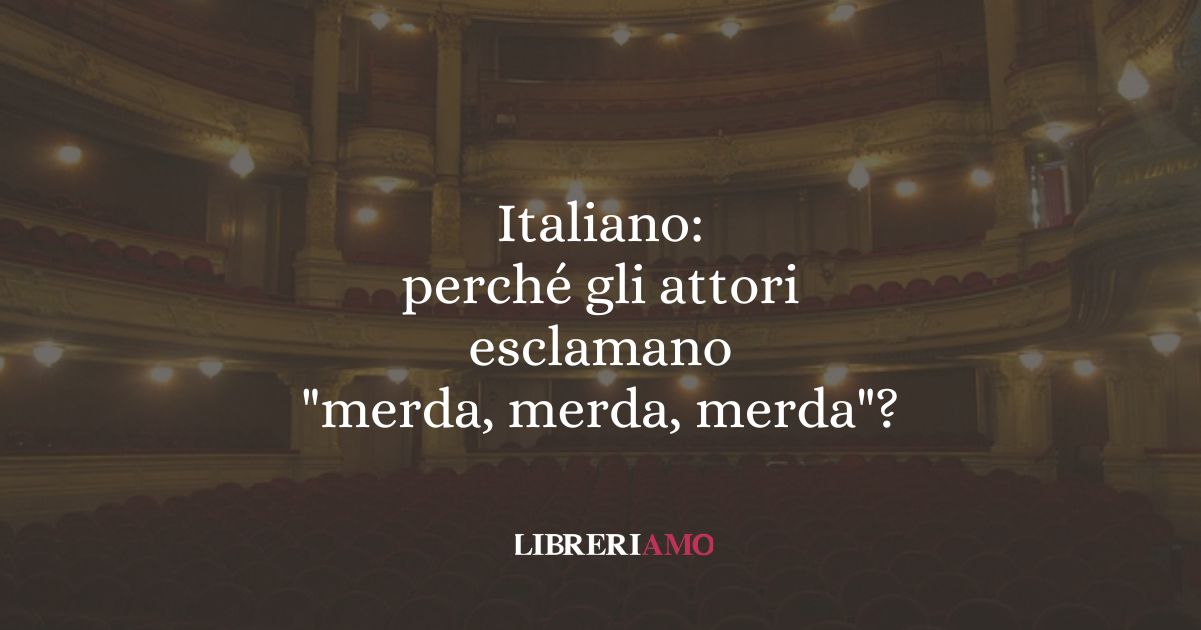
Il mondo del teatro italiano è da sempre intriso di rituali, superstizioni e gesti propiziatori. Si tratta di tradizioni antiche, tramandate di generazione in generazione, che hanno contribuito a costruire quell’aura di mistero e sacralità che ancora oggi circonda il palcoscenico. Tra queste, una delle più note e curiose è senza dubbio l’uso di dire “merda, merda, merda” prima di andare in scena, una formula che sembra quasi un paradosso: augurare il successo evocando ciò che, nell’uso comune, è considerato sgradevole. Ma perché gli attori ricorrono a questa espressione e come mai, da secoli, è diventata un autentico rito collettivo?
Italiano e teatro: il contesto storico: carrozze, cavalli e pubblico borghese
La spiegazione più diffusa fa risalire l’origine dell’usanza all’Europa del Settecento e dell’Ottocento, quando il teatro cominciò a rivolgersi non più soltanto a un pubblico popolare, ma soprattutto a quello borghese e aristocratico. Gli spettatori di rango giungevano a teatro in carrozza, e la presenza di molti cavalli davanti all’edificio significava che lo spettacolo aveva richiamato grande affluenza. Più carrozze, più letame sparso davanti al teatro: da qui il nesso simbolico tra abbondanza di escrementi e successo dell’opera.
Dire “merda” divenne dunque un augurio paradossale ma comprensibile: se c’era “tanta merda” significava che il teatro era pieno, che gli attori si sarebbero esibiti davanti a un pubblico numeroso e che lo spettacolo avrebbe avuto risonanza.
Le critiche alla teoria “carrozze-cavalli”
Non tutti, però, accettano questa spiegazione come unica e definitiva. il divulgatore Roberto Mercadini, ad esempio, fa notare che il teatro all’italiana disponeva anche di ampi spazi destinati al pubblico meno abbiente, in particolare le platee che, in epoca premoderna, erano prive di sedie e accessibili anche a chi non arrivava in carrozza. Per questo motivo, ridurre l’origine della formula soltanto alla presenza del pubblico borghese e delle carrozze potrebbe risultare una semplificazione eccessiva.
Ciò che resta indiscusso è però l’associazione tra la parola “merda” e l’idea di abbondanza, di “pieno”. L’espressione non è tanto legata all’oggetto in sé, quanto al suo valore simbolico: l’eccesso, la tracimazione, l’affluenza.
Il tabù linguistico e la scaramanzia
Dal punto di vista antropologico e psicologico, l’abitudine di dire “merda” si inserisce nel più ampio fenomeno del pensiero magico. In molte culture, pronunciare apertamente parole come “buona fortuna” è considerato di cattivo auspicio, quasi come se attirasse l’attenzione di forze contrarie, sempre pronte a rovesciare l’aspettativa positiva. Per questo, al posto di evocare direttamente la fortuna, si preferisce augurare qualcosa di apparentemente negativo, ribaltandone il significato.
In Italia si dice “merda”, in Francia “merde”, in Spagna “mucha mierda”, mentre nei paesi anglosassoni prevale l’espressione “break a leg!” (“rompiti una gamba!”). Tutte queste formule condividono lo stesso principio: non nominare la fortuna per non spaventarla, ma evocarne l’ombra attraverso una frase paradossale.
Una parola collettiva, un rito di appartenenza
Il teatro non è mai soltanto una forma di arte, ma anche un’esperienza comunitaria. Gli attori, prima di andare in scena, vivono un momento di tensione condivisa, un’attesa che mescola ansia, adrenalina e speranza. Pronunciare insieme “merda, merda, merda” diventa un gesto di coesione, un modo per sentirsi parte di una tradizione più grande, per esorcizzare la paura dell’insuccesso.
In questo senso, la formula funziona anche come rito di appartenenza: non è soltanto un augurio, ma un codice segreto che distingue chi appartiene al mondo del teatro da chi ne resta fuori. È un “saluto iniziatico”, che lega gli attori di oggi a quelli di ieri, in un filo invisibile che attraversa i secoli.
Dal realismo al simbolismo
Un altro aspetto interessante riguarda l’evoluzione semantica della parola stessa. Se in origine il legame con la “merda” era probabilmente realistico (letame davanti ai teatri, segno di pubblico), con il tempo il termine ha assunto una valenza più astratta e simbolica. Oggi nessuno pensa più ai cavalli quando la pronuncia: “merda” è diventata un segnale sonoro, un’esclamazione rituale che concentra in sé tutto il peso della tradizione e della superstizione teatrale.
La forza della parola sta proprio nella sua brutalità, nella sua immediatezza. Dire “merda” non richiede spiegazioni: è un colpo netto, liberatorio, che rompe il silenzio della tensione pre-spettacolo.
Dietro questo rito, come dietro molti altri legati alla scaramanzia, si nasconde un bisogno umano universale: quello di avere la sensazione di poter influenzare il destino in situazioni in cui non si ha il pieno controllo. Lo spettacolo, come un esame o una competizione, è un evento imprevedibile: non si può sapere con certezza come reagirà il pubblico, se la rappresentazione filerà liscia, se non ci saranno imprevisti tecnici.
Il gesto scaramantico non garantisce davvero la buona riuscita, ma offre un sollievo psicologico: fa sentire gli attori meno in balia del caso, dando loro la sensazione di aver compiuto un passo in più verso il successo.
Dire “merda, merda, merda” non è quindi un semplice vezzo linguistico, ma un rito complesso che racchiude storia, simbolismo e psicologia. Nasce forse da un contesto concreto – il teatro borghese, le carrozze, il letame – ma si trasforma in un gesto collettivo che unisce le generazioni di attori in una catena di scaramanzia. È il trionfo del paradosso: augurare il peggio per ottenere il meglio, evocare lo sporco per invocare il successo.
In fondo, questo rituale ci ricorda che il teatro è anche questo: un luogo in cui realtà e illusione, serio e grottesco, sublime e triviale convivono armoniosamente. E forse è proprio in questo equilibrio che risiede il suo fascino immortale.