Italiano e greco: “Panta rei”, cosa significa realmente?
Scopriamo assieme l’origine e il significato originario dell’espressione eraclitea “Panta rei”, anche utilizzata in italiano.
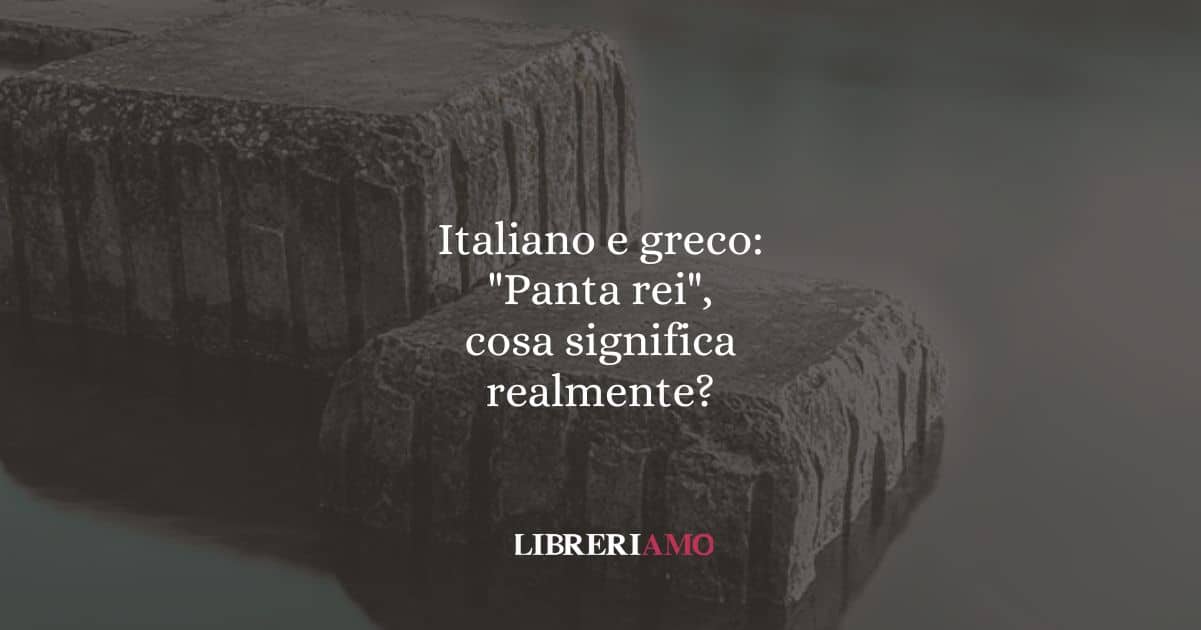
’espressione greca, entrata a piè pari nell’italiano, «panta rei» (πάντα ῥεῖ), tradotta solitamente come «tutto scorre», è una delle formule più celebri della storia del pensiero occidentale. Pur nella sua apparente semplicità, essa raccoglie una stratificazione complessa di interpretazioni, attribuzioni e fraintendimenti che attraversano secoli di filosofia. Oggi è spesso ripetuta come un luogo comune per indicare che tutto cambia, che nulla è stabile, che la realtà è un flusso continuo. Tuttavia, come mostrano gli studi più accurati sulla filosofia eraclitea, tale accezione popolare rischia di distorcere il significato originario e, soprattutto, di ignorare la profondità speculativa che sta alla base di questa massima.
Eraclito e un erroneo modo di dire italiano
Benché comunemente venga attribuita al filosofo Eraclito di Efeso, vissuto tra il VI e il V secolo a.C., «panta rei» non compare in nessuno dei frammenti diretti che ci sono giunti. La nota raccolta di testi presocratici a cura di Hermann Diels e Walther Kranz, che costituisce la principale base filologica per lo studio di questi filosofi, non attesta la frase tra i circa cento frammenti riconosciuti come eraclitei. Il primo autore a riportarla con esattezza è il filosofo bizantino Simplicio, vissuto nel VI secolo d.C., che scrive «panta rei os potamos», «tutto scorre come un fiume». Ci troviamo dunque di fronte a una massima tardiva, derivata da una tradizione interpretativa che ha filtrato e riformulato i concetti eraclitei.
La vera origine della formulazione «panta rei» si trova però in Platone, e precisamente nel dialogo Cratilo, in cui Socrate discute con Cratilo e Ermogene del rapporto tra linguaggio e realtà. Cratilo, seguace radicale del pensiero eracliteo, sostiene che «Eraclito dice che tutte le cose si muovono – panta chorei, πάντα χωρεῖ – e nulla permane». Platone riferisce anche il celebre paragone del fiume, secondo cui non si può immergersi due volte nella medesima acqua: una sintesi che diverrà la cifra più nota del pensiero di Eraclito pur non essendo formulata direttamente da lui nei termini che noi oggi conosciamo.
Tuttavia, lo stesso Cratilo estremizza l’insegnamento del maestro. Non solo non si può entrare due volte nello stesso fiume, sostiene, ma non lo si può fare nemmeno una volta, poiché la realtà muta così rapidamente da sfuggire a qualunque presa cognitiva. Per questo motivo, arriva persino a ritenere che il linguaggio sia uno strumento inadeguato a descrivere il reale, preferendo invece i gesti come forma più autentica di espressione. Questa posizione radicale contribuì non poco alla nascita del luogo comune di un Eraclito “filosofo del tutto scorre”, e alla trasformazione di «panta rei» in un motto semplificato, quasi riduttivo.
In realtà, gli stessi frammenti eraclitei indicano un pensiero molto più sottile. Eraclito parla sì del divenire, ma non lo intende come instabilità assoluta o come caotica dissoluzione dell’essere. Al contrario, nel continuo mutamento egli ravvisa la condizione stessa della stabilità. L’esempio del fiume, riportato nel frammento DK 12, è emblematico: «acque sempre diverse scorrono per coloro che s’immergono negli stessi fiumi». Il fiume resta un fiume proprio perché l’acqua cambia continuamente: se non scorresse, non sarebbe più un fiume ma un lago o uno stagno. In questo senso, il divenire non nega l’identità delle cose, ma la costituisce.
Questa idea si collega al concetto eracliteo dell’«armonia dei contrari» (DK 51), una tensione costante e feconda che permette alle cose di essere ciò che sono e, al contempo, di trasformarsi. Il frammento DK 49 esprime tale paradosso in maniera potente: «Negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo». Le cose, dunque, mutano senza perdere la loro essenza; trasformazione e permanenza non sono opposti, ma aspetti di una stessa dinamica fondamentale.
Il significato autentico di «panta rei», dunque, si distanzia dalla lettura superficiale che la traduce in un semplice «niente dura». L’idea eraclitea del divenire non è una negazione dell’essere, bensì una concezione della stabilità come struttura dinamica. Il mondo è stabile perché cambia; il cambiamento non è una minaccia all’identità, ma il suo fondamento. E se il linguaggio a volte può confondere questo paradosso – come osservava già Seneca nelle Lettere a Lucilio – è proprio perché le parole tendono a fissare ciò che è invece in perenne tensione.
Comprendere l’espressione «panta rei» nella sua complessità significa allora riconoscere la profondità del pensiero eracliteo, spesso ridotto a formula retorica. «Tutto scorre» non è un invito alla rassegnazione né un motto di impermanenza indistinta: è un’indicazione sulla natura profonda delle cose, sulla loro capacità di essere se stesse proprio attraverso il mutamento. Una lezione che, al di là dei secoli, continua a interrogare il nostro modo di intendere identità, tempo e trasformazione.