Italiano e storia: perché il XX secolo è chiamato “secolo breve”?
Scopriamo perché il ventesimo secolo, nel lessico italiano è spesso denominato “secolo breve”; chi ha coniato questa espressione e perché?
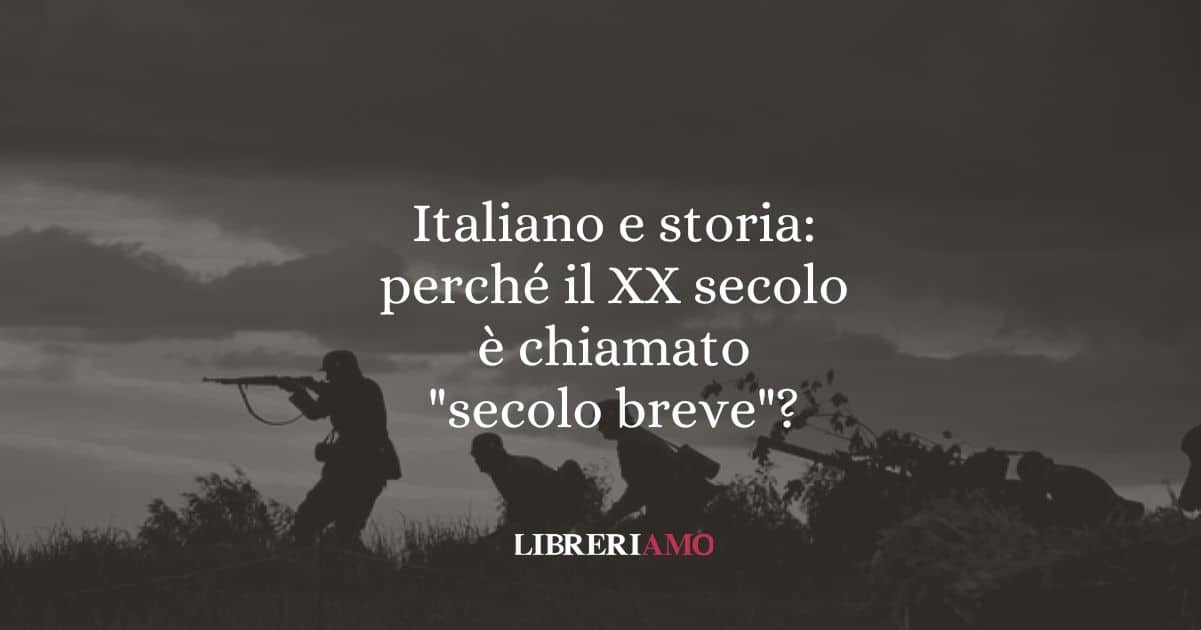
Eric Hobsbawm, con il suo saggio che in italiano ha come titolo Il secolo breve (1994), ha coniato un concetto che ha profondamente influenzato il modo di leggere il Novecento. Definire il XX secolo come “breve” significa collocarlo in un perimetro temporale che non coincide con i canonici cento anni, ma con un arco delimitato da due grandi eventi: lo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Tra questi estremi, secondo lo storico britannico, si è consumata un’epoca coerente e autonoma, distinta sia dal lungo XIX secolo (1789-1914), sia dalle dinamiche del XXI secolo nascente.
Questa definizione risponde a una duplice esigenza: da un lato, restituire al Novecento la sua eccezionalità, caratterizzata da eventi cataclismici, mutamenti ideologici e rivoluzioni tecnologiche senza precedenti; dall’altro, sottolineare come la “normalità” della vita internazionale sia stata radicalmente stravolta in questo intervallo. Non a caso Hobsbawm descrive il Novecento come “l’età degli estremi”, dove le più alte conquiste scientifiche e sociali si intrecciano con le più profonde tragedie collettive.
Italiano e storia: l’età della catastrofe (1914-1945)
La prima fase del secolo breve è segnata da conflitti devastanti. La Prima guerra mondiale distrugge equilibri secolari, travolgendo imperi millenari come l’ottomano, l’asburgico e lo zarista. La guerra, definita “totale” per la mobilitazione economica e civile che comporta, inaugura una nuova epoca di violenza organizzata. Nel suo solco nasce la Rivoluzione russa del 1917, che introduce un nuovo sistema politico-ideologico destinato a contrapporsi al capitalismo per gran parte del secolo.
Gli anni successivi, anziché portare stabilità, alimentano ulteriori fratture: la crisi del 1929 sconvolge l’economia mondiale, mentre in Europa si affermano i totalitarismi fascista e nazista, ideologie che conducono alla catastrofe della Seconda guerra mondiale. Quest’ultima, ancora più distruttiva della precedente, non è solo un conflitto militare, ma anche uno scontro ideologico assoluto, accompagnato dall’orrore della Shoah e dall’uso della bomba atomica.
L’Età dell’oro (1946-1973)
Dopo tanta devastazione, il mondo sembra entrare in una fase di ricostruzione e relativa prosperità. Gli anni che seguono il 1945 sono dominati dalla guerra fredda, la contrapposizione tra blocco sovietico e blocco occidentale. Ma, nonostante la tensione ideologica, non si giunge a un nuovo conflitto globale.
Sono decenni caratterizzati da una crescita economica senza precedenti: il cosiddetto boom economico, che porta benessere diffuso e miglioramenti nelle condizioni di vita. È anche il tempo delle grandi trasformazioni sociali: la fine del colonialismo, l’avanzare dei diritti civili, i movimenti di contestazione giovanile e culturale. Le scoperte scientifiche e tecnologiche – dalla medicina all’esplorazione spaziale – alimentano la percezione di un progresso continuo. Tuttavia, sotto questa superficie, rimangono tensioni pronte a riemergere.
La Frana (1973-1991)
La crisi petrolifera del 1973 segna l’inizio di una fase di incertezza. Il modello di crescita illimitata entra in crisi, i conflitti regionali si moltiplicano (basti pensare al Medio Oriente e all’Afghanistan), e le contraddizioni interne al sistema sovietico diventano sempre più evidenti.
Il crollo del muro di Berlino nel 1989 e la successiva dissoluzione dell’URSS nel 1991 segnano la fine di un’epoca. Non solo si chiude la guerra fredda, ma si conclude anche quel sistema di equilibrio globale che aveva caratterizzato il secolo breve. Hobsbawm osserva che il mondo si avvia verso un “disordine mondiale” dalle forme incerte, privo di un meccanismo capace di governarne le tensioni.
Il significato del “secolo breve”
Definire il Novecento come “secolo breve” significa riconoscerne la densità storica e la radicalità dei cambiamenti. È stato un secolo di ideologie assolute – fascismo, comunismo, liberalismo – che si sono contese l’egemonia mondiale, producendo al contempo straordinarie conquiste e immense tragedie. Ma è stato anche un secolo in cui il progresso scientifico e tecnologico ha trasformato radicalmente la vita quotidiana, dal vaccino alla televisione, dall’automobile a internet.
Il secolo breve, insomma, ha unito catastrofi e speranze, lasciando un’eredità contraddittoria. La sua chiusura non coincide con un bilancio pacifico, ma con l’aprirsi di nuove sfide globali: la questione ecologica, le disuguaglianze, i conflitti identitari e religiosi.
Eric Hobsbawm, con la formula del secolo breve, ha offerto una chiave interpretativa che permette di leggere il Novecento come un’unità storica autonoma, segnata da accelerazioni e rotture profonde. Lungi dall’essere un’etichetta storiografica neutra, questa definizione invita a riflettere sulla fragilità delle certezze umane e sull’imprevedibilità della storia.
Se il lungo XIX secolo fu l’età delle certezze borghesi e dell’illusione del progresso lineare, il secolo breve è stato il tempo degli estremi: splendore e miseria, emancipazione e tirannia, invenzione e distruzione. Un secolo che, pur essendo stato “breve”, continua a proiettare le sue ombre e le sue lezioni sul mondo contemporaneo.