Italiano e enantiosemia: i significati di “conciare”
Vediamo assieme cosa comporta il fenomeno dell’enantiosemia e come qualche termine italiano ne porti le caratteristiche.
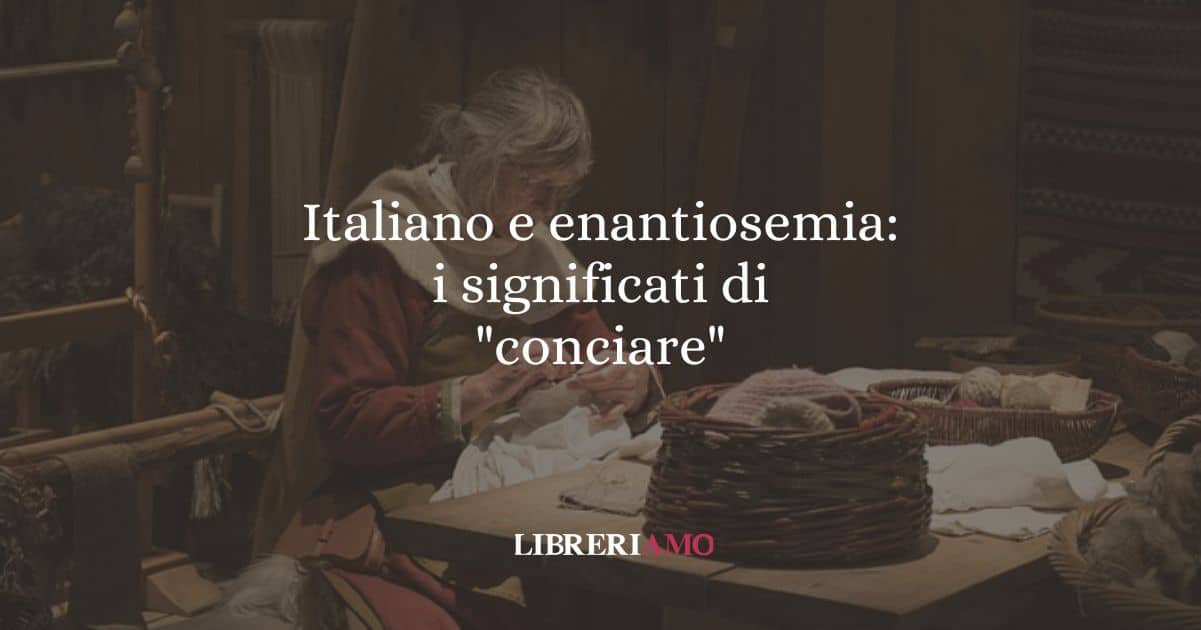
L’italiano, inteso come lingua, nella sua ricchezza e complessità, è piena di parole che non si lasciano imprigionare in un solo significato. Alcuni termini sembrano portare in sé una tensione interna, una duplicità semantica che li rende ambigui, vivi, carichi di sfumature. È il caso del verbo “conciare”, uno di quegli esempi affascinanti di enantiosemia, ossia il fenomeno linguistico per cui una stessa parola assume significati opposti. “Conciare”, infatti, può significare tanto aggiustare, acconciare, riparare, quanto rovinare, maltrattare, danneggiare. È un termine che, come pochi altri, mette in scena la capacità della lingua di esprimere il mondo nelle sue contraddizioni.
Italiano e semantica
L’etimologia ci guida alle origini del verbo. “Conciare” deriva dal latino conficiare, che significava “preparare, condire, lavorare”. Da questo senso originario di “preparazione” deriva l’uso tecnico legato al mondo delle pelli: “conciare le pelli” significa sottoporle a un processo di trattamento che le renda morbide, resistenti, adatte alla lavorazione. È questo il significato più antico e concreto del termine, tuttora in uso nella terminologia artigianale e industriale. Ma, come spesso accade nella storia delle parole, il significato si è allargato, spostato, talvolta capovolto.
Nel linguaggio comune, infatti, “conciare” è passato a indicare non solo il “preparare”, ma anche l’aggiustare o mettere a posto qualcosa o qualcuno. Dire “si è conciato bene” poteva, in passato, significare che una persona si era sistemata con cura, si era acconciata in modo appropriato. Da qui derivano i sinonimi positivi del verbo: acconciare, accomodare, rattoppare, aggiustare. Tutti rimandano a un gesto di cura, di riparazione, di miglioramento.
Eppure, nella stessa lingua, “conciare” ha finito per significare anche l’esatto contrario. Oggi, se diciamo che qualcuno “è conciato male”, intendiamo che è ridotto male, malmesso, rovinato, tanto nell’aspetto fisico quanto in senso più figurato. L’espressione “essere conciato per le feste” è un modo ironico per dire che qualcuno è ridotto in pessime condizioni, magari dopo una disavventura, una malattia o una caduta. Così, “conciare” può voler dire maltrattare, sciupare, danneggiare, deteriorare. La parola che nasceva come gesto di lavorazione e miglioramento finisce per evocare la rovina, la sporcizia, la disgregazione.
Come spiegare questa doppia direzione di senso? L’enantiosemia nasce spesso da slittamenti d’uso, da sfumature ironiche o metaforiche che nel tempo prendono piede. “Conciare” appartiene proprio a questo tipo di evoluzione. Nel caso delle pelli, infatti, la “concia” comporta un processo di trasformazione violenta: la pelle grezza viene sottoposta a sostanze chimiche, trattata, lavorata fino a diventare un materiale nuovo. È dunque un’operazione che implica insieme cura e violenza, costruzione e distruzione. Il linguaggio comune ha colto questa ambiguità e l’ha estesa alla sfera umana: chi è “conciato male” è come una pelle trattata male, lavorata troppo o in modo sbagliato, mentre chi “si è conciato bene” è il risultato di una lavorazione riuscita, di una sistemazione armoniosa.
Non è raro che la lingua, con la sua sapienza istintiva, colga questa dialettica tra opposti. Anche in altri verbi italiani si osservano fenomeni simili. Pensiamo a “tirare su” (che può voler dire incoraggiare o, al contrario, vomitare), o a “lasciare” (che può significare abbandonare o concedere). “Conciare” si colloca in questa famiglia di parole “bivalenti”, che non si limitano a designare un’azione, ma racchiudono in sé una storia culturale, una visione del mondo.
Interessante è anche la sfumatura legata al significato di “sporcare” o “insudiciare”. Dire che qualcuno è “conciato” può evocare un’immagine visiva di disordine, di sporcizia, di goffaggine. Eppure, anche in questo senso apparentemente negativo, si nasconde una vena di ironia e di affetto. È una parola che, nel parlato, spesso serve a sdrammatizzare: “Guarda come ti sei conciato!” non è un rimprovero severo, ma un commento bonario, familiare, che esprime una mescolanza di rimprovero e tenerezza.
La ricchezza del verbo “conciare” sta dunque nella sua capacità di oscillare tra poli opposti: la cura e il danno, l’ordine e il disordine, la bellezza e la deformità. È una parola viva perché descrive l’esperienza umana nella sua interezza, nella sua imperfezione. Ogni volta che “conciamo” qualcosa — che sia un oggetto, un vestito, una pelle o noi stessi — compiamo un atto di trasformazione, e ogni trasformazione comporta inevitabilmente una perdita e un guadagno.
L’enantiosemia segna l’evoluzione della lingua
Dal punto di vista linguistico, “conciare” mostra come le parole non siano entità fisse, ma organismi in movimento, che assorbono i sensi della vita quotidiana, le abitudini, le ironie e le contraddizioni dei parlanti. È il popolo della lingua — non i grammatici — a decidere che “conciare” possa voler dire tanto “rattoppare” quanto “rovinare”. È la realtà che cambia significato alle parole, e la lingua, come un organismo sensibile, registra questi mutamenti.
Così, il verbo “conciare” ci insegna che la lingua italiana non è solo uno strumento di comunicazione, ma una forma di pensiero vivente, capace di accogliere il paradosso e di trasformarlo in significato. In esso convivono l’artigiano che ripara e il destino che consuma, la mano che aggiusta e quella che sciupa. Forse proprio per questo, il suo suono conserva una verità antica: che ogni cura, ogni aggiustamento, ogni tentativo di ordine porta sempre con sé una traccia di disordine — e viceversa.