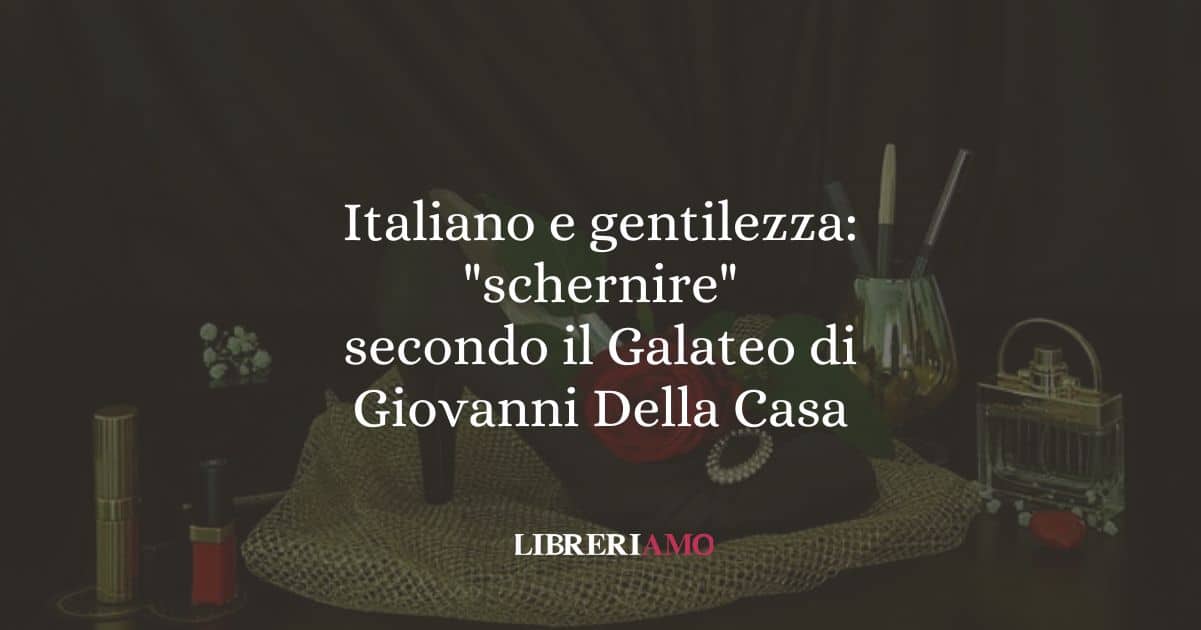Nel “Galateo”, scritto da Giovanni Della Casa nel XVI secolo, galateo italiano di maggior successo, la riflessione sul comportamento umano si eleva ben oltre la semplice codifica di regole di cortesia: diventa un’indagine morale, una forma di educazione dell’anima. Tra i molti passaggi dedicati al vivere civile e al decoro delle parole, spicca la riflessione sullo scherno, che Della Casa considera uno dei gesti più vili e disonorevoli. Il passo in cui afferma che “schernire non si dee mai persona quantunque inimica, perché maggior segno di dispregio pare che si faccia schernendo che ingiuriando” racchiude una concezione profonda del linguaggio e del rispetto umano: il riso, quando diventa derisione, smette di essere gioia e si trasforma in crudeltà.
Schernire non si dee mai persona quantunque inimica, perché maggior segno di dispregio pare che si faccia schernendo che ingiuriando. Conciosiaché le ingiurie si fanno o per istizza o per alcuna cupidità; e niuno è che si adiri con cosa o per cosa che egli abbia per niente o che appetisca quello che egli sprezza del tutto; sì che dello ingiuriato si fa alcuna stima, e dello schernito niuna o picciolissima. Ed è lo scherno un prendere la vergogna che noi facciamo altrui a diletto senza pro alcuno di noi.
Per la qual cosa si vuole nella usanza astenersi di schernire nessuno: in che male fanno quelli che rimproverano i difetti della persona a coloro che gli hanno, o con parole, come fece Messer Forese da Rabatta delle fattezze di Maestro Giotto ridendosi, o con atti, come molti usano, contrafacendo gli scilinguati o zoppi o qualche gobbo. Similmente chi si ride d’alcuno sformato o malfatto o sparuto o picciolo, o di sciocchezza che altri dica, fa la festa e le risa grandi; e chi si diletta di fare arrossire altrui: i quali dispettosi modi sono meritatamente odiati.
Italiano e galateo
Giovanni Della Casa distingue con finezza tra l’ingiuria e lo scherno. L’ingiuria, egli scrive, nasce da istinto o da cupidità, cioè da passioni umane comprensibili, per quanto condannabili: la rabbia, la vendetta, il desiderio di affermare sé stessi. Lo scherno invece è un atto gratuito, che non nasce da una causa reale, ma dal piacere maligno di umiliare.
Chi ingiuria, riconosce almeno all’altro una qualche dignità: lo ritiene avversario degno di reazione, o persona che, in un modo o nell’altro, può nuocere o influire. Chi schernisce, invece, nega all’altro ogni valore, lo riduce a oggetto di riso, a figura deformata e impotente. Per questo Della Casa osserva che “dello ingiuriato si fa alcuna stima, e dello schernito niuna o picciolissima”.
È una distinzione sottilissima ma di grande modernità. Lo scherno, a differenza dell’offesa diretta, è un atto di disumanizzazione: riduce la persona a caricatura, la espone al ludibrio e cancella la possibilità di risposta. L’ingiuria chiama ancora al confronto; lo scherno nega la pari dignità. In questo senso, Della Casa anticipa quella sensibilità etica che riconosce nel linguaggio un potere di ferire tanto quanto un’arma.
Il riso crudele e la perdita della misura
La critica dello scherno è anche una critica della risata crudele, della tendenza umana a divertirsi dei difetti altrui. Della Casa cita l’esempio di Messer Forese da Rabatta, che si burlava delle fattezze di Giotto, e più in generale condanna chi “si ride d’alcuno sformato o malfatto o sparuto o picciolo, o di sciocchezza che altri dica”.
In questo elenco, che abbraccia tanto le imperfezioni fisiche quanto quelle intellettuali, emerge un tratto fondamentale della morale rinascimentale dell’autore: il vero gentiluomo non è colui che si mostra brillante o arguto a spese degli altri, ma chi sa contenere la propria lingua e dominare il proprio riso.
Il “Galateo” nasce infatti come trattato sull’arte della misura. Nella società di corte del Cinquecento, la parola era strumento di distinzione sociale, ma anche possibile fonte di disonore. Sapere quando tacere, come ridere, come rispondere, significava preservare la propria dignità e quella altrui. Schernire, invece, rompeva l’equilibrio del convivere, perché trasformava la conversazione in una scena di sopraffazione.
Non è un caso che Della Casa parli di chi “si diletta di fare arrossire altrui”: il piacere nel mettere in imbarazzo, nel rendere visibile la vergogna dell’altro, è per lui un segno di cattiva educazione, ma soprattutto di malvagità morale. Il riso, se nasce dal dolore di un altro, perde ogni grazia e diventa un segno di bassezza d’animo.
Schernire come negazione dell’umanità
Il linguaggio di Della Casa è preciso e incisivo: “lo scherno è un prendere la vergogna che noi facciamo altrui a diletto senza pro alcuno di noi”. In questa frase si rivela tutta la condanna etica dell’autore.
Lo scherno, infatti, non produce nessun vantaggio, né pratico né morale: non serve a difendersi, non corregge un torto, non costruisce nulla. È una crudeltà fine a sé stessa, un piacere perverso tratto dal male altrui. Per questo è peggiore dell’ingiuria, che almeno nasce da un motivo. Schernire è un modo per sentirsi superiori, per cancellare l’altro attraverso la risata.
Nell’analisi di Della Casa si intuisce una concezione umanistica della parola: essa deve servire alla convivenza, non alla distruzione. Parlare bene non è solo questione di forma, ma di etica del rispetto. Chi usa la parola per umiliare, tradisce la sua funzione più alta: quella di mezzo di comunione tra gli uomini.
Attualità di una riflessione rinascimentale
La riflessione sullo scherno nel “Galateo” conserva una straordinaria attualità. Oggi, in un’epoca segnata dai social media e dal linguaggio pubblico spesso aggressivo, lo scherno è diventato forma quotidiana di interazione: si ride di tutto e di tutti, si ironizza per sentirsi parte di un gruppo, si trasforma l’umiliazione altrui in spettacolo.
Della Casa ci ricorda che deridere non è mai innocente: anche se mascherato da ironia o umorismo, lo scherno nasce da disprezzo, e il disprezzo è sempre un modo di negare l’umanità dell’altro.
Nel suo tempo, l’autore intendeva educare i cortigiani alla grazia e al decoro; nel nostro, la sua lezione si trasforma in un invito alla responsabilità della parola. Ridere sì, ma senza disprezzo; parlare, ma senza ferire; usare la lingua come strumento di civiltà, non come arma di offesa.