Italiano: l’inconsistenza della parola “slacktivismo”. Cioè?
Scopriamo il significato del termine “slacktivism”, entrato nel vocabolario italiano come “slacktivismo” e perché la realtà giovanile lo smentisce.
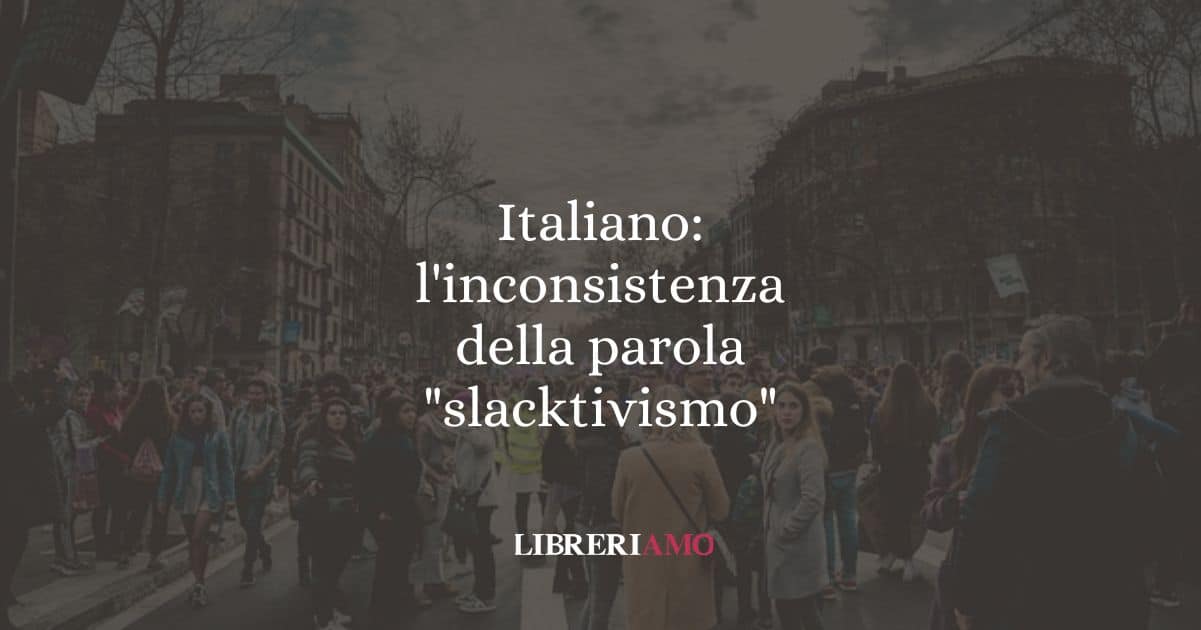
Il termine italiano slacktivismo (dall’inglese slacktivism, composto da slacker, “pigro”, e activism, “attivismo”) nasce con una connotazione ironica e negativa: indica una forma di impegno civile o politico che richiede uno sforzo minimo, spesso limitato a un “like” su un post, a una condivisione su un social network o alla firma di una petizione online. Un attivismo, insomma, giudicato superficiale, fiacco, incapace di incidere realmente sulla società.
Eppure, questa definizione appare sempre più riduttiva e incapace di cogliere la complessità del fenomeno. Negli ultimi anni, proprio attraverso i social media, sono nate e cresciute mobilitazioni di portata mondiale che hanno dimostrato come il cosiddetto slacktivismo non sia affatto un sinonimo di disimpegno, ma al contrario una nuova forma di partecipazione politica e sociale, soprattutto per le giovani generazioni.
La nascita del termine e l’introduzione nel lessico italiano
L’uso del termine slacktivism si afferma nei primi anni Duemila, in un contesto in cui i social network cominciavano a diffondersi come strumenti di comunicazione di massa. La critica era semplice: cliccare un “mi piace” o condividere un contenuto non equivale a scendere in piazza, a organizzare un corteo o a dedicare tempo e risorse a una causa. Il rischio percepito era quello di trasformare l’impegno civile in un gesto di facciata, privo di conseguenze concrete.
Molti osservatori, soprattutto nelle generazioni meno avvezze ai social, hanno visto nello slacktivismo la prova del disinteresse dei giovani per la politica, del loro rifugiarsi in una partecipazione comoda e virtuale. Una forma di coscienza lavata a buon mercato, incapace di incidere davvero sulla realtà.
Dal virtuale al reale: le nuove piazze
Questa visione, tuttavia, si è rivelata parziale. I social network, infatti, non sono spazi isolati dal mondo reale, ma strumenti che connettono, informano e mobilitano. Un hashtag può diventare il punto di partenza di una manifestazione globale, un video virale può denunciare un’ingiustizia e costringere istituzioni e governi a intervenire, una campagna online può raccogliere fondi per emergenze umanitarie con rapidità ed efficacia.
Un esempio emblematico è quello del movimento Fridays for Future, nato dai post di Greta Thunberg e diffusosi grazie alla condivisione online di immagini, slogan e appuntamenti di protesta. In poche settimane, milioni di giovani hanno riempito le piazze di tutto il mondo per chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico. Se il gesto iniziale poteva sembrare un atto di “slacktivismo”, il risultato è stato una mobilitazione reale, capace di portare il tema ambientale al centro dell’agenda politica internazionale.
Lo stesso vale per il movimento Black Lives Matter, esploso dopo l’uccisione di George Floyd nel 2020. I social hanno amplificato il messaggio, diffuso testimonianze e organizzato cortei in decine di Paesi, dimostrando che il confine tra attivismo digitale e attivismo “sul campo” è sempre più sottile.
Giovani e politica: un impegno che cambia forma
L’idea che i giovani siano disinteressati alla politica è ormai superata. Piuttosto, il loro modo di fare politica è diverso da quello delle generazioni precedenti: meno legato ai partiti, più fluido, più attento ai temi concreti come l’ambiente, l’uguaglianza di genere, i diritti civili.
I social network diventano così strumenti privilegiati per informarsi e mobilitarsi, perché consentono un accesso immediato alle notizie, un confronto costante e la possibilità di esprimere opinioni e organizzare azioni collettive. Certo, non tutti i gesti online hanno la stessa forza: condividere un post non equivale a cambiare una legge. Ma sottovalutare l’impatto del digitale significa non riconoscere che molte lotte contemporanee hanno preso forma proprio grazie alla rete.
Il cosiddetto slacktivismo, quindi, non va liquidato come attivismo “fiacco”: spesso è il primo passo verso un impegno più concreto. Un like può sembrare insignificante, ma può contribuire a diffondere un messaggio, a far conoscere una causa, a creare un senso di appartenenza che incoraggia azioni successive.
Un altro elemento da considerare è l’efficacia del cosiddetto slacktivismo. Le campagne digitali riescono a raggiungere un pubblico vastissimo in tempi rapidissimi, cosa che difficilmente potrebbe avvenire con i soli strumenti tradizionali. Inoltre, i social permettono di bypassare i canali ufficiali di informazione, dando voce a chi spesso non l’ha avuta.
Pensiamo alle petizioni online, che hanno contribuito a cambiare politiche aziendali, a fermare progetti dannosi per l’ambiente o a spingere i governi a occuparsi di questioni altrimenti trascurate. O alle raccolte fondi digitali, che hanno garantito aiuti immediati in contesti di emergenza, come guerre o catastrofi naturali.
In tutti questi casi, ciò che sembrava “attivismo minimo” si è tradotto in risultati tangibili.
Il termine slacktivismo nasce per criticare un impegno giudicato pigro e superficiale. Ma la realtà dimostra che anche un semplice gesto online può essere l’inizio di un processo più ampio e incisivo. I giovani, lungi dall’essere disinteressati alla politica, utilizzano i mezzi che hanno a disposizione per far sentire la propria voce.
I social network non sostituiscono le piazze, ma le alimentano; non rimpiazzano la partecipazione, ma la rendono più capillare e inclusiva. In questo senso, parlare di slacktivismo come attivismo fiacco significa non riconoscere la trasformazione che la politica sta vivendo nell’era digitale.
Forse, più che di slacktivismo, dovremmo parlare di un nuovo attivismo, capace di fondere il potere simbolico e comunicativo del digitale con la concretezza dell’azione collettiva. Un attivismo che, come dimostrano i giovani di oggi, è tutt’altro che pigro: è vivo, creativo e determinato a cambiare il mondo.