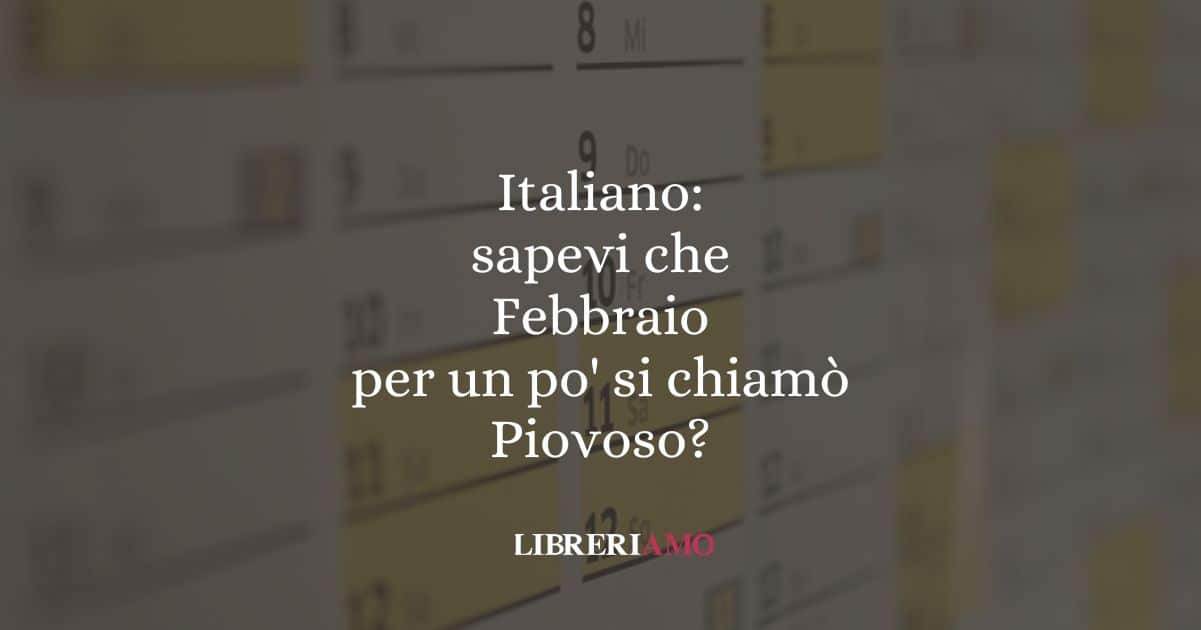Cominciamo il nostro viaggio tra italiano e storia: tra i tanti segni simbolici che accompagnarono la breve e drammatica esperienza della Repubblica napoletana del 1799, ve n’è uno particolarmente suggestivo e poco ricordato: il cambiamento del calendario. Nel gennaio di quell’anno, con l’ingresso delle truppe francesi guidate dal generale Jean Étienne Championnet e la proclamazione della Repubblica, anche a Napoli si adottò il calendario rivoluzionario francese. Così, il tradizionale mese di febbraio non esistette più: esso si trasformò in “piovoso”, quinto mese del nuovo sistema, corrispondente grosso modo al periodo che andava dal 20 gennaio al 18 febbraio del calendario gregoriano.
Italiano e nuovo calendario
L’uso di un calendario diverso non fu un semplice dettaglio burocratico. Significava abbandonare un sistema millenario, fondato sulla tradizione cristiana e sul culto dei santi, per sostituirlo con un tempo laico, regolato dai cicli naturali e dalla nuova visione del mondo inaugurata dalla Rivoluzione francese. “Piovoso” era il mese invernale in cui le piogge segnavano il ritmo della natura, secondo quella logica agricola e razionale che ispirava il calendario rivoluzionario. Non più nomi di divinità o reminiscenze latine, ma fenomeni naturali, elementi della vita quotidiana, simboli del rapporto diretto tra uomo e ambiente.
L’adozione del “mese piovoso” a Napoli rappresentò dunque una rottura con il passato, un gesto che accompagnava il proclama solenne con cui Championnet, il 4 piovoso dell’anno VII (23 gennaio 1799), annunciava ai napoletani la nascita della nuova Repubblica: «Siete finalmente liberi! La vostra libertà è il solo prezzo che la Francia vuol ritrarne dalla sua conquista». Quel linguaggio solenne e rivoluzionario, che riecheggiava le dichiarazioni dei giacobini francesi, si innestava in una realtà molto diversa, segnata da profonde divisioni sociali, da un analfabetismo diffuso e da un popolo che poco comprendeva le idealità filosofiche dei nuovi governanti.
Tuttavia, per gli intellettuali e i patrioti napoletani, l’introduzione del nuovo calendario fu un simbolo di emancipazione. Era la dimostrazione che Napoli non apparteneva più al mondo feudale dei Borbone, ma si collocava in quel circuito europeo che parlava il linguaggio dei diritti, della libertà e dell’uguaglianza. Avvocati, medici, giovani nobili di seconda fila, ecclesiastici ribelli alle gerarchie: essi videro nel “mese piovoso” un segno tangibile della trasformazione in corso. Anche il giornale ufficiale della Repubblica, il Monitore Napoletano, diretto da Eleonora de Fonseca Pimentel, adottò le nuove denominazioni dei mesi, contribuendo a diffondere questa novità simbolica tra i lettori.
Ma il cambiamento del calendario mostrò anche i limiti della rivoluzione partenopea. Per la maggioranza della popolazione, il “mese piovoso” era un concetto estraneo, lontano dal modo tradizionale di scandire la vita con le feste religiose, i santi patroni, le ricorrenze legate alla Chiesa. Per i lazzari, i facchini, i pescatori che si ribellarono all’arrivo dei francesi, quella novità appariva incomprensibile, quasi un’imposizione estranea alla loro cultura.
Per loro, la libertà non si misurava con i proclami o con la sostituzione di “febbraio” con “piovoso”, ma con la possibilità concreta di sopravvivere, di lavorare, di difendere le proprie famiglie. Non a caso, le insurrezioni popolari contro i francesi furono alimentate anche dal senso di distacco tra le élite giacobine e il resto della popolazione.
Repubblica napoletana e Francia
Eppure, nel suo breve arco di vita, la Repubblica napoletana tentò di rendere concreto quel linguaggio simbolico. La sostituzione del mese di febbraio con “piovoso” non fu un atto isolato: si accompagnò a una serie di riforme che cercavano di tradurre in pratica i principi della Rivoluzione francese. Furono aboliti i privilegi nobiliari, eliminata la feudalità, riformato l’ordinamento giudiziario, e furono poste le basi di una nuova costituzione. Tutto questo, però, non bastò a salvare l’esperimento repubblicano, che dopo appena cinque mesi e venti giorni sarebbe crollato sotto l’avanzata delle armate sanfediste guidate dal cardinale Ruffo.
La memoria del “mese piovoso” resta dunque legata a quell’attimo fugace in cui Napoli si volle europea e rivoluzionaria. È un ricordo che ci parla non solo di politica e di guerre civili, ma anche di come i simboli, persino quelli apparentemente minimi come un nome di mese, possano esprimere profonde trasformazioni storiche. Quando, con la restaurazione borbonica, si tornò al vecchio calendario, si tornò anche a un ordine sociale tradizionale, fatto di re, santi e sudditi. Ma per chi visse quei giorni, il “mese piovoso” rimase per sempre il segno che, almeno per un momento, Napoli aveva provato a respirare il vento nuovo della libertà.